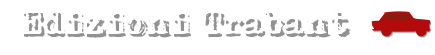Prefazione a
Sul campo di Adua – Eduardo Ximenes
Non ricordo chi ironizzava sul fatto che, per mancanza di un numero sufficiente di vittorie, la toponomastica italiana si è dovuta adattare a un abbondante utilizzo di battaglie perdute. Siamo dunque abituati a frequentare luoghi dai nomi come via Caporetto, via Lissa, piazza El Alamein, via dell’Amba Alagi e, qua e là, una via, viale, piazza Macallè. D’altra parte, lo spirito italico – quanto a chiacchiere, secondo a nessuno – ha spesso trovato il modo di rigirare a proprio favore, nella retorica nazionale, gli insuccessi militari. E così imbarazzanti disfatte, pietose ritirate, figure meschine contro avversari non sempre superiori sono state ben volentieri convertite in “onorevole sconfitta”, “eroica resistenza”, “resa con l’onore delle armi”. Significativa, ad esempio, è la lapide commemorativa posta in Egitto sul luogo in cui si combatté la battaglia di El Alamein. “Mancò la fortuna, non il valore” recita l’iscrizione. Senza nulla togliere alla memoria dei caduti, varrebbe la pena sottolineare che in verità non mancarono né la fortuna, né il valore; a mancare furono semmai logistica, rifornimenti, carri armati. Ma a noi, per assolverci, piace pensare che questi siano dettagli, e che l’estro del momento, l’idea suggerita dal genio innato, in una parola l’improvvisazione possa, se ben assistita dalla buona sorte, sopperire all’equipaggiamento e alla pianificazione.
Sono considerazioni da affidare più al sociologo che allo storico. E tuttavia, continuando in questa speculazione alla buona, è evidente come una tale opera di rimozione abbia lo scopo di nascondere quanto brucino le sconfitte nell’inconscio collettivo. Bruciano, sì. Da una certa ottica, l’italiano medio porta con sé l’eredità di una lunghissima serie di umiliazioni militari. E ciò fa male tanto più in relazione all’istintivo senso di superiorità che l’italiano prova nei confronti degli avversari che hanno prevalso: siano essi contadini greci o partigiani albanesi, decadenti soldati anglosassoni o guerriglieri africani. La parabola media di una missione militare italiana consiste in un’allegra partenza nella convinzione di schiacciare con poca fatica un nemico notevolmente inferiore – d’altra parte, chi potrebbe ritenersi superiore ai discendenti dei legionari romani? – e una successiva ritirata dopo che il nemico inferiore si è rivelato, nei fatti, più equipaggiato, più scaltro, più motivato.
La battaglia di Adua è forse, da questo punto di vista, uno dei migliori esempi. Il 1° marzo 1896 rappresenta uno shock collettivo da cui il paese si è ripreso a fatica e con conseguenze, alla lunga, nefaste. Troppo pesante venire a sapere che la nuova Italia, finalmente unita, libera e sulla via del progresso, potesse essere sopraffatta da truppe di nativi africani o, come più volte li aveva chiamati nei suoi discorsi il presidente Crispi, “quattro predoni barbari”.
UNA CATASTROFE ANNUNCIATA
Eppure le premesse erano tutt’altro che incoraggianti: come spesso ci capita, troppi elementi avevano fatto qua e là sfociare la storia nella farsa. Già che il neonato Regno, sorto dalla retorica della liberazione nazionale dal giogo straniero, varcasse il Mediterraneo per cercare territori da assoggettare in Africa, ledendo quindi l’indipendenza nazionale altrui, era cosa da suscitare a essere benevoli un risolino di compassione; che ciò avvenisse proprio sotto il governo della Sinistra erede dei movimenti risorgimentali, per mano di un eroe garibaldino come Francesco Crispi, questo era il colmo. Eppure andò proprio in questo modo: negli anni ‘80 del XIX secolo l’Italia avviava la propria politica coloniale, spinta da un misto di ambizione e complesso di inferiorità nei confronti delle potenze europee, il tutto condito dalla solita giustificazione sulla missione civilizzatrice degli Europei nei confronti dei selvaggi. Come al solito, però, il nostro paese arrivava per ultimo, quando già Inghilterra e Francia si erano spartite la maggior parte del bottino. Unico, restava indipendente il Corno d’Africa e fu dunque lì che i nostri governanti puntarono il dito sulla cartina: il Regno avrebbe cercato la propria parte in Africa Orientale, sulle rive del Mar Rosso. Pochi parevano però essersi chiesti per quale motivo quell’angolo di mondo fosse ancora indipendente e sovrano.
La risposta, a non avere paraocchi, era piuttosto semplice: la regione era una delle poche nel Continente Nero ad avere una struttura statale forte e riconoscibile, dotata di un esercito organizzato e in qualche misura ammodernato: il secolare Impero Etiope fondato nel XIII secolo da una dinastia che amava farsi credere discendente nientedimeno che del Re Salomone. Un regno che, per quanto ancora basato su strutture feudali, nonostante fosse cronicamente afflitto da lotte intestine per il predominio, aveva però dimostrato di saper trovare unità di intenti quando si trattava di fronteggiare una minaccia esterna. Così, quando l’Italia iniziò ad acquisire territori sulla costa, dalla baia di Assab al porto di Massaua, fino alla città di Asmara, fondando in questo modo la Colonia Eritrea, inevitabile si pose il problema di definire i rapporti con l’Impero confinante. La soluzione, a voler dar credito agli aspetti leggendari della vicenda, fu una tipica furbata all’italiana: la truffa.
Nel 1889 il conte Pietro Antonelli, ambasciatore d’Italia in Etiopia, firmava per nome del re Umberto I un accordo con l’imperatore Menelik II, passato alla storia come il Trattato di Uccialli. Molto si è scritto a proposito di tale documento e sulle intenzioni con cui fu redatto. Resta un dato di fatto: la versione in lingua italiana e quella in lingua amarica differivano in pochi, essenziali dettagli. Famigerato è soprattutto l’articolo 17, che in italiano recitava:
Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.
mentre in amarico:
Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia ha la possibilità di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.
Sottigliezze? Non proprio, perché per gli Etiopi significava la libertà di richiedere l’aiuto dell’Italia nelle faccende di politica estera, mentre per gli Italiani era il divieto assoluto agli Etiopi di contrarre alleanza con chicchessia senza la loro mediazione: in poche parole, un vero e proprio protettorato. La versione più benevola attribuisce il doppio testo a un errore di traduzione; una vulgata molto diffusa, però, sospetta un tentativo di frode ai danni degli etiopici, tramite il quale la piccola Italia poteva vantarsi nel mondo di avere espanso i confini a buon mercato, sfruttando la propria innata furbizia a danno di un branco di ingenui barbari. Ma il diavolo – si sa – non fa coperchi.
E così fu. Quando l’Italia protestò contro il tentativo di Menelik di stringere trattati con la Francia e la Russia, il negus semplicemente stracciò il Trattato di Uccialli: ci si incamminava verso la guerra. Nel 1895 le truppe al comando del generale Oreste Baratieri sconfinavano in territorio etiope occupando la regione del Trigré.
Baratieri era destinato a diventare l’uomo-simbolo della successiva catastrofe, raccogliendo in sé tutte le contraddizioni della storia che raccontiamo e assumendosi, in fin dei conti, il ruolo del capro espiatorio. Era innanzitutto un ex garibaldino, e di lungo corso. Unitosi al Generale sin dalla prima ora, aveva seguito i Mille fino alla battaglia di Capua. E con le camicie rosse era rimasto anche dopo l’Unità, partecipando, per esempio, alla disfatta di Mentana. Solo in seguito era entrato nel Regio Esercito, guardato dai veterani col sospetto da sempre riservato ai parvenu garibaldini e al loro grado conquistato sul campo e non in Accademia. A onor del vero, il sospetto non era del tutto immeritato: egli condivideva con Crispi e con la maggior parte dei reduci dell’impresa risorgimentale la tendenza a dare scarsa importanza a fattori come organizzazione logistica, preparazione teorica, studio del territorio e dell’avversario, nella convinzione che al momento buono sarebbe bastato inastare la baionetta e attaccare a testa bassa, alla garibaldina appunto, e conseguire con l’ardimento risultati migliori di quelli che si sarebbero potuti raggiungere con la competenza.
Al di là delle sue personali responsabilità, bisogna dire che al generale non ne andò bene una. Se l’occupazione del Trigré poté sembrare inizialmente rapida e indolore, la controffensiva nemica rese le divisioni italiane simili al classico topo finito nel formaggio: gli Etiopi si dimostrarono presto più numerosi, meglio equipaggiati e più preparati strategicamente del previsto. Mentre Baratieri invano invocava l’invio di rinforzi, nel dicembre 1895 circa 2000 soldati guidati dal maggiore Toselli erano circondati e uccisi sul colle dell’Amba Alagi; nel gennaio 1896 cadeva dopo un breve assedio la fortezza di Macallè; l’esercito etiope dilagava fino a minacciare la stessa Colonia Eritrea, mentre gli italiani ripiegavano su posizioni difensive. Nel mentre, a Roma ci si perdeva in chiacchiere e questioni secondarie: l’onore nazionale, il prestigio in pericolo, le possibili ripercussioni sul risultato delle imminenti elezioni. Crispi stabilì di rimuovere il vecchio compagno d’arme garibaldino con il più esperto Antonio Baldissera e lo inviava in Eritrea; in attesa dell’avvicendamento, però, metteva pressione su Baratieri perché affrontasse la situazione più di petto. Celebre è il telegramma che gli scrisse nel febbraio ‘96, rimproverandolo aspramente: “Codesta è una tisi militare, non una guerra”.
Baratieri, valutando le forze in campo, avrebbe preferito ripiegare su posizioni più sicure. Tutti però lo spingevano ad attaccare: il governo, l’opinione pubblica, i generali del suo Stato Maggiore, ancora convinti, dopo due mesi di campagna, che sarebbero stati sufficienti un paio di colpi di cannone per mettere in fuga il nemico. Il generale si piegò così ad avanzare verso la conca di Adua, dove lo aspettavano forze etiopi dieci volte più numerose. Era il 1° marzo 1896: circa 15.000 italiani, male equipaggiati, con una scarsa conoscenza del territorio, inferiori di numero e per giunta mal schierati sul campo, erano travolti da 150.000 soldati delle varie tribù locali. Fu un massacro, il numero dei morti stimato sui 6000, quasi 3000 i prigionieri.
Nell’ottobre successivo l’Italia si piegava a firmare il trattato di Addis-Abeba, con il quale rinunciava a qualunque pretesa sull’Etiopia in cambio del riconoscimento della Colonia Eritrea. Baratieri, scampato per un pelo alla morte, era sottoposto a un umiliante processo davanti alla Corte Marziale; e si vocifera che avesse scambiato la sua assoluzione per il silenzio sulle responsabilità dei suoi superiori militari e politici.
VERSO IL CAMPO DELLA MORTE
È qui che prende inizio la storia raccontata in questo libro. La quale non è la narrazione della battaglia di Adua (per quanto ne contenga uno dei primi tentativi di ricostruzione), ma il diario di un viaggio a ritroso sulle orme della ritirata italiana.
Sin dagli albori della penetrazione italiana in Africa, l’argomento era divenuto motivo di interesse per la stampa, non soltanto dal punto di vista politico ma anche della semplice cronaca. L’impresa evocava affascinanti avventure in scenari esotici abitati da popolazioni lontane e dai bizzarri costumi; se a ciò si aggiunge il proliferare dei primi periodici illustrati e il perfezionamento della tecnica fotografica, si comprende bene come fosse interesse di qualunque direttore di testata inviare oltremare un giornalista-illustratore. Nascevano, in sostanza, i reportage di guerra e quello che leggiamo è una delle prime testimonianze del genere.
Siamo dunque nel maggio del 1896: ad appena due mesi dalla disfatta, Eduardo Ximenes, del periodo L’Illustrazione Italiana edito dai Fratelli Treves, si unisce a una spedizione militare il cui compito, in base ad accordi presi con i vincitori, è quello di dare sepoltura ai caduti italiani ad Adua. Una missione tutt’altro che semplice, sicuramente poco piacevole: si tratta di compiere all’inverso il percorso delle truppe sconfitte, portare soccorso ai superstiti – alcuni ancora sotto assedio da parte degli uomini di Menelik – e infine giungere al campo della battaglia, nel pieno del territorio di un nemico vittorioso. L’autore assolve con diligenza il suo compito di cronista e di illustratore, lasciandoci così una testimonianza di eccezionale interesse: via via che si addentra nel cuore del continente, annota le sue osservazioni di curioso, ascolta e riporta le voci dei personaggi che incontra, i loro aneddoti, i loro commenti, e per di più ce ne lascia un ricordo visivo, fermandosi a ritrarre volti e paesaggi. Ma il valore dell’opera non si ferma al puro aspetto descrittivo: essa va interpretata, bisogna saper leggere tra le righe anche ciò che l’autore dice senza volerlo dire.
Sgomberiamo subito il campo da un possibile equivoco: per quanto all’epoca l’Italia fosse attraversata da una forte corrente di pensiero anti-colonialista (soprattutto negli ambienti repubblicani e socialisti) e nonostante ci fossero anche alcuni inviati in Africa animati da spirito critico nei confronti della politica del nostro governo, Ximenes non appartiene ad alcuna di queste categorie. È, al contrario, quello che si definirebbe un buon patriota: vuoi per convinzione, vuoi per linea editoriale, si dimostra sin dalle prime battute assolutamente convinto della liceità della nostra missione: il compito che si assume pare anzi essere quello di rassicurare il lettore, convincendolo che Adua sia stato solamente un incidente di percorso, al quale seguirà presto il riscatto dell’onore nazionale. Eppure proprio per questa ragione il suo racconto assume interesse: rivelando anche con una certa ingenuità il suo punto di vista su ciò che osserva, Ximenes fa un po’ da cartina al tornasole, permettendoci di studiare da un punto di vista ravvicinato l’atteggiamento mentale di molti suoi contemporanei. Quasi senza rendersene conto e sicuramente al di là delle sue intenzioni, ci descrive tutta la prepotenza, l’insensatezza, in una parola lo squallore del colonialismo europeo in Africa.
Il suo diario di viaggio è, per forza di cose, segnato a ogni pagina da immagini di morte e distruzione. Nei primi spostamenti non fa che incontrare reduci della battaglia, persone ferite, bendate, in convalescenza. Al di là dei suoi compatrioti, l’immagine più cruda è quella dei soldati delle truppe ascare mutilati di una mano e un piede: dopo la sconfitta, questa è stata la punizione loro inflitta dagli etiopici per aver collaborato con l’invasore straniero. Man mano che il viaggio prosegue, poi, ciò con cui si confronta sono popolazioni ostili, soldati italiani sotto assedio, racconti di prigionieri maltrattati. Si tratta, in definitiva, di un panorama cupo, che incrudelisce quanto più i viaggiatori si avvicinano al campo della battaglia, disseminato di spoglie umane e dei resti dei loro oggetti, divise a brandelli, lettere mai inviate. Potrebbe essere quasi la discesa in un inferno dantesco africano; eppure, da buon patriota, il nostro testimone si sforza di mantenere addirittura un atteggiamento di ottimismo. Parrebbe quasi, alle volte, che a vincere ad Adua siano stati gli italiani e non gli etiopici; e anche quando racconta gli episodi della disfatta, riesce a sfoggiare la ben nota abilità italica nel rigirare la frittata, sfoderando una sequela di eroismi e frasi storiche degne delle Termopili.
In tutto questo, Ximenes fa tutto tranne che porsi le domande fondamentali. Non un dubbio lo sfiora sulla moralità del contegno dei suoi conterranei, non si ferma mai a chiedersi perché gli italiani siano lì e a quale scopo, né arriva a pensare che magari la ragione stia dalla parte degli autoctoni, impegnati in nient’altro che combattere un invasore straniero. Sconcertante è, per esempio, l’impassibilità con cui, giunto ad Adi-Cajè, descrive i metodi adottati dagli ufficiali italiani per reprimere quella che oggi chiameremmo la resistenza passiva degli abissini (pag. 63 e seguenti). I locali, infatti, hanno la buona abitudine di sabotare gli italiani rompendo, di notte, i fili del telegrafo. Per tutta risposta, i padroni bianchi fermano dei sospetti e, se le risposte fornite durante l’interrogatorio non li soddisfano, li sottopongono alla fustigazione pubblica. Ximenes assiste ad una di queste punizioni esemplari e, lungi dal provare alcun sentimento, se non d’indignazione, almeno di pietà, non trova di meglio che stupirsi della resistenza fisica di questi africani: un bianco – osserva – non avrebbe resistito a un paio di quei colpi di pelle di ippopotamo. Ma neppure questo ferma gli atti di sabotaggio: allora il generale Del Mayno raduna i preti del circondario e, mentre gli si prostrano invocando giustizia, minaccia di fare incendiare i loro villaggi. Più avanti, quando è costretto ad accamparsi di notte in un villaggio abbandonato, l’inviato racconta con un misto di stupore e riprovazione, quasi si fosse trattato di una forma di tradimento, che gli abitanti avevano aperto il fuoco sulle truppe italiane in ritirata (pag. 98). Ma l’episodio forse più significativo è quello del convento di Debra Damo (pag. 126 e seguenti), nel corso del quale troviamo gli italiani impegnati a maltrattare, minacciare e deridere, con tutto lo sprezzo possibile a chi si considera una razza superiore, i monaci di un monastero della chiesa copta, rei di nascondere dei beni depredati al Regio Esercito. Quando, però, Ximenes incontra dei soldati italiani catturati dai nemici e da poco liberati, con una stupefacente faccia tosta si sdegna a sentir loro raccontare di avere subìto delle percosse (pag. 154).
È un sistema di due pesi e due misure che può adottare inconsapevolmente solo chi sente di avere una missione civilizzatrice e scopre con delusione che la civiltà – qualunque cosa ciò significhi – ove non richiesta possa anche essere non gradita. Ximenes se ne accorge quando finalmente penetra in territorio nemico e inizia a scovare i resti dei soldati uccisi. Si lascia così andare a un’amara riflessione: « Quante guerre, quante stragi erano passate per quelle contrade! Quelle plaghe fatte deserte dallo spavento delle battaglie e delle rapine, ci avevano visto tornare indietro come scornati, impotenti a farvi regnare il lavoro e la civiltà! » (pag. 154 della versione cartacea).
Impotenti a farvi regnare il lavoro e la civiltà. C’è tutto un mondo dietro queste poche parole.
E poi ci sono le immagini. Circa 200 schizzi e fotografie accompagnano quest’opera, diario – ricordiamolo – del direttore artistico di un periodico illustrato. Sono testimonianze preziose di un luogo e di un’epoca, indispensabili per immaginare l’avvenimento in questione; a titolo di esempio, il romanziere contemporaneo Carlo Lucarelli ne ha fatto abbondante uso per scrivere un recente romanzo storico incentrato sulla battaglia di Adua. Le immagini anch’esse sono una sorta di viaggio agli inferi: iniziano con placidi panorami dell’Eritrea italiana e dei soldati sbarcati, si trasformano lungo il cammino nella rappresentazione di fortini sotto assedio, soldati feriti, ascari mutilati; nell’ultima parte, alternano ricostruzioni di vari episodi della battaglia a fotografie fatte in studio dei suoi vari caduti, quasi una inconsapevole Spoon River.
TORNEREMO?
La battaglia di Adua, come detto, ebbe una serie di conseguente nefaste. Nell’immediato innanzitutto: la caduta di Crispi, il processo a Baratieri, l’umiliazione di un intero paese a livello internazionale. Come fatto giustamente notare, si potrebbe imputare ad Adua anche altri avvenimenti di poco successivi, persino la morte di re Umberto i: l’ostilità dell’estrema sinistra nei confronti nel potere sabaudo, infatti, se aveva motivazioni di ordine sociale legate strettamente all’attualità italiana, non era però estranea al malumore suscitato, in ambienti socialisti, anarchici, repubblicani, anche dalle imprese coloniali e dal loro fallimentare esito.
Ma esiste un’altra conseguenza, forse ancora più grave, di Adua, e risiede nella frustrazione che provocò per decenni nella coscienza degli italiani, come se fosse un’onta da lavar via un giorno o l’altro. Il diario di Ximenes si conclude proprio con un giovane soldato il quale, nel lasciare le terre teatro dello scontro, si rivolge al suo superiore e gli chiede: « Signor capitano, ci torneremo, non è vero? »
Ci saremmo infatti tornati quarant’anni dopo, al seguito dell’aquila e del fascio littorio.
Ma questa è un’altra storia.
Marcello Donativi