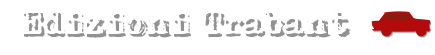Prefazione a
Il Misogallo – Vittorio Alfieri
Che accade quando uno scrittore tendenzialmente rivoluzionario assiste per davvero a una rivoluzione? La storia non manca di esempi del genere, e quasi sempre con esiti imprevedibili.
Ne abbiamo ampia prova nel secolo passato, ricco di episodi – tragici o meno – di intellettuali marxisti partiti con la luce negli occhi per Mosca e tornati chi in preda ai dubbi, chi alla depressione, chi da un giorno all’altro ferocemente antisovietico; qualcuno addirittura filonazista. Probabilmente immaginare per anni e anni un avvenimento porta a una idealizzazione facile a trasformarsi in delusione quando si incontra con la realtà; e specialmente se questa realtà è fatta di tumulto ed esecuzioni sommarie.
Il XX secolo, dicevamo; l’Urss; esiste però un esempio del genere nella nostra storia letteraria, un caso vagamente sottaciuto o affrontato malvolentieri, e per recuperarlo dobbiamo tornare indietro ai tempi della Rivoluzione Francese: Vittorio Alfieri e il Misogallo.
Il Misogallo? E che roba è?
Proviamo ad aprire un manuale scolastico e cercare traccia di questa opera. Dico un manuale scolastico, perché alla fin fine sono quelli i testi che arrivano alla gente. I battibecchi tra cattedratici non lasciano solitamente i corridoi intorno al loro ufficio, e a noi non piace parlare nei corridoi, preferiamo un bar o la soglia di un negozio.
Partiamo dal classicissimo Salinari-Ricci. Poche righe: “L’odio contro la Francia è espresso in uno strano libro, il Misogallo, misto di prosa e versi, scritto fra il 1793 e il ’99, in cui l’Alfieri manifesta spirito antilluminista, reazione alla prepotenza francese, coscienza nazionale nel suo sorgere violentemente polemica. Queste opere, storicamente interessanti, nulla aggiungono al ritratto dell’Alfieri che siamo andati configurando nelle pagine precedenti”. Un’opera antilluminista, dunque; una mera reazione alle prepotenze francesi (quindi – si può supporre – non sarebbe stata scritta se non ci fosse stato l’espansionismo rivoluzionario); e comunque si può tranquillamente ignorarla.
Via col Petronio: “il Misogallo (1793-99), misto di prose e di versi, violenta esplosione di odio contro la Francia, nel quale confluirono tanti moti dell’Alfieri (…) e che nell’Alfieri si esprimevano in modi confacenti al suo spirito, cioè in modi irosi di polemica”. Leggi: il tipo era fatto così, questa operuccia è da intendersi frutto di una incazzatura passeggera.
In tempi più recenti il Ferroni ci stupisce con un’ulteriore sintesi: “…un curioso libello antifrancese, Il Misogallo (scritto tra il 1793 e il 1798)”. Niente di più, niente di meno.
Questo è quanto è concesso sapere al lettore comune, per così dire l’uomo della strada, e il motivo si può anche facilmente ipotizzare: la pietra dello scandalo è dovuta al fatto che l’Alfieri, il tragico dei tragici, l’uomo che aveva posto lo scontro tra il cittadino e il tiranno al centro delle sue opere, il poeta considerato a posteriori tra i fondatori della Libertà Italica; ebbene, quale ultima opera da lasciare al mondo riempì pagine e pagine di sdegnose invettive contro la Rivoluzione, maledicendo i Francesi tutti e il giorno in cui si erano ribellati al Re Legittimo; e coprendo il popolo dei sanculotti di simpatiche invettive come “feccia sordida”, “turbe di macachi fastidiose”, “ventitré milioni di pidocchi”.
I professoroni, invece, nelle loro disquisizioni esoteriche, il problema se lo sono posto, ma senza arrivare a una spiegazione condivisa. Per alcuni l’Alfieri – in modo in verità non diverso da tanti suoi contemporanei – matura uno spirito conservatore con un repentino voltafaccia in tarda età (una sorta di demenza senile, insomma); per altri la spiegazione sarebbe nel proverbiale caratteraccio dell’autore; per non parlare della tesi elaborata dal Sapegno in un famoso saggio del ‘49, secondo cui Alfieri in realtà era sempre stato reazionario… senza saperlo .
Come sciogliere dunque un tale nodo, e individuare una spiegazione senza cadere in ridicole accuse di tradimento della causa?
Cerchiamo innanzitutto di ripercorrere in breve le tappe della vicenda.
Per fare questo dobbiamo tornare all’incirca all’anno 1782. A quella data Vittorio Alfieri poteva ritenere di essere al culmine, e forse al compimento, della sua carriera letteraria. Nobile di nascita, irrequieto per vocazione, l’astigiano sin da giovane offriva, oltre a una sconvolgente somiglianza con l’attore Michael Caine, un ego tendente pressocché all’infinito. Una personalità così straripante aveva bisogno di trovare soddisfazione in qualche impresa titanica; e il nostro l’aveva individuata nel farsi il Tragediografo italiano per eccellenza, supportato in ciò da un volontarismo che sarebbe divenuto leggendario (compresi miti secondo cui si faceva legare alla scrivania per non cedere alla tentazione di far altro che scrivere). La sua formazione era stata prevalentemente autonoma, frutto dell’esperienza di lunghi viaggi per tutta Europa e letture appassionate di pochi ma selezionati autori (fra tutti Plutarco e Dante), il che, non senza un accatastarsi spesso confuso di spunti e idee, lo aveva portato a una concezione del mondo in cui il Nemico dell’uomo per eccellenza è il Tiranno; e nella sua epoca costui era incarnato più che altro nel Re. L’odio per le restrizioni, i controlli polizieschi, gli abusi ma anche soltanto l’etichetta dell’Ancient Régime lo avevano spinto sulle soglie dell’odio di sé, o perlomeno della sua origine sociale; al punto che nel 1778, per beneficiare di una maggiore indipendenza come scrittore, aveva rinunciato ai suoi possedimenti feudali; il che equivaleva quasi alla rinuncia al titolo nobiliare.
Nell’82 il nostro pensava di mettere fine alla sua produzione tragica. Nel corso di meno di dieci anni aveva dato fondo a tutte le sue energie, allontanando via via la propria arte dalle influenze della scuola francese allora di moda e da lui aborrita (e questa è già una prima avvisaglia…), fino a un suo personalissimo stile, in cui ogni verso era scolpito con la forza e l’austerità di un bassorilievo di età classica: se i drammi francesi solevano avere la musicalità di un valzer, Alfieri preferiva le marce militari. E al centro degli intrecci, era quasi sempre lo scontro tra l’Eroe e il Tiranno; la lotta all’abuso di potere, il fremito di libertà e altri simili concetti altisonanti che tanta influenza avrebbero avuto sul linguaggio retorico risorgimentale, post-risorgimentale e financo dell’Italia repubblicana.
Parallelamente ai drammi, metteva mano a una serie di prose in cui ribadire i medesimi concetti, in un rapporto di reciproca influenza con il suo teatro. Anche se pubblicati soltanto intorno al 1789, vanno ascritti agli anni della prima produzione poetica i due famosi saggi Della tirannide e Il Principe e le Lettere. Nei quali – benché si dica oggi che germogliavano le basi che lo avrebbero portato a rifiutare i fatti di Francia – in mezzo a un atteggiamento comunque individualista e aristocratico, non veniva esclusa a priori la rivolta violenta contro i Re: “Io, che ad ogni vera incalzante necessità, abbandonerei tuttavia la penna per impugnare sotto il tuo nobile vessillo la spada” (Della Tirannide, libro I); “Aggiungerò, che, per maggiore sventura delle umane cose, è altresì più spesso necessaria la violenza, e qualche apparente ingiustizia nel posar le basi di un libero governo su le rovine d’uno ingiusto e tirannico, che non per innalzar la tirannide su le rovine della libertà. (…) le importantissime mutazioni non possono mai succedere fra gli uomini (come dianzi ho notato) senza importanti pericoli e danni; e che a costo di molto pianto e di moltissimo sangue (e non altramente giammai) passano i popoli dal servire all’essere liberi, più ancora, che dall’esser liberi al servire. Un ottimo cittadino può dunque, senza cessar di esser tale, ardentemente desiderare questo mal passeggero…” (ibidem, libro II, cap. VIII).
Una vignetta di qualche decina di anni fa, opera del compianto Giovanni Mosca, rappresentava un Alfieri accigliato: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli, e alla fine ho dimenticato cosa volevo”. Questo è forse ciò che gli accadde nel decennio successivo. Motivi di lavoro (la stampa delle sue tragedie) e personali (la convivenza con la sua compagna) lo portarono a vivere gran parte dell’anno a Parigi. Non era la prima volta che risiedeva nella città; e nella sua autobiografia avrebbe in seguito ricordato con disagio il suo primo soggiorno, definendola con la consueta mancanza di mezze misure una “fetida cloaca” (Vita, cap. V). Ma sono questi giudizi del senno di poi, tanto più da prendere con le pinze in una personalità così umorale e orgogliosa. I fatti asciutti ci dicono che Alfieri a Parigi restò per quasi dieci anni dopo il 1782, alternando la capitale francese con altre residenze ma sempre facendo ritorno. Non solo: gli eventi del luglio 1789 lo trovarono entusiasta spettatore. Questo è un qualcosa di cui in seguito si sarebbe pentito e vergognato; eppure al momento in cui la Bastiglia fu presa e distrutta dalla folla, il poeta sentì l’animo infiammarsi di spirito combattivo, e mise mano alla penna per celebrare la caduta della tirannide in una magniloquente ode “A Parigi sbastigliato” (riportata in appendice).
Ma gli eventi incalzavano, le violenze pubbliche e private si facevano via via routine quotidiana, e quella che inizialmente poteva sembrare una fase di passaggio verso una monarchia costituzionale all’inglese (fino ad allora la forma di governo maggiormente apprezzata dal poeta), si dimostrava un evento soltanto parzialmente governato dagli uomini, e più spesso tendente a un’anarchia selvaggia, una voglia di purificazione col ferro e col fuoco che prendeva di mira non soltanto il Tiranno ma l’intera aristocrazia. Ecco dunque Alfieri messo davanti a quello spargimento di sangue che dieci anni prima aveva definito un male passeggero e tutto sommato desiderabile. Basta all’incirca un anno e mezzo e forse meno per fargli mutare idea; ed è un lasso di tempo in cui, se da un lato ci sono state la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, l’abolizione della schiavitù e simili riforme progressiste, dall’altro si è assistito a massacri di massa, teste umane portate in corteo sulle picche, esplosioni di ferocia non sempre controllate quanto spesso strumentalizzate dai nuovi governanti. Una delle prime pagine del Misogallo esprime bene lo sconcerto dell’autore davanti allo spettacolo di una vera e propria caccia all’uomo per le strade parigine, un semplice sospettato inseguito e massacrato dalla folla, senza che in seguito le autorità si degnino di ricercare i responsabili. Alla fine dell’estate del 1792, Alfieri prende la sua decisione: lasciare la Francia a qualunque costo, per proteggere la sua donna e la sua stessa vita. Troppi sono stati per lui i campanelli d’allarme: in marzo l’adozione della famigerata ghigliottina, in aprile la dichiarazione di guerra alla Germania, tra giugno e agosto una serie di tumulti che hanno preso di mira il sempre meno regnante Luigi XVI, sino a farne un prigioniero dei suoi stessi sudditi. Per l’astigiano la misura è colma: procuratosi due passaporti per vie traverse, il 18 agosto tenta la fuga dal paese. Non è impresa facile, e riesce per un soffio, secondo il racconto appassionante che ci fa lo stesso autore (Vita, cap. XXII).
Si potrebbe dire che fece appena in tempo, perché di lì a poco sarebbe iniziato il 1793, l’annus horribilis della Rivoluzione: in gennaio l’esecuzione del Re e la proclamazione della Repubblica; in febbraio-marzo una valanga di dichiarazioni di guerra contro Inghilterra, Olanda e Spagna; in primavera l’istituzione del famigerato Tribunale Rivoluzionario e la repressione dei moti antirivoluzionari di Vandea; in settembre il completarsi del Terrore con la condanna a morte dei dantonisti.
Un bagno di sangue che Alfieri seguì soltanto da lontano, ma con non scemata passione. Tutt’altro. Un tipo come lui non poteva tacere, abitudine che gli era del tutto estranea anche in normali circostanze. Già mentre si trovava a Parigi aveva preso l’abitudine di buttar giù alcuni piccoli componimenti sui fatti del giorno, principalmente sonetti ed epigrammi; una volta trovato rifugio e sicurezza in Italia (“e chi ‘l crederebbe?” commentò egli stesso) rese sistematico quest’uso, mentre attorno si ingigantiva la tragedia – e quella vera, in proporzioni che lui stesso non avrebbe mai potuto immaginare: la parabola di Robespierre, la nascita dell’imperialismo rivoluzionario, il sorgere della stella di Napoleone. Nel 1799 l’astigiano si ritrovò con sufficiente materiale per mettere assieme un’opera bizzarra, mista di versi e di prose: una sorta di satira menippea, come l’avrebbe definita un greco antico. Ma lo stesso autore ne aveva paura, conscio di aver composto un libro proibito: non pensò alla sua pubblicazione, ma ne fece un numero limitato di copie da far circolare tra persone fidate. Non vide mai la sua opera stampata: essa uscì postuma, con una falsa dicitura (“Londra 1799”) per favorirne la circolazione clandestina. Fu perciò una specie di involontario testamento poetico, e che sorta di testamento: non un canto, ma una bestemmia. Il poeta era già di suo un uomo eccessivo; ma quando, come in questo caso, si infuriava raggiungeva facilmente la più alte vette dell’iperbole.
Ecco dunque – se ci passate l’anacronismo – un Alfieri célinizzato, che butta via rigore e misura per sfogare un odio gigantesco, volutamente esagerato, da fare impallidire la più dionisiaca delle commedie antiche. Il problema che lo ha lacerato sarà stato probabilmente trovarsi faccia a faccia con la prospettiva di dover, proprio lui, parlare contro il Popolo, la Libertà e anzi riabilitare il Tiranno (tant’è vero che, a detta sua, una delle prime parti composte fu l’apologia di Luigi XVI, in barba alla tesi di fondo del Della Tirannide, secondo cui ogni Re è per definizione un Tiranno). Ma allora perché il governo rivoluzionario gli appare così odioso, addirittura opprimente, tanto da fargli rimpiangere la monarchia assoluta? La risposta che si dà è semplice: non si tratta di vera libertà, bensì di una truffa, l’assolutismo rimesso su sotto un altro nome e con più gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini e dei loro beni. Ma – e le obiezioni incalzano – cosa fare allora di tutta la retorica sulla libertà e la rivolta? Perché non ha funzionato? E la seconda risposta è senza mezzi termini: la colpa è dei Francesi. Né più né meno. Si tratta un popolo barbaro, di schiavi nati, che mai potrebbero farsi liberi ad onta di tutte le dichiarazioni in questo senso; millantatori, sbruffoni, sanguinari, scambiano la libertà per l’anarchia, la Repubblica per una Tirannia sotto falso nome, e per di più, gonfi di superbia, pretendono di imporre all’Europa intera il loro imbizzarrito metodo di governo. Alfieri, che ammirava la monarchia costituzionale inglese e la repubblica dei neonati Stati Uniti, davanti ai difetti dell’esperimento francese trova la soluzione addossando la colpa, in modo anche un po’ razzista, al popolo che l’ha attuato: e il Francese diviene una sorta di Nemico numero uno dell’umanità.
Ma questa semplificazione non deve pensare a un pensiero organizzato. Il Misogallo è puro sfogo, non prevede la ragionevolezza di un pensiero pacato. Alfieri non teorizza: morde.
Come porci davanti a questa falange di insulti?
Dipende. Bisogna riconoscere che almeno al principio questo atteggiamento risulta efficacemente umoristico; e persino il più francofilo fra noi dovrebbe ammettere un pizzico di verità in versi come “Gente più matta assai che la Sanese / Or vedria Dante nostro, s’ei vivesse; / Se (come io l’odo) udire ei pur dovesse / Tutto dì millantarsi la Francese” (Sonetto V); anche se alla lunga subentra la noia per un’opera così lunga e ripetitiva: alla centocinquantesima ingiuria volgare contro i cugini d’oltralpe gli occhi prendono ad appesantirsi. Ma anche in questa caoticità e tendenza alla ripetizione, il Misogallo presenta delle pagine di altissimo valore, che avrebbero meritato ben altra sorte nella storia della nostra letteratura: si pensi allo spassosissimo dialogo tra le ombre di Luigi XVI e Robespierre (prosa V), nel quale i due, incontrandosi all’altro mondo, piangono la sorte comune toccata loro, l’uno re di nome, l’altro di fatto, ed entrambi uccisi dallo stesso strumento di morte.
Per quanto eccessivo, apparentemente inaccettabile, questo Misogallo non è il frutto di un anziano che si scopre d’improvviso reazionario, né il vaneggiamento di un folle. È lo sfogo livido di un idealista che ha tanto idealizzato da mettersi nella condizione di rifiutare qualunque concretizzazione dei suoi sogni, come inevitabilmente inferiore a quelli. Gli altisonanti appelli di Alfieri alla libertà si erano formati sulle pagine di Plutarco, e dovevano assomigliare nella sua testa a certi dipinti neoclassici, come quelli di David, il pittore ufficiale della Rivoluzione. Si aspettava un tempio greco, e si ritrovò in un mattatoio.
Soltanto in questo modo si comprende la sua delusione, e la sensazione irritante di essere preso in giro ogni qual volta viene nominata dai Francesi la parola Libertà. Lo spiega bene con irriverente sarcasmo in uno dei più caustici epigrammi (il XXXV), nonché quello che forse più di tutti esprime il suo pensiero sulla Rivoluzione Francese:
Si dice, che dicea non so qual Papa
Palpandosi la tiara: Oh quanto bene
Ci fa quest’ampia favola di Cristo!
Così, cred’io, dice ora il ben più tristo
Gruppo de’ nuovi Gallici Pentarchi,
Rimpannucciati, e di ricamo carchi,
Le panciette palpandosi omai piene,
E dianzi avvezze al cavolo e alla rapa,
«Oh beata novella cecità!
Quanto a noi fa pur bene
La favoletta della Libertà».
Marcello Donativi