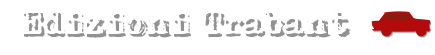Prefazione a
Scritti politici – Giacinto De Sivo
«Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei Consigli d’Europa perché grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché, nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di noi!»
Così dichiarava il 10 gennaio 1859 re Vittorio Emanuele II di Savoia, giustificando quella che di lì a poco sarebbe diventata la politica piemontese di annessione degli stati italiani.
Un grido di dolore, l’espressione era destinata a divenire proverbiale. Purtroppo, c’è da ammettere che a gridare di dolore, alla fine del convulso processo di unificazione nazionale, furono in tanti, e non sempre casa Savoia seppe dimostrare la stessa sensibilità. «Pavammo nui da sott’ / e Emmanuele se ne fott’» recitava un canto popolare della seconda metà dell’800. Al di là del folclore, l’epoca post-unitaria vide tutto un fiorire di pensatori, intellettuali o semplici memorialisti intenti a urlare il proprio disappunto per il nuovo stato di cose, e dalle posizioni più disparate: un ampio gruppo di scontenti che andava dai legittimisti contrari al cambiamento, per motivi di principio e di merito, a quei rivoluzionari che il cambiamento l’avevano auspicato ma, una volta avvenuto, restarono delusi. Chi ci segue, lo sa: da alcuni anni ci prodighiamo per riportare all’attenzione del pubblico queste testimonianze, spesso passate sotto silenzio.
Tra i legittimisti, non lo scopriamo certo noi, un posto di rilievo è occupato da Giacinto De Sivo. Con la sua veemenza egli rappresenta probabilmente il più acceso, appassionato, sincero pensatore filo-borbonico del suo tempo. «Il più feroce sostenitore dei Borboni» abbiamo avuto modo di definirlo in occasione della pubblicazione della Storia delle Due Sicilie. Una definizione che è spiaciuta a qualcuno, ma che da parte nostra s’intendeva nel suo significato etimologico di strenuo, infaticabile. Come ad alcuni ha garbato poco la prefazione al primo volume della Storia, nella quale, volendo presentare il personaggio anche a chi vi si accostasse la prima volta, abbiamo osato muovergli qualche appunto e, in un paio di occasioni, fare dell’ironia. Le critiche che ci sono arrivate – sempre nell’ambito del garbo e dello scambio civile di opinioni – sono un segno più che evidente della simpatia e del rispetto che questo personaggio gode oggigiorno nella cerchia degli appassionati di storia meridionale.
Abbiamo dunque pensato che fosse utile completare il quadro raccogliendo, per la prima volta in un unico volume, le altre sue opere di argomento politico. Un insieme di pamphlet e discorsi pubblici – più un piccolo componimento poetico – che, per i motivi che addurremo, non soltanto affiancano ma per certi aspetti chiariscono meglio l’opera storica dell’autore.
La nostra raccolta ha inizio con l’elogio pronunciato nel 1852 per la morte del generale Ferdinando Nunziante, l’uomo che nel biennio 1847-49 aveva domato le rivolte in Calabria e Sicilia. Gli avvenimenti dell’epoca avevano profondamente scosso l’autore, al punto da spingerlo a scrivere il primo abbozzo di quella che sarebbe diventata la Storia delle Due Sicilie. Nelle vicende del ‘48 napoletano De Sivo aveva già scorto i semi di quel processo che avrebbe portato in meno di quindici anni al disfacimento del regno borbonico: da questo punto di vista, la prematura scomparsa di Nunziante, da lui descritto come un eroe legittimista tale da poter essere contrapposto a Garibaldi – e si noti con che maligna soddisfazione l’autore ci descrive il nizzardo che dopo Velletri fugge pur di non scontrarsi con il napoletano – assume quasi i contorni di un oscuro presagio.
Difatti, il testo successivo è ancora un discorso funebre, mai però stacco potrebbe essere più drammatico. Ci spostiamo a Roma nell’ottobre del 1861, quando De Sivo partecipa, con gli altri legittimisti napoletani in esilio, alle celebrazioni per il primo anniversario della sfortunata battaglia del Volturno. Data l’occasione, il tono è similmente di cordoglio, ma ad essere pianto non è più adesso un uomo soltanto, ma un regno intero e una lunga schiera di caduti. Il Discorso pe’ morti nelle giornate del Volturno è l’occasione, per il tragediografo di Maddaloni, per riassumere in breve le vicende della caduta dei Borboni e soprattutto la drammatica situazione del Mezzogiorno nell’immediato indomani della unificazione. Una struggente malinconia percorre queste righe, con tutto il dolore che un esule può provare per essere costretto a osservare la sua terra da lontano. La conclusione è, ad ogni modo, di speranza: «Si, rivedremo i nostri cari monti, le nostre campagne benedette, le incontate sponde delle Sirene; finirà questo esiglio, ritorneremo a’ paterni focolari, riabbracceremo le spose, ribaceremo i figli nostri.»
Di tutt’altro tono il successivo L’Italia e il suo dramma politico nel 1861. L’anno è il medesimo, ma l’occasione e lo spirito profondamente differenti. Non si tratta, adesso, di una commemorazione dei caduti, ma di una appassionata filippica contro il progetto dell’unità italiana. L’argomento è generale e non riguarda esclusivamente le regioni meridionali: De Sivo si scaglia contro quella che ritiene essere un’ipocrita bugia, presentare cioè come progetto di riscatto nazionale quella che è soltanto, a conti fatti, l’espansione di uno staterello e una rivoluzione a danno dei legittimi regnanti. Attinge alla sua indignazione per smentire la vulgata propagandistica degli unitari, secondo cui gli stati della penisola fossero tutti, quale più quale meno, degli incubi di miseria e oppressione. Deride le ambizioni del neonato Regno d’Italia in campo internazionale, mortificando, dati alla mano, le sue reali possibilità di competere con le potenze europee.
Se nel Dramma politico lo sguardo è focalizzato all’Italia tutta, nel successivo pamphlet ci si concentra quasi esclusivamente sulla situazione di Napoli. Parliamo di quello che è forse il saggio più celebre del De Sivo: I Napoletani al cospetto delle nazioni civili. Potremmo azzardare addirittura che sia la sua opera più riuscita, per impatto e scorrevolezza. Diversi elementi che nei saggi precedenti abbiamo potuto sentire accennare, dipingere appena o soltanto introdurre, qui si riuniscono in un unico, coerente tutt’uno. I temi cari a De Sivo, condensati in poche pagine, ci sono tutti: esprime la sua avversione al cospirazionismo liberale-massonico, rivendica con orgoglio il felice stato del Regno delle Due Sicilie prima del 1860, smaschera le arti adottate dai suoi nemici per calunniarlo e farlo passare per una sorta di inferno sulla terra, descrive per sommi capi la sventurata campagna del 1860-61 che ha portato all’annessione piemontese. Ma l’Italia – avverte – non può essere unita, i suoi stessi abitanti non lo desiderano, né a conti fatti conviene davvero che sia unita; e in una lunga sezione centrale motiva il suo assunto su basi linguistiche, storiche, politiche. In chiusura, lancia un appello alle nazioni europee perché dimostrino attenzione al tragico stato del meridione d’Italia, devastato da una guerra civile chiamata brigantaggio, e alla situazione dei suoi esuli che vanno «raminghi per la terra, riempiendola di lamenti, invocando soccorso dagli uomini e dal cielo.» È, in definitiva, il vero altro grido di dolore da contrapporre a quello citato da Vittorio Emanuele II: grido, in fin dei conti, inascoltato.
Conclude la nostra raccolta un componimento poetico, la canzone All’Italia, occasione colta dall’autore per ribadire in versi il medesimo strazio per una penisola ridotta, a suo vedere, ad un cumulo di «carceri colme e strette / spie, sgherri, uccisioni, ire e pugnali».
Il nome di Giacinto De Sivo resterà per sempre legato alla Storia delle Due Sicilie, la sua opera più imponente e più letta, anche se non con il successo che avrebbe meritato. E tuttavia, rispetto a quella, i presenti scritti, per quanto composti in base all’urgenza del momento, per occasioni particolari, o per commentare fatti contingenti dell’attualità, hanno un loro particolare interesse nel presentarci in forma più completa il pensiero dell’autore. Un pensiero che soltanto a una lettura superficiale potrebbe essere liquidato come reazionario e retrogrado. Certo, nasce da una bruciante esperienza che lo spinge a esprimersi in una forma veemente, sarcastica, talora violenta; ha però una sua lucidità nel denunciare la faciloneria e l’ipocrisia dell’illusione di fare uno stato dal nulla calpestando storia, tradizioni e quelli che oggi chiameremmo diritti umani. Ma De Sivo in queste pagine non si limita a distruggere, ci lascia anche intravvedere, sia pure in modo sfuggente, l’aspetto propositivo del suo pensiero: il ripudio dell’espansionismo militaresco, l’idea federalista considerata come la più adatta per la particolare storia politica e culturale della penisola italiana, un certo universalismo cristiano che lo porta a prediligere la multi-culturalità al nazionalismo: «Anzi che abolire la idea di straniero, la esageriamo, e risvegliamo le gelosie e le ambizioni. Ma questo pensiero che ne richiama a’ tempi rozzi, e fa considerare nemico qualunque parli diversa lingua, è pensiero vecchio che accenna a disgiungere quanto Cristo annodava; è ritorno al paganesimo che appellava barbaro lo straniero, e lo voleva morto o servo.»
Scrivendo per lo più a 1861 in corso, egli dimostra anche di nutrire solide speranze sul trionfo di queste idee. Da buon cristiano, De Sivo crede nella Provvidenza e non può abbandonarsi all’idea che i torti restino a lungo impuniti. Esule, osserva da lontano le vicende della sua vecchia patria e, sotto l’ottica distorta dalla distanza e dalla partecipazione emotiva, in parte esagera o fraintende gli avvenimenti. Il fenomeno del brigantaggio, per esempio, eccita la sua fantasia, vi scorge il tanto agognato riscatto del suo popolo soggiogato: Fuori lo straniero! è il grido terribile di tutta una gente oppressa: ogni valle, ogni grotta, ogni macchia ne ripete l’eco; un popolo non può tutto andare in esilio, o in carcere, o in tomba. Vi saran sempre braccia per combattere e seppellire l’avido invasore sotto le campane glebe.» Scrivendo noi invece nel 2013, dobbiamo riconoscere come tali previsioni si siano rivelate, alla lunga, errate, ed è questo l’aspetto più malinconico che sottostà ai presenti scritti. Se De Sivo nel Discorso pe’ morti nelle giornate del Volturno vaticinava la fine dell’esilio, la storia decise invece tutt’altro e, nonostante i tentativi, a volte anche ingenui, per resuscitarlo, il suo amato Regno di Napoli non rivide più la luce. A conferma della veridicità di quell’amara battuta attribuita a Francesco II di Borbone: «I regni sono come i sogni. Dopo qualche giorno, non se ne ricorda più nessuno.»
Marcello Donativi