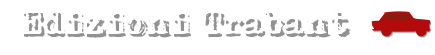Prefazione a
Cronachetta siciliana dell’estate 1943 – Nino Savarese
L’onore di essere liberato per primo era toccato in sorte, fra tutti i popoli d’Europa, al popolo napoletano: e per festeggiare un così meritato premio, i miei poveri napoletani, dopo tre anni di fame, di epidemie, di feroci bombardamenti, avevano accettato di buona grazia, per carità di patria, l’agognata e invidiata gloria di recitare la parte di un popolo vinto, di cantare, batter le mani, saltare di gioia fra le rovine delle loro case, sventolare bandiere straniere, fino al giorno innanzi nemiche, e gettar dalle finestre fiori sui vincitori.
Curzio Malaparte, già nelle prime pagine de La Pelle, mette le cose in chiaro non solo sul tono che caratterizzerà il suo romanzo-inchiesta, ma anche su uno dei temi portanti: la raffigurazione degli italiani del 1943 non già come un popolo liberato, ma come un popolo vinto. Con tutto ciò di degradante che l’essere vinto porta con sé, compreso il sentirsi in obbligo di applaudire e ringraziare il vincitore.
Il pensiero di Malaparte ci è venuto alla mente, come un deja-vu, leggendo la Cronachetta Siciliana di Savarese, in quei punti in cui descrive l’incontro tra i soldati americani e la popolazione nostrana:
La gente affamata, sofferente e turbata si pigia attorno ai nuovi arrivati, aspettando aiuti miracolosi. Questi occhi avidi, questa bramosia, queste risvegliate esigenze in ogni ceto di persone, anche per tanti bisogni superflui ed imitativi, danno nausea. Guardano questi soldati ben vestiti, guardano gli oggetti nelle loro mani come bestie imploranti. Ora vogliono ottenere per adulazione dal nemico di ieri, quello che si fece credere loro di potergli strappare con la violenza delle armi.
E le analogie potrebbero anche finire qui, perché laddove Malaparte sfodera tutto il caleidoscopio di turpitudini che il suo cinismo riesce a ricordare, ad amplificare o a inventare di sana pianta, Savarese da par suo cerca di mantenersi sul terreno della cronaca, al limite condita qua e là di un certo lirismo. Eppure entrambi, dietro le rispettive maschere, tradiscono il medesimo sentimento: una profonda tristezza per la sorte della propria gente. Una tristezza piuttosto diffusa anche tra chi gioiva della caduta del fascismo, un peso dovuto all’oggettiva constatazione di essere stati sconfitti, benché in una guerra insensata e a tratti impopolare, e di non aver ottenuto indietro la libertà con i propri mezzi, ma averla ricevuta da altri.
Poi, su questa constatazione, ognuno costruisce il tessuto che preferisce. E in effetti Curzio Malaparte, nel brano citato, tanto si lascia prendere la mano dalla forte immagine che ha in mente, da commettere una lieve imprecisione. Perché, a ben vedere, non era stato il popolo napoletano il primo a essere liberato in Europa: era stato il popolo siciliano.
E dunque l’onore di essere uno dei primi testimoni dell’avvenimento non spettava a lui ma, tra gli altri, a Nino Savarese.
Ma facciamo un passo indietro e ricapitoliamo in che maniera la guerra, sino a quel momento lontana, era potuta irrompere nella campagna di Enna, in queste “contrade di secolari silenzi”. Per farlo, dobbiamo spostarci nel Marocco, a Casablanca, qualche mese prima. Precisamente, nella seconda metà del gennaio 1943.
Qui, nella città in cui l’anno precedente era stato ambientato l’omonimo film con Humphrey Bogart, si erano incontrati i rappresentanti degli Alleati con il seguito del proprio Stato Maggiore: da una parte Winston Churchill e il generale Alexander, dall’altra Franklin Roosevelt con il generale Eisenhower; qualche giorno più tardi li avrebbe raggiunti Charles De Gaulle. Mancava Iosif Stalin; benché assente, egli era però il convitato di pietra della situazione. Uno dei punti all’ordine del giorno erano infatti le sue insistenze affinché gli alleati intraprendessero qualche azione sul fronte occidentale per alleggerire la pressione dell’Asse sull’Unione Sovietica.
I rappresentanti americani erano favorevoli a considerare un piano, ma indecisi sui dettagli: ipotizzavano uno sbarco in Francia, o l’intensificazione dei bombardamenti sulle città tedesche. Churchill aveva invece un’idea chiara: l’attacco sarebbe dovuto essere portato al “ventre molle” dell’Asse, l’Italia. Le ragioni erano molteplici. Strategiche sicuramente, quali consolidare le conquiste nel Mediterraneo e rendere più sicura la navigazione alleata. Vi erano però anche ragioni politiche: attaccare il componente ritenuto più debole dell’alleanza nemica poteva significare, facendo leva sul malcontento della popolazione e di parte della classe dirigente, costringerlo con poco sforzo all’uscita dal conflitto. Una previsione, a ben vedere, azzeccata, a patto di stralciare la parte relativa al poco sforzo.
Fu così deciso di procedere con l’invasione della Sicilia, in codice Operazione Husky. Dopo un lungo lavoro di preparazione non solo bellica, ma anche spionistica (compreso – pare – l’allacciamento di contatti con la mafia locale), il 10 luglio 1943 le truppe anglo-americane sbarcavano nella parte sud-orientale dell’isola, senza trovare la strada spianata ma nemmeno correndo il rischio, come annunciato da Mussolini, di essere fermate sulla battigia. Chiedo scusa, bagnasciuga.
Dal punto di vista strategico, l’obiettivo principale era quello di puntare al controllo dello stretto di Messina. Allo scopo, la VIII armata britannica del generale Montgomery (il vincitore di El Alamein), sbarcata a sud di Siracusa, avrebbe marciato verso nord, passando per Catania e conquistando, infine, Messina. Alla VII armata statunitense, comandata dal generale Patton, era invece assegnato un compito minore: sbarcare tra Gela e Noto e avanzare quanto bastava per coprire il fianco sinistro agli Inglesi. Non era prevista una penetrazione nell’interno: gli Ennesi avrebbero potuto dormire sonni tranquilli.
Ma qui intervennero umanissimi sentimenti come orgoglio e gelosia. Patton, l’irascibile, pittoresco generale Patton, famoso per i modi spicci, il linguaggio brutale e gli atteggiamenti da film western, non poteva rassegnarsi a un ruolo subalterno. Cercò quindi di convincere in tutti i modi il generale Alexander, comandante in capo delle forze di terra dell’operazione, a permettergli di avanzare nel cuore della Sicilia e puntare su Palermo. Una mossa di scarsa utilità dal punto di vista strategico, ma utile ai fini propagandistici. La guerra è fatta anche di questo. Alexander, alla lunga, cedette, non perché interessato alla presa di Palermo, ma perché scorgeva una qualche utilità nel “tagliare in due” l’isola con una marcia verso l’interno. Vale a dire, verso Enna.
Fu pertanto un misto di improvvisazione e vanagloria a far sì che, nell’estate del 1943, lo scrittore siciliano Nino Savarese si trovasse faccia a faccia con il mostro della Seconda Guerra Mondiale.
Savarese era nato nel settembre 1882 in quella che ancora all’epoca si chiamava Castrogiovanni (soltanto negli anni ’20 riprenderà il suo antico nome di Enna). Poco meno che trentenne, aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma, dove visse gran parte della sua vita, raggiungendo una certa fama coeva come giornalista e scrittore. Una fama al giorno d’oggi un po’ sbiadita, ma tale all’epoca da costituire l’ispirazione di diversi autori successivi, uno tra tutti Leonardo Sciascia. Non aveva però spezzato del tutto il legame con la terra madre, dove tornava spesso alla tenuta di famiglia, il Podere di San Benedetto. Qui appunto si era recato nel 1943, quando l’avanzata dell’esercito anglo-americano gli impedì di rientrare a Roma. Bloccato nel mezzo degli avvenimenti, fu ispirato a scrivere il diario che presentiamo, che – non poteva saperlo – sarebbe stata la sua ultima opera. Tornato infatti a Roma nel 1944 dopo la liberazione della città, sarebbe morto per un malore improvviso nel gennaio del ’45, senza riuscire nemmeno a vedere la fine della guerra.
Ma torniamo al diario. Diario romanzato, sicuramente un’opera letteraria pensata per essere tale e non semplici appunti di un testimone. Savarese è uno scrittore e come tale vive il suo compito di cronista. Ma è proprio questo uno dei punti di interesse. È come se partisse dal mondo contadino della tradizione letteraria siciliana per descrivere il suo improvviso, e traumatico, incontro con la civiltà contemporanea. In pratica, Mastro don Gesualdo davanti ai carri armati.
Siamo alla fine di giugno, ed è giunto il tempo di mietere il grano. Sono cicli della vita di campagna che si reiterano, immutati, da secoli; eppure quell’anno i contadini esitano a mettere mano alla falce. La ragione è intuibile nei segnali della prossima sventura. Aerei nemici sempre più spesso solcano il cielo, e in lontananza, di notte, si scorgono i bagliori delle esplosioni, che i popolani osservano fuori di casa allo stesso modo dei fuochi d’artificio durante le feste di paese. La gente del posto, osserva l’autore, non è abituata alla guerra, che da secoli non si fa vedere in queste provincie; pensa ai propri ritmi, si preoccupa del grano. Il tempo è talmente immutato che il Commissario Civile viene ancora chiamato il “vicerè”.
Con il passare dei giorni la guerra lascia intendere i suoi segnali sempre più forti. Aumentano i rumori. Arrivano sempre più soldati tedeschi a cercare postazioni, requisire materiale. Si intensificano i bombardamenti, ed è la città di Enna a sperimentarne, per prima, gli orrori. Finché non subentra un sentimento di stanchezza, e fa sì che la popolazione arrivi ad augurarsi che il nemico venga presto, e tutto finisca in qualsiasi modo, purché finisca. Un sentimento che, all’epoca, era tutt’altro che poco diffuso nella popolazione italiana.
E un giorno arriva la notizia: “Vengono. A momenti sono qui”.
Quando giungono, ciò che avviene è ben lontano dalla descrizione macchiettistica che popola tanti filmati propagandistici degli Alleati, con i bravi ragazzi americani abbracciati alle donne italiane e intenti a distribuire generosamente cibo e sigarette. Piuttosto, è l’incontro tra gente che proviene da secoli differenti, e la delusione è, forse, reciproca.
Sono arrivati i ricchi in terra di poveri: sono arrivati i ben calzati tra gli scalzi, gli spensierati fumatori tra i forzati astemii, i divoratori di scatole tra quelli che si nutrono di solo pane e di piante legate alle radici. Guardano. Avevano negli occhi immagini di terre lussuose, di climi eccessivi, di eccessive fruttificazioni, e di una vita facile e lustra di novità: ora li posano su questi ulivi centenari dalla chioma gentile e ben proporzionata, su queste siepi di fichidindia che prosperano sulle pietre, su queste colline umili sparse di casette, vigilate da un cipresso, da un olivo e da un olmo.Le cose che essi portano con loro: le scatole di latta che lasciano per terra, le custodie di cartone che spargono tra le stoppie gridano novità: troppe nude, in quest’aria carica di tempo: sembrano non ancora ammansite dalla pazienza, dalla difficoltà e dalla carità dell’uomo, come fossero state fatte per essere prese e lasciate. E nella loro nuda pulitezza contrastano con tutto ciò che è nostro, e che porta l’impronta della fatica, anche dello stento, ma insieme di un accordo placido con la natura: i panni dei nostri contadini, le barde delle cavalcature, gli arnesi di lavoro che sanno di leggenda nella loro austera semplicità.
Seguiranno altre scene, come quella riportata all’inizio, dalle quali traspare tutta l’amarezza di Savarese per quella che è ben più di una sconfitta militare: è il tracollo morale di un popolo. Le stesse scene di elargizione di beni diventano un’umiliante elemosina da parte del vincitore a un vinto non degno nemmeno del disprezzo riservato ai tedeschi.
Non che Savarese appoggi il fascismo o la guerra; tutt’altro. Ma, lucidamente, non riesce a scindere le responsabilità del regime da quelle del popolo che l’ha seguito. Riflette a posteriori sulle ragioni, per lui poco comprensibili, che ci hanno spinto nel conflitto, e l’unica risposta che riesce a darsi è che sia la guerra dell’invidia. Riflette sulle ambizioni di potenza internazionale, probabilmente gli tornano alla mente gli slogan sul posto al sole, e altro non vede che un livido desiderio di impossessarsi della ricchezza altrui, una ricchezza dunque non sudata, non meritata e nemmeno, in fondo, necessaria. Se si trascina un popolo, specialmente quello italiano, in una guerra con tali presupposti morali, la vittoria non è possibile. Savarese, che sotto il fascismo non ne era stato un aperto oppositore, nel momento in cui cade non cerca di rifarsi una verginità tardiva, ma analizza con la necessaria lucidità le ragioni di un tracollo generale della società.
È una lettura utile, oltre che piacevole, per le ragioni che ci portano spesso a proporre un’opera, la ricerca cioè di testimonianze che ci aiutino a trovare un equilibrio tra le opposte fazioni che troppo spesso scandiscono la memoria storica; in questo caso, tra il ritratto oleografico dei liberatori alleati accolti da una popolazione festante e quello, simile ai manifesti di Boccasile, di crudeli invasori responsabili nientedimeno che della morte culturale dell’Europa (la citazione è di un politico italiano che, come tanti altri suoi colleghi, amava un tempo spararle grosse, salvo smentirsi anni dopo).
Savarese non è di alcuna di queste sponde. Da uomo taciturno e riflessivo quale ci viene descritto, osserva la Storia che gli passa accanto, e ne coglie gli aspetti essenziali. Non abbiamo vinto la guerra: siamo gli sconfitti, ed essere passati subito con i vincitori non può mutare questo fatto; e tuttavia, non siamo delle vittime, perché l’abbiamo voluto, l’abbiamo cercato, se non tutti, almeno in molti. E anche chi non lo voleva, non deve fare a meno di notare che la libertà ritrovata è arrivata sulle punte delle baionette, e viene elargita al pari delle sigarette e della carne in scatola. Un’elemosina, appunto.
Adesso sono venuti anche gli inglesi, ma nessuno sa dove stiano, nessuno li vede. Due bandierine straniere sono state messe a sventolare, sebben con discrezione, sopra un edificio fascista. Guardiamo in silenzio: un velo di tristezza copre i nostri occhi, un senso di violazione, di perdita pesa sul nostro cuore.
Eppure non sappiamo rimpiangere il lugubre vessillo nero di cui queste bandiere hanno preso il posto. E che non era la bandiera d’Italia.
Marcello Donativi