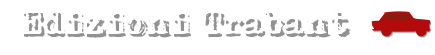Prefazione a
Un italiano in America – Adolfo Rossi
“Negli ultimi anni la loro immigrazione è aumentata in maniera allarmante. La capitale e le città di provincia sono affollate da masse di loro che sono per lo più improduttive. Sono stati tra i primi a emigrare da noi, e da diversi punti di vista sono i peggiori. Ovviamente, non includo quelli che arrivano per trovare un qualche lavoro, gente laboriosa, capace e rispettosa della legge. Ma purtroppo la maggior parte di loro sono diversi: si tratta per lo più di delinquenti ed emarginati, che arrivano qui soltanto per fare i vagabondi e gli accattoni, visto che nel loro paese è proibito. Portano con sé le loro abitudini di pigrizia e degradazione, e ovunque aumentano non possono che esercitare un’influenza negativa sulla popolazione. […] L’aspetto peggiore nella loro immigrazione è il traffico di bambini. […] Li mandano per strada la mattina presto con la fisarmonica o altri strumenti musicali e hanno il compito di suonare davanti alle case e aspettare le monetine. Non chiedono apertamente l’elemosina, semplicemente stanno lì e aspettano, e le persone indulgenti, mosse a pietà dal loro aspetto misero, si commuovono e danno dei soldi, senza badare al fatto che il denaro non andrà personalmente a loro, ma al padrone che li ha acquistati.”
Sarebbe un esperimento piuttosto interessante sfidare il lettore a indovinare il soggetto del brano appena citato. Sono forse gli Zingari? I Rumeni? Gli Albanesi? E l’autore, è un esponente di quei movimenti politici che da anni si battono per porre un argine all’immigrazione nel nostro paese?
Niente di tutto questo, in verità. Il brano ha più di cento anni, l’autore è inglese e il soggetto delle sue invettive sono… gli Italiani. Il libello, stampato a Londra nel 1892, si propone di analizzare i flussi di immigrazione verso l’Inghilterra e i relativi problemi. L’autore individua due categorie di immigrati particolarmente pericolose: gli Ebrei e gli Italiani. In entrambi i casi, pur mettendo le mani avanti affermando di essere ben disposto verso chi intende lavorare e rispettare la legge, le conclusioni cui arriva sono le stesse: bisogna impedire a ogni costo che questa gente continui ad affluire, perchè si tratta di individui dall’innata tendenza a delinquere, sfaccendati, poco propensi ad assimilarsi alla cultura inglese e anzi capaci, alla lunga, di esercitare un’influenza perniciosa sugli Inglesi stessi.
Una posizione estremista? Probabile. Era però un sentimento diffuso nei paesi anglosassoni dell’epoca, e riguardava indistintamente italiani, irlandesi, polacchi e via a seguire. Nei primi anni del XX secolo un articolo comparso su un quotidiano di New York così si esprimeva: “Gli argini sono abbattuti. Le sbarre sono aperte. Le porte d’ingresso non presidiate. La diga abbattuta. Le fogne non sono bloccate. L’Europa sta vomitando! In altre parole, la feccia dell’immigrazione si sta riversando sulle nostre coste.” Qualche giorno prima, una vignetta satirica sullo stesso quotidiano aveva cercato di rappresentare graficamente il fenomeno. Era raffigurata una gigantesca barca posta sull’Oceano Atlantico, in modo da collegare l’Italia e l’America del nord. Attraverso di essa, ogni sorta di delinquente e accattone poteva agevolmente fare il proprio ingresso negli Stati Uniti.
Non mancavano, ovviamente, anche le voci in favore. Come capita oggi da noi, erano le associazioni di volontariato, spesso di natura religiosa, a prendere le difese degli stranieri. Avveniva così che nel 1917 il direttore di una società di studio dell’immigrazione, legata alla Chiesa Presbiteriana, affermava: “Quello che gli Italiani chiedono non è la nostra carità né la nostra commiserazione, ma avere l’opportunità di condividere con noi la vita di ogni giorno di cui ognuno dovrebbe far parte conservando il proprio personale patrimonio culturale.”
Nel corso degli ultimi anni, man mano che il nostro paese veniva investito da flussi migratori sempre più consistenti, con le relative, forse fisiologiche reazioni (compresi episodi del più becero razzismo), molti italiani hanno riportato alla memoria dell’opinione pubblica il periodo in cui erano i nostri connazionali a emigrare in terra straniera e subirne le conseguenze. Molto spesso, questo genere di operazioni hanno lo scopo dichiarato di generare empatia nei confronti degli immigrati, ricordando come le stesse sofferenze le abbiano patite molti dei nostri nonni o bisnonni. “Quando gli Albanesi eravamo noi” è d’altra parte il sottotitolo di un fortunato libro-inchiesta sul tema, di fatto uno dei maggiori best-seller degli ultimi dieci anni. L’intento è nobile. Forse però converrebbe astrarsi dalle necessità contingenti e trarre da queste storie una lezione più generale, che ruota intorno all’eterno problema della migrazione, questa ruota in perenne movimento che, apparentemente, presto o tardi colpisce ogni popolo più o meno alla stessa maniera. Un fenomeno complesso, ricco di così tante sfaccettature da non poter essere ridotto soltanto ai suoi aspetti di miseria e xenofobia. Comunque lo si voglia giudicare, una miniera inesauribile di storie. E a noi questo interessa: ascoltare delle storie.
Purtroppo, però, spesso queste restano senza un cantore. Nella maggior parte dei casi, lo status socio-culturale del migrante è tale da lasciare la sua testimonianza più alla tradizione orale che a quella scritta. Pensiamo ai canti degli emigranti, forme di poesia popolare tramandata di bocca in bocca: Mamma mia dammi cento lire, Trenta giorni di nave a vapore e altri. Un patrimonio prezioso, espressione però più che altro di una memoria collettiva. In sostanza, manca in genere il racconto organico – e scritto – di una singola esperienza.
Se c’è però un caso che fa eccezione è quello di Adolfo Rossi, l’autore del libro che presentiamo. Un uomo che non emigrò per miseria quanto per curiosità, portando dietro il suo entusiasmo giovanile e le ambizioni di farsi cronista di una grande avventura. Quando, infatti, nell’estate del 1879 prese la decisione di lasciare tutto e partire per gli Stati Uniti, non si può dire che fosse attanagliato dalla fame. Era in un certo senso un privilegiato: aveva potuto studiare, pur senza arrivare al diploma, aveva una famiglia a sostenerlo e poteva frequentare concittadini illustri in letteratura e in politica come Alberto Mario. Un lavoro, poi, l’aveva. Tramite un concorso pubblico, aveva ottenuto un posto da impiegato alle Poste. Rossi sarebbe potuto diventare uno dei placidi padri di famiglia immersi nella noia di provincia; spinto, invece, da fantasticherie giovanili o, per usare le sue stesse parole, tormentato da “una specie di nostalgia dell’ignoto”, all’età di ventuno anni decide di trasferirsi a New York. Oltre al poco bagaglio e denaro, porta con sé anche la voglia e la capacità di fissare su carta le tappe della sua esperienza.
Abbiamo così la possibilità, più unica che rara, di seguire un emigrato in tutto il suo arduo tragitto. Dall’interminabile viaggio in nave, già in sé carico di insidie, al primo approccio a una realtà che si rivela subito dura e ostile; le difficoltà di imparare la lingua del posto e trovare un lavoro; gli episodi di solidarietà tra immigrati, ma anche i casi in cui uno straniero può essere angariato dai suoi stessi connazionali; le storie inquietanti di delinquenza e alcolismo.
In tutto questo Adolfo Rossi si muove con lo spirito del cronista, teso a dipingere un quadro, più che a dare giudizi di valore. Vuole descrivere, non muovere a pietà o denunciare. Questo lo porta, a volte, a raccontare episodi poco edificanti nei confronti del suo popolo. Quando, per esempio, al nono capitolo parla dei Cinque Punti, cioè la baraccopoli dei Five Points immortalata al cinema dal famoso film Gangs of New York, confessa con sincerità: “A New-York c’è quasi da vergognarsi di essere italiani.” E ci porta per mano a passeggiare nei bassifondi, entrare nei locali malfamati in cui si serve birra avariata, assistere alle trattative tra i caporali e i braccianti, secondo un sistema che il nostro non esita a definire una forma di “schiavitù italiana.” In un altro passaggio, però, si ribella ai numerosi stereotipi che circolano sugli Italiani e descrive, sotto forma di testo teatrale, la scena surreale del giovane immigrato ospite a cena, costretto a rispondere a numerose domande come “è vero che portate sempre un coltello in tasca?” o “quale strumento musicale suoni?”
In generale, il suo tono è leggero, anche quando si trova a riferire storie di povertà e violenza. Rossi si sforza di intravvedere il lato curioso, quasi divertente, delle cose. Ne è un esempio quello che, a nostro avviso, è uno dei passi più riusciti: la descrizione del gergo italo-americano. Nel corso di due pagine memorabili, possiamo assistere a un’intera conversazione tra due italiani, che parlano nella loro lingua inframmezzandola di parole inglesi storpiate e italianizzate. Al punto da avere alla fine frasi come “Sì, adesso è in un buon bisiniss (business); ha un bello stendo (stand) di pinozze (peanuts) in Vico Stretto (Bleecker Street).”
Sono questi bozzetti di vita quotidiana ciò che più abbiamo apprezzato in questo libro e, speriamo, apprezzerete anche voi.
Partito senza un soldo, dopo aver praticato i mestieri più disparati, Adolfo Rossi poté mettere a frutto la sua educazione umanistica ottenendo alla fine un posto come redattore del periodico Il Progresso Italo-Americano. La sua storia è dunque quella di un migrante che, come si suol dire, ce l’ha fatta. È, però, anche la storia di uno di loro che un giorno fece ritorno a casa. Dopo tre anni di esperienza americana rientrò infatti in Italia, dove fece tesoro dell’esperienza maturata all’estero per avviare una brillante carriera di giornalista. Inviato del Corriere della Sera, fu uno dei primi corrispondenti di guerra, in Turchia ed Eritrea. Ma non aveva reciso del tutto il suo legame con l’immigrazione. Fu il tema di alcune sue fortunate pubblicazioni: oltre alla presente, segnaliamo Nel paese dei dollari: tre anni in America, un testo dal taglio meno narrativo e più saggistico de Un Italiano in America. Ma non solo: nel 1901 lasciava il giornalismo per diventare ispettore del neonato Commissariato sull’Emigrazione Nazionale, un lavoro che lo avrebbe portato a girare il mondo, principalmente le Americhe del Nord e del Sud, ovunque ci fossero comunità di italiani, e portare all’attenzione in articoli di fuoco le loro dure condizioni di vita. Morì nel 1921, mentre si trovava a Buenos Aires addirittura con l’incarico di Ministro Plenipotenziario presso l’Ambasciata Italiana. Dopo essere stato un giramondo per tutta la sua esistenza, quest’uomo dall’instancabile curiosità fu seppellito nel paese natale nel suo Polesine, accanto alla tomba di Alberto Mario.
Prima di lasciarvi alla lettura di quest’opera, secondo noi parecchio godibile, ci sia concessa una riflessione finale. Dal momento che rifuggiamo la retorica, ci asterremo dal pronunciare frasi roboanti sulla società multietnica, né è nostra intenzione negare le difficoltà e i conflitti, a volte drammatici, che provocano i flussi migratori. Ci limiteremo a una scarna osservazione. A seconda delle stime, oggi il numero dei cittadini degli Stati Uniti di origine italiana oscilla tra i 16 e i 20 milioni. L’attuale sindaco di New York porta un cognome italiano, e non è il primo nella storia. Cognomi italiani si trovano un po’ ovunque tra le celebrità di ogni campo, nel cinema, nella musica, nello sport. Lo stesso si può dire di tante altre nazionalità che cento anni or sono alimentavano l’emigrazione verso l’America del Nord.
Ebbene, contrariamente alla convinzione dell’autore del passo citato all’inizio di questa prefazione, non risulta che l’America ne abbia tratto detrimento. Forse varrebbe davvero la pena di spendere qualche minuto della nostra giornata a pensarci.
Marcello Donativi