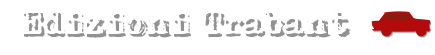Prefazione a
Nel regno della mafia – Napoleone Colajanni
La mafia non esiste.
Quante volte nella storia d’Italia abbiamo sentito questo ritornello da parte della gente di strada, sui giornali, persino in Parlamento. Un atteggiamento di sufficienza o finta ingenuità che portava Leonardo Sciascia a mettere in bocca a un suo personaggio simili affermazioni:
“Questo qui, caro amico, è uno che vede mafia da ogni parte: uno di quei settentrionali con la testa piena di pregiudizi, che appena scendono dalla nave-traghetto cominciano a vedere mafia dovunque… (…) ma vi capisco: non siete siciliano, e i pregiudizi sono duri a morire. Col tempo vi convincerete che è tutta una montatura”.
E più avanti:
“Ma il siciliano che io sono, e l’uomo ragionevole che presumo di essere, si ribellano a questa ingiustizia verso la Sicilia, a questa offesa alla ragione. (…) Ditemi voi se è possibile concepire l’esistenza di una associazione criminale così vasta ed organizzata, così segreta, così potente da dominare non solo mezza Sicilia, ma addirittura gli Stati Uniti d’America…”
Oggi che l’esistenza di una tale associazione è stata non solo dimostrata, ma anche accettata dall’opinione pubblica, sembra incredibile che venissero fatti discorsi del genere. Ma non dimentichiamo che ancora negli anni ‘80 c’era chi parlava con scetticismo di un “teorema Falcone” o in alternativa “teorema Buscetta”: favole, teorie campate in aria. Calunnie nei confronti dei siciliani.
Eppure di mafia in Italia si parla da almeno 150 anni, quando l’unificazione del paese sotto la bandiera sabauda portò la nuova autorità a confrontarsi con la difficile situazione delle regioni annesse; ed è degno di riflessione come questo fenomeno di cui a lungo si è voluta negare la realtà fosse al contrario un fatto bene assodato per gente che viveva – e lo combatteva – più di cento anni fa. Il che ci porta dritto al tema del libro che presentiamo.
Nel Regno della mafia è stato pubblicato nel 1900, ma potrebbe essere stato scritto ieri. Basterebbe già questa constatazione per renderlo interessante.
Il pamphlet prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto nel 1893. Emanuele Notarbartolo, già sindaco di Palermo e personalità molto in vista non solo in Sicilia ma in tutta Italia, il 1° febbraio veniva assassinato da ignoti e il suo corpo gettato giù da un treno. Subito emersero forti sospetti che legavano l’accaduto alla passata esperienza dell’ucciso alla direzione del Banco di Sicilia: in particolare, si parlava di un suo dossier accusatorio sulle attività illecite di alcuni membri del consiglio di amministrazione, inviato al Governo e prontamente fatto scomparire. Presto si riuscì a individuare anche i possibili esecutori materiali e soprattutto il probabile mandante: nientedimeno che un deputato del Parlamento Italiano di nome Raffaele Palizzolo.
Come è facile immaginare con gli occhi smaliziati di oggi, le indagini furono svolte in modo distratto e poco scrupoloso, sino a sfociare – come chissà quante volte in passato – in un nulla di fatto. Soltanto la testardaggine del figlio dell’ucciso, Leopoldo Notarbartolo, riuscì a far riaprire il caso alcuni anni dopo: ma questa volta venne assegnato alla Corte d’Assise di Milano, per quello che oggi chiameremmo “legittimo sospetto” nei confronti dei magistrati di Palermo.
E qui avvenne il fatto. Nel nuovo scenario lombardo, l’opinione pubblica italiana si trovò per la prima volta a confrontarsi con un fenomeno che non s’aspettava, e con parole di cui fino ad allora non conosceva il significato: mafia, omertà, uomo d’onore. Come ci racconta lo stesso Colajanni, i magistrati milanesi constatarono con stupore come le istituzioni siciliane, a partire dalle forze di polizia, i carabinieri, e su fino a prefetti e procuratori generali, avessero intenzionalmente trascurato elementi di indagine, oscurato prove e financo distrutto verbali di interrogatorio. Non soltanto; avviate nuovamente le indagini, gli inquirenti si ritrovarono davanti al classico muro di gomma: testimoni reticenti, finti smemorati o apertamente mentitori, tant’è che furono costretti a procedere nei confronti di molti di loro per falsa testimonianza. Mai prima d’ora ci si era trovati, sotto gli occhi della giovane nazione italiana, di fronte a un caso di giustizia così intricato. Perché i testimoni non parlano? ci si chiedeva con ingenuità. Hanno paura della mafia – era la risposta. Ma gli italiani, questa mafia, proprio non sapevano che fosse.
È questo che spinse un siciliano a scrivere un libbricino dal titolo Nel Regno della Mafia.
Napoleone Colajanni non era uno qualunque. All’epoca dei fatti era da tre anni deputato al Parlamento e non aveva perso tempo a mettersi in luce come un socialista e un agitatore, dando appoggio e guida al movimento dei Fasci Siciliani.
E dire che considerava quello un momento più rilassato della sua vita. La vera fase eroica era avvenuta nella prima gioventù, quando a tredici anni era scappato dalla sua Castrogiovanni per arruolarsi con i garibaldini. Quella volta fu scoperto e riportato controvoglia a casa; ma non passò molto tempo. Nel 1862, ancora minorenne, era con Garibaldi sull’Aspromonte e venne fatto prigioniero; nel 1866 combatté la Terza Guerra di Indipendenza nel 13° Battaglione dei Carabinieri Genovesi; nel ’67 ancora al fianco dell’Eroe dei Due Mondi nel disastro di Mentana. Nel 1869 aderiva a una setta di cospiratori mazziniani chiamata Alleanza Repubblicana Universale e veniva arrestato alla vigilia di una insurrezione.
Poteva essere la fine, ma il caso volle che nello stesso anno nascesse l’erede al trono Vittorio Emanuele III. Fu emanata un’amnistia, e Colajanni poté fare ritorno a casa, ma con tutt’altro animo da quello con cui era partito. Avvertiva quel senso di sconfitta all’epoca molto comune tra i repubblicani e i socialisti che avevano partecipato al Risorgimento, lo stesso misto di disillusione e malinconia che abbiamo già documento a proposito di Alberto Mario. Tuttavia non si ritirò a vita privata: qualche anno più tardi decise di intraprendere la via della carriera politica, non più dall’esterno ma dall’interno del “sistema” (per usare un termine del tutto anacronistico). Era il 1878 quando ottenne il primo incarico a livello locale, consigliere municipale di Castrogiovanni; nel 1890 finalmente entrava nel Parlamento Italiano.
E incominciò a fare rumore. Tanto per dirne una, appena qualche mese prima del caso Notarbartolo, il 20 dicembre 1892, un suo discorso alla Camera a proposito dello scandalo della Banca Romana aveva creato uno scossone tale da far cadere il governo, quasi una sorta di Tangentopoli di età umbertina. E nello stesso periodo, con una instancabile attività di politico e giornalista, denunciava con forza le storture dello stato unitario, lo spaccamento del paese in due tronconi nord e sud, lo sfruttamento del proletariato contadino meridionale. Un gran bel rompiscatole, insomma; fondamentalmente un idealista, di quelli che oggi ci farebbero tenerezza, se non ci rendessimo conto di averne un bisogno disperato.
Basti dire che del socialismo aveva un’idea tutta propria, tanto eterodossa da farlo allontanare dai movimenti operai quando avrebbe preso piede il marxismo, e da spingere Gramsci a definirlo “un nemico del socialismo”. Non si considerava materialista: secondo lui la questione sociale non era soltanto un fatto economico, ma anche etico. Perciò rifiutava il concetto di lotta di classe: la lotta esisteva, certo; ma era soltanto la prima fase dell’evoluzione, che non andava incoraggiata, ma superata a favore di una maggiore diffusione dell’Altruismo. L’obiettivo era sì l’uguaglianza: ma non poteva significare un livellamento verso il basso.
Posizioni inconciliabili con il marxismo, che lo portarono ad avvicinarsi dapprima al neonato Partito Repubblicano, e successivamente a provare una certa simpatia per il fascismo nella sua iniziale fase sansepolcrista. Ma la morte, avvenuta nel 1921, in un certo senso lo salvò da questa imbarazzante adesione. O forse gli impedì di prendere in un secondo momento le distanze. Non lo sapremo mai.
La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è cosa spingesse questa sorta di Don Chisciotte ottocentesco ad affrontare lo spinoso problema della mafia, e cercare di spiegarne la natura e le origini. L’impegno politico, certo; l’indignazione per la giustizia corrotta nella propria regione; le evidenti collusioni del fenomeno con la classe dirigente nazionale.
Ma c’è un’altra non trascurabile ragione.
In quei primi decenni dello stato unitario era avvenuto il fatale incontro tra nord e sud dell’Italia: e in un certo senso si era trattato di un evento traumatico, tanto che un personaggio insigne come Massimo D’Azeglio si era lasciato andare a quella infelice battuta secondo cui “unirsi ai napoletani è come andare a letto con un lebbroso”. Le regioni del sud apparivano ai settentrionali come selvagge, incivili, dominate dalla delinquenza e dall’anarchia. Pareva che una spaventosa incomunicabilità impedisse ai due mondi di capirsi: e i fenomeni di delinquenza organizzata come il brigantaggio e la mafia non erano certo d’aiuto.
Fu la neonata scienza positivista a fornire un tentativo di spiegazione. Nel 1876 veniva pubblicata la prima edizione de L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia legale ed alle discipline carcerarie di Cesare Lombroso: il testo che nel nostro paese fondava l’antropologia criminale. Le tesi di Lombroso, pur nella loro complessità, potevano riassumersi così: certi uomini sono naturalmente portati al delitto in misura maggiore rispetto ad altri, a causa di specifiche differenze nella struttura biologica; quindi bontà e malvagità sono caratteri innati nell’individuo e nelle razze umane. Lo studioso, che con questa brillante intuizione raggiunse fama e onori oltre ogni dire, individuò anche alcune di queste differenze biologiche tra i buoni e i cattivi; e celebre rimane, ad esempio, quell’escrescenza interna della scatola cranica che Lombroso riteneva sicuro segno distintivo degli assassini (per chi fosse curioso, un esemplare è tuttora conservato presso il Museo Criminologico di Roma).
Per quello che ci riguarda più da vicino, invece, l’antropologia criminale ricorreva a categorie di ordine climatico. Detto in poche parole, sosteneva che con il caldo in una determinata regione fosse proporzionale alla tendenza dei suoi abitanti a delinquere. Quindi i popoli che vivevano nel meridione d’Europa erano per loro natura potenziali ladri, menzogneri e omicidi; e ciò era una spiegazione sufficiente al fenomeno della mafia.
È difficile capire come una teoria del genere potesse essere accolta con rispetto negli ambienti accademici italiani; più facile comprendere come risultasse offensiva per gli intellettuali meridionali. E proprio contro Lombroso si scagliò più volte la vena polemica di Colajanni: nel 1885 scriveva La delinquenza in Sicilia e le sue cause; meno di dieci anni dopo Latini e Anglosassoni – razze inferiori e razze superiori, stoccata più generale contro il razzismo. Tra le due, il nostro Nel Regno della Mafia, con le sue allusioni dirette o indirette alle teorie positiviste.
L’approccio di Colajanni, infatti, è di gran lunga più razionale di quella scienza che sosteneva di porre la ragione alla base di sé. Secondo lui le origini della mafia non vanno rintracciate in tendenze “innate” o “biologiche” del popolo siciliano, bensì nella travagliata storia antica e recente di questa isola. La mafia – sostiene in un punto illuminante – non è necessariamente un’organizzazione criminale: è prima di tutto la forma mentis di un popolo, un sentimento medioevale nato e sviluppatosi come unica forma di sopravvivenza a secoli di dominazione straniera, di ingiustizia e anarchia. In Sicilia esiste la mafia perché i siciliani si sono dovuti abituare all’idea di non avere un governo degno di questo nome e dover sopperire da sé, secondo schemi di giustizia che non hanno mai conosciuto alcunché di moderno. E quel che è peggio, la mafia continua a esistere perché l’assenza dello stato non è mai stata colmata.
È questo uno snodo fondamentale della ricostruzione di Colajanni. È da questa constatazione che prende piede la parte più polemica del suo libello, tesa a ricostruire gli innumerevoli e abnormi errori compiuti dai reami che si sono succeduti al governo della Sicilia, a partire dai Borboni per finire ai Savoia. Quando traccia brevemente una storia dell’amministrazione della giustizia in Sicilia dal ‘700 ai suoi giorni, altro non fa che enumerare una lunga lista di decisioni incomprensibili, provvedimenti sbagliati, corruzione e abuso; e sul banco degli imputati finiscono non soltanto i malviventi, ma anche e soprattutto i governanti che non li hanno perseguiti o addirittura ci sono andati a braccetto per i propri fini.
Qui risiede la profonda attualità di questo testo, anche se preferiremmo che non fosse più attuale. La Sicilia descritta da Colajanni è una regione in cui il potere politico, anziché combattere la delinquenza organizzata, spesso se ne serve per ricevere voti. Lo dicevamo all’inizio: sembra scritto ieri.
In verità la vicenda Notarbartolo proseguì ancora dopo la pubblicazione di Nel regno della Mafia, e senza lieto fine. Nel 1902 la Corte d’Appello di Bologna condannava Raffaele Palizzolo a 30 anni di carcere; ma nel 1904 la Corte d’Appello di Firenze annullava la sentenza per un semplice vizio di forma. Quando fu comunicata la notizia dell’assoluzione, in gran parte della Sicilia si festeggiò: numerosi erano stati i comitati creati per difendere il “buon nome dei siciliani” dalle calunnie a cui venivano sottoposti dal processo. Quella sentenza significava per loro un fatto chiaro: la Giustizia italiana decretava ufficialmente che la mafia non esiste.
E questa infelice conclusione può restare come prova dell’esattezza delle intuizioni del nostro autore. Sui modi in cui sconfiggere la mafia nel corso dell’ultimo secolo si è detto tutto e il contrario di tutto, compresi i più utopistici castelli in aria. Ma forse la ricetta migliore è stata suggerita da Colajanni alla fine di questo libretto: “Per combattere e distrurre il regno della Mafia è necessario, è indispensabile che il governo italiano cessi di essere il Re della Mafia”.
Marcello Donativi