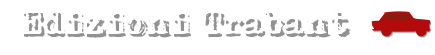Prefazione a
I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli – vol. I – Giuseppe Buttà
Emilio Solfrizzi, vestito dei panni di Ferdinando IV di Borbone, compie fino in fondo il suo dovere, come chiestogli dal soggetto e dalla tradizione popolare. Al suo primo apparire nello sceneggiato televisivo Luisa Sanfelice, il re è seduto nel palco riservato al teatro San Carlo, davanti alla tavola su cui gli hanno servito degli ovvi “maccheroni c’a pummarola”. Ferdinando è proprio come la gente si aspetta che sia: pingue, col caratteristico naso che gli valse il soprannome di Re Nasone, stravaccato sulla poltrona in un una maniera scomposta che stride con la sberluccicante divisa. D’altra parte, l’abito è per metà coperto da un gigantesco tovagliolo infilato nel colletto.
Come inizia a parlare, si rivela ancora di più conforme al modo in cui la storia ha voluto tramandare la sua figura: scostante, collerico, cinico al punto che, informato delle nuove sconfitte subìte dal suo esercito a opera di 20.000 francesi e volontari italiani (sic), alza il calice e brinda: «A quei poveri coglioni in divisa bianca!».
E anche nella restante parte dello sceneggiato, tutto continua a soddisfare il modo in cui l’uomo comune è portato a immaginare gli eventi del 1799: i borbonici sono gretti, volgari o al più freddi calcolatori come il famigerato cardinale Ruffo; i loro seguaci, masse informi di straccioni sanguinari e superstiziosi; dalla parte opposta vi sono gli eroi, giovani e belli come ci si aspetta che siano; nobili d’animo, pieni di discorsi fascinosi sulla libertà.
Per ovvie ragioni Giuseppe Buttà, morto nel 1886, non poté assistere a tali rappresentazioni postume della storia delle Due Sicilie. In ogni caso non ne sarebbe stato stupito. D’altra parte, lo sceneggiato è basato sul romanzo di Alexandre Dumas, autore che Buttà conosceva, senza nutrire nei suoi confronti la benché minima stima. Un vendifrottole: così lo definisce in un passo de Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta. Lo scrittore francese, infatti, infatuato dalla figura di Giuseppe Garibaldi, aveva in parte finanziato la spedizione dei Mille; successivamente aveva raggiunto l’esercito garibaldino, e al suo seguito era arrivato fino a Napoli, sorta di poeta di corte del Dittatore. L’ironia di Buttà a tal proposito è tagliente:
Venne a Milazzo il romanziere Dumas, a cui Garibaldi, sotto lo specioso titolo che avesse comprato 1500 fucili, avea dato delle lettere per esigersi dal tesoro di Palermo centomila franchi. Il sindaco Verdura non volle pagarli, il Prodittatore ne pagò sessantamila. Il Dumas inebbriato di quella non lieve somma, scrisse e stampò sul fatto d’armi di Milazzo menzogne sperticate, cose delle Mille ed una notte. Descrisse Garibaldi un Orlando furioso per la forza, un Federico II di Prussia e un Napoleone 1° per la strategia militare. Fra le altre cose narrò che avea veduto innumerevoli schiere di soldati napoletani combattere in Milazzo contro duemila e cinquecento ragazzi garibaldini. Fu questo un fenomeno ottico prodotto da que’ be’ sessantamila franchi, perchè non erano di carta straccia, ma luccicavano, ed aveano la immagine del tiranno di Napoli.
E anche più avanti, nell’opera, sottolinea spesso di considerare Dumas niente più di un propagandista prezzolato. D’altronde, quando nella seconda metà degli anni ‘70 del XIX sec. il sacerdote Giuseppe Buttà, ex cappellano militare dell’Esercito Borbonico, reduce della guerra contro Garibaldi prima e l’esercito piemontese poi, capitolato di Gaeta e per anni esiliato a Roma per le sue idee filo-borboniche, si accingeva a scrivere una storia dei Borboni di Napoli – l’opera che qui presentiamo – era perfettamente consapevole di lottare contro una fitta schiera di scrittori che nel corso del tempo si erano prefissati di dare della casa regnante di Napoli il peggior ritratto possibile. Quel ritratto che nella coscienza popolare si è talmente radicato fino ad arrivare ai nostri giorni.
Inutile nascondersi dietro un dito: Buttà era assolutamente di parte in proposito. L’intera sua vita era stata caratterizzata dalla fedeltà al Regno delle Due Sicilie, nel cui esercito, sia pure come cappellano, aveva militato. L’esperienza della campagna militare 1860-61, inoltre, aveva lasciato molte ferite aperte nel suo animo: era stato traumatizzante assistere allo spettacolo di un regno che nel giro di pochi mesi si scioglie come neve al sole, il cui numeroso esercito si arrende davanti a un nemico teoricamente più debole in mezzo a una tale mole di errori strategici e lassismo da lasciare più di un ragionevole sospetto di tradimento da parte degli alti ufficiali. Era stata questa la molla che aveva spinto il reduce a farsi scrittore, con la stesura della sua monumentale storia della campagna di Garibaldi vista dall’ottica dell’esercito sconfitto.
In ogni caso, Buttà non era tanto ingenuo da ignorare il fatto che, se così tante persone avevano favorito gli avversari del regime borbonico, ciò era dovuto anche a una assillante campagna propagandistica, la quale, pur cresciuta negli anni immediatamente precedenti alla guerra (si pensi alle famigerate lettere di Lord Gladstone), non per questo aveva abbassato la guardia nel momento in cui il nemico era vinto. Negli anni immediatamente a ridosso della spedizione di Garibaldi, infatti, non erano soltanto opere apologetiche dei Mille a trovare il successo del pubblico, ma veniva licenziata anche una folta pubblicistica con l’intento di screditare non solo gli ultimi Borboni, che avevano di recente perduto il regno, ma l’intero casato e la sua storia, come a dare una giustificazione postuma al suo abbattimento.
Nel 1860 Giovanni La Cecilia dava alle stampe la sua storia dei Borboni di Napoli; nel 1865 era il turno del già citato Alexandre Dumas con un’opera dallo stesso titolo; e altre pubblicazioni dal taglio più o meno simile fioccavano in quegli anni, tutte – quale più quale meno – caratterizzate dallo stesso leitmotiv: dare dei Borboni di Napoli un’immagine a metà strada tra la macchietta e il cattivo dei romanzi gotici; come dire, una sorta di pulcinella sanguinari e incestuosi.
Giuseppe Buttà avvertiva dunque il dovere di ribaltare questa immagine così negativa; e tuttavia era conscio del fatto che non bastava rispondere ai pubblicisti contemporanei, perché, pur con tutti i loro eccessi e infiorettature romanzesche, costoro erano gli eredi di una tradizione storica sfavorevole ai Borboni che aveva mosso i suoi primi passi già dagli albori dell’800. Il nostro autore individua, perciò, chi sono i primi veri avversari da smentire: Vincenzo Cuoco e, soprattutto, Pietro Colletta. Scrive infatti in un passo della presente opera:
Di tutti gli scrittori rivoluzionarii che calunniarono i Borboni di Napoli, quelli che meritano di essere confutati sono Coco e Colletta, perchè calunniando non lasciano di esser serii e non volendolo dicono molte verità. Gli altri venuti appresso altro non fecero che copiare questi due autori; alcuni aggravandone le tinte, altri inventando altre infamie che non esistettero mai. Si è perciò, che nel corso di questo qualunque siasi lavoro, m’ingegnerò di esaminare varie asserzioni calunniose di questi due storici, e con particolarità del Colletta, essendo costui più conosciuto, e perchè la sua storia comincia da Carlo III e finisce con la morte di Ferdinando IV; mentre Coco tratta dei soli fatti del 1799. Di Gorani, di Dumas, di La Cecilia, e di qualche altro calunniatore, ragionerò qualche volta, o per dimostrar falso qualche documento che i medesimi ci han regalato, o per esilarare un poco i lettori con le loro buffonate storiche.
Il che ci porta ai temi trattati in questo primo volume, che abbraccia il periodo dall’ascesa al trono di Carlo III fino alla morte del suo successore Ferdinando IV (in seguito Ferdinando I). Un tema scottante, giacché il secondo sovrano delle Due Sicilie, regnante nei difficili anni della Rivoluzione Francese e dell’Impero Napoleonico, è forse quello che maggiormente ha subìto le carezze propagandistiche dei suoi nemici. Non che la sua figura poco si prestasse alla burla: designato successore al trono a seguito di una complessa serie di circostanze, senza che nessuno si fosse preoccupato di fornirgli un’adeguata educazione, divenne in breve celebre per le sue maniere spicce, l’uso insistente del dialetto napoletano, quei modi, insomma, da popolano che gli valsero il soprannome di Re Lazzarone.
Ma probabilmente la scure della damnatio memoriae non si sarebbe mai abbattuta su di lui, se non avesse rivestito un ruolo cruciale nella reazione alla diffusione degli ideali della Rivoluzione Francese in Europa. Una colpa imperdonabile: quella di non essersi lasciato mandare alla ghigliottina come il cognato Luigi XVI di Francia. Al di là della battuta, nel segno del tipico sarcasmo di Buttà, resta il fatto che re Ferdinando si alienò le simpatie dei posteri a seguito delle drammatiche vicende del 1799, con il regno invaso dall’esercito francese, l’abbattimento della monarchia a favore della Repubblica e la successiva restaurazione per mano di masse armate di contadini sotto il comando del Cardinale Ruffo; il cosiddetto Esercito della Santa Fede, un altro fenomeno storico più volte dipinto a fosche tinte e interpretato unicamente attraverso categorie come superstizione e violenza criminale.
Buttà doveva essere conscio, nel trattare tali argomenti, di addentrarsi in un campo minato, tanto difficile doveva essere – com’è tuttora – sradicare dall’immaginario collettivo certi postulati così ben fermi. E bisogna in ogni caso sottolineare, come già fatto poc’anzi, come fatto in ogni prefazione da noi scritta alle sue opere, l’assoluta parzialità dell’autore. E però proprio in questo l’opera trova il suo interesse: messi di fronte per anni solo ed esclusivamente a una parzialità di tipo opposto, leggere le parole di un apologeta, anziché di un censore, dei Borboni di Napoli è un utile sforzo per cercare di riequilibrare il nostro giudizio storico. Nel suo dipingere i Borboni non già come dei diavoli partoriti da madre terra, ma come quasi angeli inviati da Dio a reggere la Giustizia, Buttà in ogni caso ci suggerisce delle possibili chiavi di lettura alternative, le quali, se scrostate dalla patina di partigianeria dello scrittore messinese, possono condurci a comprendere alcune scomode verità: quali, ad esempio, il fatto che i Borboni di Napoli abbiano rappresentato non solo e sempre reazione e opposizione al moderno, ma spesso siano stati dei modernizzatori del Regno, sia pure attraverso il riformismo e senza il mantello del Fuoco Purificatore; il fatto che i fenomeni rivoluzionari del XVIII e XIX secolo fossero poco più di colpi di stato a opera di ristrette élite senza un vero seguito né contatto con le popolazioni (la Repubblica Partenopea quasi un governo quisling dell’espansionismo francese; i moti del 1821 una specie di colpo di stato militare); fino allo scandalo estremo, ciò che non si può che sussurrare: e cioè che per un re così infamato come Ferdinando IV il popolo provava un affetto per nulla facile da trovare nella storia, tanto da prodigarsi per il suo ritorno al trono e salutarne la restaurazione come una liberazione nazionale.
Sono temi che apparentemente sembrano lontani dalla sensibilità di noi contemporanei. Eppure, ogni tanto riaffiorano in superficie, a dimostrazione di come la storia sedimenti e lasci sempre e comunque una traccia. Basti pensare ai recenti festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, con il peraltro divertente intervento di Roberto Benigni sul palco di Sanremo, nel corso del quale ha intessuto un ritratto dei Borboni talmente negativo da spingersi a paragonare il loro regno alla dittatura nazista. Dall’altro lato, alcuni ambienti intellettuali meridionali hanno di recente intrapreso un percorso di rivalutazione del Regno delle Due Sicilie, il quale, pur lodevole, si spinge talora a eccessi – non ce ne voglia nessuno – che hanno più del politico che dello storico.
Quale che sia il dibattito ideologico, resta un’ultima considerazione, che è alla base del nostro progetto di proporre in catalogo – per primi nella storia – l’opera omnia del sacerdote di Naso: le sue opere hanno in ogni caso dei meriti letterari. Sorta di Don Camillo ante litteram, spirito combattivo con il gusto della battuta, Buttà ci ha lasciato delle pagine di godibile lettura, che forse avrebbero meritato un sia pur piccolo posto nella memoria dei posteri. No, non era propriamente uno storico, ma di questo era perfettamente consapevole. Lo dimostra uno dei punti dell’opera in cui si lascia andare a una sorta di dichiarazione programmatica:
Taluni poco benevoli alle spirito di questa mia scrittura — e ve ne sono di quelli che han dettato e dettano storie calunniose gremite di falsi documenti — vanno spacciando che io non narro più di quanto abbiano detto altri prima di me. Si sa bene che le storia non si crea, cosa per altro che fanno questi messeri; del resto costoro o non han capito il mio programma o fingono non capirlo; perlocchè credo necessario farlo loro sentire con maggior chiarezza.
È questo un lavoro in cui accenno i fatti positivi avvenuti sotto la dominazione de’ re di Casa Borbone, dando ad essi quel valore che meritano. M’ingegnerò di mondare i calunniati di tanta accuse stupide, sleali e spudorate; e di far note quelle circostanze che gli scrittori malevoli tacciono, perchè in opposizione a quello che essi vogliono farci credere; e ciò dopo di aver travisato la verità storica, inventando circostanze e fatti che non avvennero. Inoltre intendo di mettere in contraddizione quegli autori con sè medesimi; facendo conoscere eziandio quel che furono o sono, cioè che ci han predicato filantropia, e si sono dimostrati oltre misura interessati ed egoisti; si vantano amatori di libertà e di progresso e si sono svelati ciurmadori di liberalismo, intolleranti e triviali tiranni; ostentano onestà e son calunniatori e falsarii. In una parola, questo lavoro è più polemico che storico , giacchè riduce la storia a quello che è stata senza alterazione di sorta; potrò errare ma non per malizia.
Nel licenziare questo primo volume, cui a breve seguiranno altri due, secondo la divisione originaria dell’opera, ci auguriamo pertanto di aver assolto in modo degno il nostro obiettivo: contribuire a diffondere opere meno conosciute non soltanto per la difficile reperibilità, ma a causa del loro contenuto, così da favorire, in questo paese che troppo spesso lo trascura, quell’oscuro e tortuoso esercizio che è il confronto delle fonti. E perché no? Magari anche dilettare i nostri venticinque lettori, che ci piace immaginare come persone che abbiano compreso che forse, tutto sommato, nati non fummo per viver come bruti.
Non ai posteri, ma a voi l’ardua sentenza.
Marcello Donativi