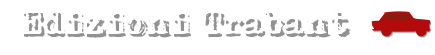Prefazione a
Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta – Giuseppe Buttà
«Spesse volte la gloria rifulge più smagliante sul capo del vinto che su quello del vincitore.» Così al capitolo XI delle sue memorie Giuseppe Buttà, cappellano militare del 9° Battaglione Cacciatori dell’Esercito di S.M. Francesco II, Re delle Due Sicilie.
Purtroppo per lui, il reverendo si sbagliava. Almeno nel caso delle vicende di cui fu testimone, valse l’antico motto latino: vae victis! guai ai vinti!
È un sabato di luglio, quando scendo alla stazione di Formia. Tante volte ho visto Gaeta dal finestrino, senza fermarmi: e sembrava tale e quale alla figura del libro di storia delle scuole medie. Su quei manuali all’avvenimento erano dedicate non più di tre righe; si parlava sbrigativamente di un assedio vittorioso da parte dell’esercito italiano, ultimo atto di una gloriosa epopea chiamata Risorgimento. Però non mancava mai la figura di un curioso promontorio dalla forma di un cumulo di farina, con una fortezza ai piedi; caratteristico il dettaglio di una grossa esplosione. A noi ragazzini quell’assedio era raccontato come una sorta di formalità, un cartellino da timbrare perché fosse portata a compimento l’unità e la redenzione della Patria; e in fondo a rinchiudersi lì dentro era un re tiranno e anche un po’ idiota, meritevole di non altro che l’esilio. Poco ci fermavamo a chiederci se e quante persone fossero morte in quell’episodio; né alcuno veniva a raccontarci che a lasciare questo mondo fossero stati non solo tiranni e soldati di tiranni, ma anche bambini della nostra età. Sepolti sotto le bombe degli “italiani”.
Dal piazzale di Formia un autobus porta a Gaeta. A bordo più che altro giovani diretti alla spiaggia, e qualche anziano. Gaeta non è posto da turismo.
E infatti di quell’episodio non rimane oggi quasi nulla. Non una targa, non un cartello che possa far pensare a un luogo storico. Soltanto un paio di ristoranti cercano di sfruttare il passato: insegne come “La taverna dei Borboni” o “Osteria di Federico”. Per il resto il paese è un placido posto di mare, con le navi ancorate nel porto e l’acqua abbastanza pulita da consentire di nuotare fra l’una e l’altra. Eppure, spesso tra gli edifici si intravede qualche casa diroccata; si incontrano muri che non finiscono, arcate solitarie in mezzo alle erbacce, resti di costruzioni che pochi si chiedono perché siano andate incontro a una tale rovina. Addentrandosi per i vicoli del colle, molte facciate sono tuttora bucherellate qua e là nell’intonaco. Strana forma di erosione, inspiegabile secondo l’azione del vento, molto di più secondo l’esplosione di uno shrapnel. Nella piazza centrale due lapidi su opposti palazzi ne specificano i costruttori: “questi edifici furono eretti dal Re tal dei tali della dinastia Borbone nell’anno tale etc. etc.”. Leggo e penso: non sono edifici; sono casematte. Ci si rifugiava durante i bombardamenti.
Dopo un’ora a vagare senza costrutto, decido di fare ritorno. Aspetto l’autobus ai giardinetti di fronte al mare. Nel mezzo, un monumento contornato da mitragliatrici d’epoca ricorda i caduti nella Prima Guerra Mondiale. Caduti per la Patria che nacque in questo luogo nel febbraio del 1861; anche se i più preferiscono pensare che sia nata più a sud e qualche mese prima, a Teano.
D’altra parte, chi dovrebbe ricordare quell’episodio? I testimoni sono morti da più di cento anni. Parecchi fra loro, dopo l’Unità d’Italia, continuarono per anni a raccontare la loro storia, in mezzo a mille difficoltà, censure, persecuzioni poliziesche. In tanti scelsero la via dell’esilio; gli altri, i più bisognosi, si piegarono al nuovo status quo, in molti si arruolarono nel nuovo esercito italiano; ma spesso senza rinunciare a scrivere sul biglietto da visita: reduce da Gaeta. Con l’orgoglio di chi ha compiuto un’impresa eroica, sventurata ma tale da rimanere negli annali.
E invece no. Il tempo ha lentamente coperto la portata degli avvenimenti, la retorica ha stabilizzato quale dovesse essere la versione dei fatti. Come se non bastasse, è arrivato il fascismo a esasperare ancor di più il Mito della Nazione. Dopo la guerra, tanto peggio: la nuova Italia repubblicana aveva bisogno della leggenda di Garibaldi ancor più di quanto non ne avesse lo stesso fascismo.
E così sono stati istituzionalizzati una serie di concetti: il Regno delle Due Sicilie era un’abominevole dittatura; re Ferdinando II era un vampiro, suo figlio Francesco II un imbecille; Vittorio Emanuele II al contrario un galantuomo; i garibaldini erano prodi, leali e coraggiosi; i soldati napoletani codardi e debosciati; e tutti quelli che provarono opporsi all’unità erano retrogradi reazionari o poveri ignoranti sobillati dalla propaganda clericale.
Ma noi, oggi, possiamo dire di avere realmente guadagnato da questa cloroformizzazione della storia nazionale? Quanto ci conviene continuare a ignorare la voce di quanti all’epoca non ne volevano sapere dell’unificazione italiana?
La presente opera fu originariamente pubblicata nel 1875 sul periodico La Discussione. L’autore, testimone oculare della disfatta dell’esercito napoletano, si dichiarava spinto a parlare dalle insistenze degli amici. Un espediente retorico, evidentemente: ciò che lo anima è invece la smania di far sentire la propria versione dei fatti. La sua incrollabile fede nella Provvidenza divina lo rendeva certo che un giorno la « storia imparziale » avrebbe reso giustizia di tanti soprusi e persecuzioni patite.
Giuseppe Buttà era nato a Naso, provincia di Messina, il 4 gennaio 1826. Egli stesso ci confessa di aver attraversato da giovane una fase di ardore liberalesco, durante la quale si era convinto che fosse necessario l’abbattimento della monarchia borbonica; ma dovette presto cambiare idea, se è vero che tra gli anni ’40 e ’50 del XIX secolo lo troviamo prima ordinato sacerdote e successivamente cappellano militare del Reale Esercito. Il suo primo incarico, non privo di conseguenze, fu presso il bagno penale di S.Stefano, esperienza durante la quale poté fare la conoscenza di tanti rivoluzionari liberali incarcerati; personalità come Luigi Settembrini, Silvio Spaventa e Carlo Poerio, che il canonico si vanta di aver spesso protetto e difeso perché fosse alleviata la durezza della loro detenzione.
Nel 1859 fu assegnato al 9° Battaglione Cacciatori stanziato nella sua Sicilia: e da qui ebbe origine l’esperienza che cambierà la sua vita. La particolarità del corpo d’armi cui apparteneva, e della posizione geografica in cui era operativo, fecero sì da fargli vivere da vicino l’intera esperienza della spedizione di Garibaldi. Buttà si trovava a Palermo durante la lotta strada per strada per la conquista della città; era alla battaglia di Milazzo con il suo amato colonnello Beneventano del Bosco; e così via retrocedendo al seguito dell’esercito borbonico in rotta, a Napoli, Capua, fino alla Gaeta assediata dai Piemontesi.
Dopo la caduta della città decise di seguire la sua truppa, destinata a rimanere prigioniera fino alla completa resa dell’esercito meridionale. Ottenuta la libertà, fu però perseguitato dalla polizia italiana quale sospetto cospiratore reazionario; destino comune a molti reduci di Gaeta. E lo stesso Buttà ci racconta con risentimento di aver chiesto l’aiuto di Spaventa nel nome degli antichi favori resigli a S.Stefano, e come questi facesse finta di non riconoscerlo (cap. XXV).
Ricercato in patria, fuggì a Roma, dove si trovava Re Francesco in esilio. Un gustoso aneddoto ce lo rappresenta nel 1866 quasi ubriaco di gioia alla notizia della disfatta italiana di Custoza. Ma quel che più conta, durante il suo soggiorno romano, dietro le insistenze degli amici, mise mano alla penna.
Aveva in mente al principio di raccontare soltanto le proprie esperienze personali, legate a « que’ tempi di rivoluzione e di invasione straniera »; e allo scopo aveva sottratto a un cassetto alcuni appunti presi durante la campagna militare del 1860-61, scritti alle volte nel corso della battaglia stessa, adoperando come scrivania la schiena del proprio attendente. Nella prefazione prometteva di non lasciarsi trascinare dalle passioni e garantiva che queste col tempo si fossero affievolite.
Ma era una linguaccia salace il Buttà; se non lo sapessimo siciliano l’avremmo detto un tosco di quelli all’antica maniera. Man mano che scriveva prendeva piede lo sdegno, e con lo sdegno il bisogno di approfondire, documentarsi per completare il racconto con quegli avvenimenti a cui non aveva avuto il privilegio di assistere. Di qui la consultazione di numerose opere, il contatto epistolare con altri testimoni, la richiesta di documenti, prove. E col progredire della ricerca, le passioni che aveva detto affievolite si riaccendevano rapidamente.
Ne scaturì un racconto torrentizio dell’unificazione italiana, impietoso verso tutto e tutti: i rivoluzionari innanzitutto, il Piemonte di Cavour in special modo, ma anche e non secondariamente gli elementi dell’esercito borbonico che avevano sposato la causa unitaria: « vili e traditori ». Non un’epopea eroica, dunque, ma una dolente inquisitoria nei confronti di un mondo impazzito che si dà all’anarchia e alla guerra: il gran Carnevale d’Italia, come lo definisce nelle ultime pagine.
Piacque molto l’opera, tanto che fu presto raccolta in volume e successivamente ristampata; ma suscitò anche un vespaio di polemiche, e non tanto tra gli unitari, che avevano già vinto e poco potevano curarsi delle lagnanze di un esule, ma tra i reduci chiamati in causa, e colpiti dal sarcastico sacerdote dall’accusa di essere ora vigliacchi, ora traditori.
Buttà ebbe il suo momento di fama, tanto da essere spinto a scrivere ancora sull’argomento: un altro saggio storico, I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli, e un romanzo; più una terza opera promessa ma mai portata a compimento, dal titolo Perché cadde il Trono di Napoli.
Poi il tempo ha cancellato ogni cosa. Il reverendo, ritornato finalmente dall’esilio, morì nel 1886 nel suo paese natale; e sulla sua testimonianza cadde il velo del silenzio. Nella Storia di Naso del 1938 – come sottolineava Leonardo Sciascia – il suo nome è accennato di sfuggita, e liquidato con pochi cenni, senza né titoli delle opere né, figuriamoci, riferimento ai contenuti.
Fu dunque tutto inutile, e la sua convinzione di rendere testimonianza alla verità un’illusione bella e buona?
Non del tutto. Un nuovo interesse si sta sviluppando negli ultimi anni nei confronti di una rilettura del Risorgimento. Lentamente si sta portando all’attenzione generale quanto di imbarazzante vi fu anche nel contegno dei Padri della Patria; e tante valutazioni, fino ad ora ritenute esclusiva di una ristretta cerchia di fanatici un po’ folcloristici, iniziano a godere di maggiore considerazione. Punto cardine di questo processo, il recupero della letteratura antiunitaria, tanto a lungo dimenticata. Nel bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, e a una manciata d’anni dal centocinquantesimo anniversario dell’unificazione, sembra che gli italiani siano più disponibili a uno sguardo critico sul proprio passato, che implichi anche la cessazione della damnatio memoriae sulla storia dei Borboni di Napoli e dei loro sostenitori.
È questo il motivo per cui vale la pena di leggere la presenta opera. Nella quale troveremo spesso versioni dei fatti divergenti da quelle a cui siamo abituati, giudizi sprezzanti su personaggi storici considerati “i buoni” e ammirevoli sui “cattivi”, lunghe requisitorie nel nome di convinzioni che oggi possono sembrare antiquate se non proprio retrograde. Qualcuno magari sobbalzerà a sentir definire la spedizione di Garibaldi non una gloriosa pagina di storia, ma una « striscia di sangue che bagnò la via da Boccadifalco a Gaeta ». Eppure il libro va letto, giacché fosse vero anche solo il 10% di quanto asserito, diventa un qualcosa di cui non si può non tenere conto.
Il Buttà è un conservatore. Sacerdote, cappellano militare, è nemico convinto del liberalismo, e difensore a spada tratta della monarchia assoluta dei Borboni; sostenitore (com’è ovvio, per un prete del XIX sec.!) dei diritti temporali della Chiesa Cattolica; un romantico che ama parlare di valori come fedeltà al giuramento e al Sovrano, onore militare, rispetto della legge.
Un odioso reazionario, dunque? Un accigliato conservatore? Macché.
A noi è simpatico. Egli è tutto fuorché un arrabbiato. Certo, la sua cronaca fu a suo tempo definita – e non senza fondamento – di “ineguagliabile parzialità”. Ma – sottolineava ancora Sciascia – è sì parziale, ma non in modo “ineguagliabile”: lo è almeno allo stesso livello di quanto non lo siano le memorie di garibaldini come Giuseppe Bandi, o l’autobiografia dello stesso Garibaldi.
Ma in Buttà tutto, anche le più odiose insinuazioni, è accompagnato da un’ironia in grado di strappare un sorriso ai meno permalosi. Da conservatore qual è, osserva i palpiti rivoluzionari, ascolta i discorsi patriottici, la retorica nazionalista, le promesse di libertà, uguaglianza e progresso, e semplicemente non ci crede. Non perché le ritenga necessariamente immorali e contro natura; ma più perché le ritiene promesse da marinaio. E Garibaldi, in fondo marinaio lo era.
I numerosi discorsi del Dittatore sono per lui « cicalate ». La sua intensa attività legislativa, una forma di « decretomania ». E quando per legge viene stabilita la « libertà di dogma », osserva: « Ed in verità questi due termini, dogma e libero esame parmi che fanno a calci! » (cap. XXVII). O ancora si prendano ad esempio i numerosi discorsi che riporta, come quello di Cavour al cap. XXXIV, puntualmente accompagnati dai suoi irriverenti commenti fra parentesi. E non si pensi di sottovalutare anche la sua – apparentemente inaccettabile – condanna dell’epoca delle rivoluzioni seguita al 1789: quando nel capitolo finale fa un consuntivo disastroso delle conseguenze delle riforme liberali, sembra che stia descrivendo la nostra epoca, e non la sua.
Molto ci sarebbe da dire, parecchie osservazioni anche critiche nei suoi confronti; ad esempio sull’atteggiamento paranoico (condiviso con molti reazionari dell’epoca) che vedeva gli avvenimenti della rivoluzione come frutto di un complotto internazionale massonico e anticlericale; più e più volte chiama i liberali settari. Incapace di comprendere le dinamiche culturali che portarono all’Unità, ancorato al legittimismo di tipo divino, Buttà non riesce a spiegare l’adesione di così tanta gente al movimento nazionale se non tramite le categorie del complotto e dell’ambizione personale. Ma sarebbe sbagliato sottovalutare alcuni di quelli che possono apparire eccessi dietrologici: il tema del tradimento da parte dell’alta ufficialità borbonica, così dibattuto con insistenza all’indomani dei fatti, viene oggi lentamente ripreso in considerazione dagli storici, e non più liquidato come una favoletta.
Comunque la si pensi, resta un dato di fatto, che non possiamo più continuare a ignorare: l’unificazione dell’Italia non è stata l’allegra scampagnata a suon di fanfare e sventolio di bandiere che ci hanno dipinto per anni; né la realizzazione tardiva di un desiderio radicato nelle popolazioni della penisola. Si è trattato invece di un evento controverso, sanguinoso, che ha messo contro italiani e italiani e ha lasciato dietro di sé uno strascico irrisolto di problemi, frustrazioni di cui non riusciamo tuttora a liberarci; come fosse un trauma collettivo che non superiamo perché abbiamo rimosso il ricordo della sua causa. Negli anni successivi all’Unità, decine di opere come la presente furono pubblicate, in forma aperta o clandestina, anonima o firmata. I libri di Giacinto de’ Sivo, il pamphlet di Tommaso Cava, l’appassionata ricostruzione di Raffaele de Cesare, il quale pur unitario e liberale non riesce a nascondere un pizzico di nostalgia per un mondo che è crollato nel giro di un mattino. E quando l’anonimo autore deI Napoletani al cospetto delle nazioni civili grida con dolore che la sua terra ha perso l’indipendenza ed è tornata al tempo dei viceré spagnoli, forse dovremmo interrogarci sui motivi di questo sconforto, prima di liquidarlo come becero spirito reazionario.
Davanti a questo dato di fatto, abbiamo due possibilità.
Una, continuare a nascondere la testa nella sabbia e bere una ricostruzione della storia parziale, retorica e – diciamola tutta – oramai un ferrovecchio; storia fatta di tamburini sardi, vedette lombarde, elmi di Scipio e via dicendo.
La seconda opzione, iniziare a rispolverare anche le ragioni degli sconfitti; leggere le loro testimonianze; non necessariamente condividere, ma quantomeno stare ad ascoltare. E cercare finalmente di capire da dove veniamo: l’unica cosa rispettabile che un popolo serio possa fare.
Marcello Donativi