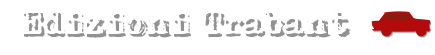Prefazione a
Memorie di un boia – Mastro Titta
“Quella der boja è una missione. Perché ammazza’ un omo ner nome della giustizia nun è come scanna’ uno dentro a un’osteria quanno se sta’ bevuti, è ‘na cosa diversa. Perché tu ammazzi un omo che nun t’ha fatto gnente. Quindi lo fai senza odio, senza rancore, anzi con una certa educazione, un certo garbo: – Permette? – Prego! Zac! Je stacchi la testa e bonanotte.”
Così filosofeggiava un indimenticabile Aldo Fabrizi in una delle prime scene di Rugantino, l’altrettanto indimenticabile commedia di Garinei e Giovannini. Fabrizi dichiarò più volte: farei Mastro Titta a vita.
E infatti ancora oggi la figura del boia di Roma resta legata a quella straordinaria interpretazione. A teatro Mastro Titta è il proprietario di un’osteria, divenuto boia del Papa per arrotondare i guadagni e per questo abbandonato dalla moglie e preso in giro dai Romani. Come è stato fatto notare, rappresenta il prototipo del ceto medio, l’uomo tranquillo che sogna una donna in casa e un fiasco di vino sul tavolo ed è disposto a qualunque lavoro pur di racimolare due lire. Facendosi pagare pro capite, cioè, con secondo la traduzione di Fabrizi, “un tanto a capoccia”.
Ma chi era davvero Mastro Titta? Le notizie certe scarseggiano, e per i motivi che esporremo poco ci vengono in aiuto le presenti memorie.
Al secolo si chiamava Giovan Battista Bugatti ed era originario di Senigallia, dove nacque il 6 marzo 1779. Dai documenti risulta che esercitò la professione di boia tra il 1796 e il 1864, totalizzando 516 tra esecuzioni capitali e punizioni corporali. Essendo forse l’unico professionista disponibile, fu al servizio sia dei Papi che degli invasori francesi, dai quali apprese l’utilizzo della ghigliottina. Smessa l’attività, poté godere di una pensione di 30 ducati al mese; morì infine il 18 giugno 1869. Di lui restano alcune stampe dell’epoca che lo ritraggono all’opera, una ghigliottina e il mantello rosso che indossava nelle occasioni ufficiali, reperti conservati nel Museo Criminologico di Roma.
Tutto qui? Tutto qui. Ma sarebbe ingeneroso limitare a queste poche righe una figura che, al contrario, ai contemporanei era celeberrima. Basti solo a dire che il suo soprannome gli sopravvisse e continuò genericamente a indicare qualunque boia esercitasse a Roma. Persino in maniera retroattiva: in un sonetto, Gioacchino Belli chiama “Mastro Titta” l’autore di un’esecuzione avvenuta molto prima che il nostro nascesse.
Per capire bisogna andare con la mente al sistema giudiziario dell’epoca. Era un periodo per così dire di transizione, in cui certe usanze barbare erano lentamente ma non ancora del tutto abbandonate. Gioverebbe ricordare come la pena di morte nel nostro paese sia stata definitivamente abolita soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e come in questo siamo stati all’avanguardia in Europa. Nella Roma papalina era ancora in vigore il concetto che la morte dei rei dovesse servire da esempio ai sudditi. Questo comportava in primo luogo che l’evento fosse pubblico, con richiamo del maggior numero di persone; in secondo luogo, prevedeva – nei casi più gravi – appendici cruente come la mutilazione del condannato e l’esposizione al pubblico (su ponti, porte o sullo stesso patibolo) delle membra dissezionate. L’unica concessione alla modernità del secolo consisteva nel fatto che lo squartamento e la dissezione avvenissero dopo la morte del condannato, avvenuta per impiccagione o taglio della testa.
L’esecuzione capitale era dunque un avvenimento di pubblico interesse, che attirava la folla e la coinvolgeva emotivamente in miriadi di sfumature. Non necessariamente su basi di sadismo: sarebbe ingiusto immaginare, come spesso si fa, il pubblico intento a dileggiare e umiliare il condannato. Anzi, spesso la folla aveva interesse a sorvegliare il boia, che facesse bene il suo dovere, senza cioè far soffrire troppo il malcapitato: non mancano esempi di pubblico inferocito che cerca di picchiare un carnefice maldestro. Altro motivo di curiosità era sapere se il reo avesse accettato o meno la confessione religiosa – dando così esempio di pentimento – e fonte di ammirazione quando andava incontro alla morte con dignità e animo sereno. Un pubblico spettacolo, insomma, che certo ci appare disgustoso, ma che – ammettiamolo – toccava corde emotive ancora oggi presenti nella morbosità con cui vengono seguiti certi fatti di cronaca.
Riflettiamo su qualche dato statistico: considerato che Mastro Titta compì 516 esecuzioni tra il 1796 e il 1864 (di cui 55 per i francesi e le restanti per il Papa) e il suo successore 12 fino al 1870, anno della caduta del governo papale, ne conseguono 528 condanne a morte nell’arco di 74 anni, per una media di circa 7 l’anno. Dati che – comunque – vanno riferiti all’intero Stato Pontificio e non alla sola Roma. Si capirà dunque come la figura del boia fosse familiare ai romani. In un altro sonetto, il Belli ironizza sugli “specialisti del patibolo”, coloro i quali non perdevano un’esecuzione e la seguivano con la competenza dell’esperto:
Volete inzeggnà a me chi ffa la capa?
Io qua nun manco mai: sò ffreguentante;
E er boja lo conosco com’er papa.
Da qui anche l’espressione idiomatica che nacque riguardo al nostro personaggio. All’epoca le esecuzioni erano effettuate in tre posti: Campo de’ Fiori, luogo tradizionale ma un po’ in disuso nel XIX secolo, Piazza del Popolo o poco più avanti davanti al ponte di Castel Sant’Angelo; tutte comunque sulla riva destra del Tevere. Per motivi di tradizione, il boia non poteva abitare su quella riva, dove era concentrata la maggior parte della popolazione, e risiedeva invece sulla sinistra, in prossimità del Vaticano. Dovendo quindi attraversare il fiume ogni volta che era chiamato al lavoro, fu coniata la frase “Mastro Titta passa ponte” a significare il giorno dell’esecuzione.
L’unità italiana segnò la fine di quell’epoca. Non la fine della pena di morte, purtroppo; ma certo il termine delle esecuzioni come pubblico spettacolo, della mutilazione dei cadaveri e simili leggi da contrappasso. Quel che restò fu da parte dei romani il ricordo di questa bizzarra figura, e da parte del resto del mondo una morbosa curiosità per tali oscuri avvenimenti.
È in questo momento che finisce la storia di Mastro Titta e incomincia quella delle sue memorie.
Nel 1886 veniva dato alle stampe a Città di Castello un documento importante: il taccuino di Giovan Battista Bugatti, sul quale aveva riportato tutte le esecuzioni eseguite, con data, nome del condannato e il motivo della condanna. Si trattava di uno scarno elenco, di interesse storico ma di noiosa lettura. Qualche anno più tardi – precisamente nel 1891 – sullo stesso tema era pubblicato a puntate un libro corposo, scorrevole a leggersi, intitolato “Mastro Titta il boia di Roma: memorie di un carnefice scritte da lui stesso”.
Quale la differenza tra i due testi? Semplice: il primo era autentico, il secondo no.
Era in realtà una scaltra operazione commerciale a opera dell’editore Edoardo Perino. Si trattava di un torinese trasferitosi dopo il 1870 a Roma, dove aveva aperto un’edicola di giornali in piazza Colonna. In seguito si era reinventato editore, pubblicando romanzi a puntate di dubbio valore e gusto, che però avevano larga diffusione, grazie anche all’uso – innovativo per l’epoca – degli strilloni. Per la modica cifra di 5 centesimi la gente poteva avere un nuovo fascicolo di storie a tinte forti dai titoli come “La figlia del cardinale”, “La Papessa Giovanna”, “I piombi di Venezia”. Insomma, romanzetti d’appendice caratterizzati da orrendi delitti, clerici perversi, carceri malsane. Il povero Bugatti fu suo malgrado coinvolto in un’operazione del genere, con una finta autobiografia basata sì su documentazione reale – i suoi taccuini, le cronache dell’epoca – ma riassemblata in modo romanzato e con non poche astuzie ed esagerazioni dalla penna di un anonimo. La tesi più ricorrente, mai però confermata, individua questi in Ernesto Mezzabotta, uno degli scrittori più prolifici al servizio di Perino.
D’altra parte era ciò che andava per la maggiore in quell’Europa di fine ottocento, la terra del Grand Guignol e di Jack lo Squartatore, avida di racconti grondanti sangue e geniale creatrice della cronaca nera. L’Europa che riscopriva il medioevo, non più quello dei castelli e dei cavalieri, ma quello dell’Inquisizione e delle prigioni sotterranee, ed era percorsa da decine di furbastri intenti a confezionare falsi strumenti di tortura che i magistrati medioevali, feroci ma poveri di fantasia, mai avrebbero potuto concepire; e che ancora oggi affollano certe mostre da località turistica.
Quell’Europa, e quella Mitteleuropa (comprese le regioni alpine che avevano di recente e felicemente unificato il nostro paese) amavano guardare all’Italia, e in particolare al centro-sud, come un lembo di terra in cui il medioevo della fantasia fosse ancora vivo e vegeto; una terra oscura, fitta di foreste abitate da briganti sadici e all’occorrenza anche cannibali; e nella quale gli stati pre-unitari erano feroci dittature con la passione per le celle segrete ricolme di infelici dati ai tormenti. In sostanza, era venuta meno l’abitudine a proporre al pubblico spettacoli cruenti, ma non era venuta meno al pubblico la voglia se non di assistere, perlomeno di leggere di stupri, rapine e sanguinose esecuzioni.
Quando le Memorie di un carnefice furono date alle stampe, Roma era ormai una città incamminata sul suo destino borghese: capitale del Regno, cantiere a cielo aperto che si espandeva ogni anno di più con nuovi quartieri, palazzi alla moda, vita mondana, teatri, gran caffè e sciantòse. Ma non era passato poi così tanto tempo da cancellare il ricordo della Roma che fu, sorta di paesello diroccato con le pecore a pascolare fra le rovine antiche e il Papa-Re a vegliare a che nessuno turbasse quella quiete da tempo congelato. Un delitto compiuto in quella città estinta aveva tutt’altro sapore; non foss’altro per la cruenta sorte che attendeva il colpevole.
Ecco dunque spiegata la ricetta del successo di quest’opera, che con la scusa di raccontare la carriera del boia riassume gli eventi capitali della cronaca nera romana tra la fine del ‘700 fino all’unità italiana. Certo non si tratta di un capolavoro, bisogna essere onesti; ma è comunque una riuscita mistura di ingredienti appetibili non solo per il pubblico di allora, ma anche per l’odierno, così ghiotto di tinte oscure. Si tratta dunque di una patacca? Sì, se volete, a patto di considerarla una patacca con un non trascurabile fondo di verità. Allo stesso modo delle decine di finte Vergini di Norimberga conservate nei musei.
Ci piace concludere con la testimonianza di un visitatore straniero che alla metà del XIX secolo ebbe occasione di assistere a un’esecuzione di Mastro Titta, e ne riportò il resoconto in un’opera intitolata “Pictures of Italy”.
Lo straniero ha saputo di una condanna a morte in programma e, spinto dalla curiosità, ha deciso di assistervi in compagnia di un amico. L’evento è fissato per le nove meno un quarto del mattino e i due, con un’ingenuità nordeuropea che fa francamente tenerezza, si fanno trovare sul posto ben due ore prima. Tutto inutile: il patibolo è pronto, la lama della ghigliottina luccica ai raggi del sole, soldati a piedi e a cavallo pattugliano la zona, ma il condannato si fa aspettare ben oltre l’ora prevista. È proprio un “paese incomprensibile”, commenta il nostro.
Inizia a spargersi la voce che si dovrà aspettare fino a sera, come di prassi quando il reo rifiuta i conforti religiosi. Passano una, due ore. Quand’ecco dopo le undici arriva all’improvviso il corteo: si saprà in seguito che il ritardo era dovuto alla richiesta del condannato di incontrare la moglie per l’ultima volta.
Il testimone non si dilunga eccessivamente sui dettagli, ma da quanto riusciamo a ricostruire la scena che gli si presentò doveva essere alquanto macabra. Il malcapitato era accompagnato dalla processione dei confortatori, vale a dire i monaci della confraternita di San Giovanni Decollato (nome non casuale), che procedevano incappucciati dietro un crocefisso, in modo non dissimile da certe celebrazioni del Venerdì Santo. Un giorno, peraltro, qualcuno mi spiegherà che conforto potesse trarre dall’avere accanto degli incappucciati che cantano in latino sventolando crocefissi. Ad attenderlo sul palco Mastro Titta, il boia, con indosso un lungo mantello con cappuccio color rosso sangue.
Poi tutto si svolge con estrema rapidità. I monaci posizionano il crocefisso davanti alla ghigliottina, in modo che il condannato possa vederlo fino all’ultimo. Questi si accomoda al ceppo, e in meno di minuto la lama cade e la testa rotola giù nel cesto. Mastro Titta la prende per i capelli e la mostra alla folla, facendo il giro dei quattro angoli del patibolo; poi la fissa in cima a un’asta sul davanti.
The show was over, lo spettacolo era finito. La folla defluisce, i superstiziosi o cinici che dir si voglia deducono dai particolari dell’esecuzione i numeri da giocare al lotto, gli assistenti del boia si danno da fare per pulire la gran quantità di sangue versato.
Il nostro ne conclude: “Fu uno spettacolo brutto, sporco, ributtante; il cui unico significato non era altro che un’opera di macelleria, al di là del momentaneo interesse, ai danni dell’unico sventurato protagonista. Sì! Una tale vista ha un solo significato e un solo ammonimento. Che io non possa mai dimenticarlo.”
Il visitatore veniva dall’Inghilterra, e il suo nome era Charles Dickens.
Marcello Donativi