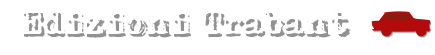Prefazione a
La camicia rossa – Alberto Mario
Facciamo come a scuola: alzi la mano chi sa dirci qualcosa dell’incontro di Teano. Nessuno si presenta? Allora devo chiamare io…
Ma ecco una manina che sbuca fra le teste: il solito volenteroso. Il quale probabilmente sciorinerà una favoletta di questo tipo:
C’era una volta un prode condottiero che nel nome di un Re Buono liberò gran parte della nostra penisola dalla dominazione straniera. Poi il Re lo raggiunse con il suo esercito, liberò strada facendo il resto del paese e i due si incontrarono in un posticino chiamato Teano. Si strinsero la mano come vecchi compari: il Condottiero, mantello in spalla e capelli al vento, disse: saluto il primo Re d’Italia! Il Re, fiero sul suo cavallo, rispose: e io saluto il mio migliore amico! E nacque il Belpaese.
Tale è la ricostruzione dei fatti tramandata per quasi un secolo e mezzo nei sussidiari di scuola, nelle opere di arte popolare, a tutt’oggi in certi sceneggiati televisivi, in cui i garibaldini – con camicie rosse stirate e fresche di bucato – vanno all’assalto al grido di: Italia e Vittorio Emanuele! E poco importa che i testimoni di quelle vicende raccontino, con significative varianti, tutt’altra storia. Per esempio, che Vittorio Emanuele fosse qualcosa di meno che un galantuomo e una figura imponente, quanto piuttosto una persona di aspetto tozzo, rozzo di modi e alquanto cinico nei suoi commenti; che Garibaldi quel mattino fosse di pessimo umore, travagliato dagli acciacchi e perciò imbacuccato come una nonnina; e che la conversazione tra i due sia stata piuttosto fredda. Taluni li ricordano parlare addirittura in francese, lingua che era loro molto più usuale dell’italiano; la frase pronunciata dal Liberatore sarebbe dunque stata: Majesté, je vous remets l’Italie.
Alberto Mario era presente a quella scena, e ce la racconta nel capitolo finale di questo libro. Ma non si può pretendere che il solo fatto di essere stato testimone oculare renda una persona imparziale; tutt’altro. Pur nell’asciuttezza del suo scrivere, non riesce a celare una punta di sarcasmo e una malinconia rabbiosa. Vengono a contatto per la prima volta i garibaldini, laceri volontari che da mesi combattono nel meridione d’Italia, e i Piemontesi con le loro divise in ordine e il protocollo da Accademia Militare, giunti con gran dispiego di forze a raccogliere il frutto del sacrificio altrui. Alcuni ufficiali sardi si fermano con i corrispettivi in camicia rossa; ma i più, compiuto il saluto da regolamento, passano oltre con disprezzo: “sarebbesi detto che eglino fossero i liberatori, e Garibaldi il liberto”. Si scorgono alla fine del corteo Fanti ministro della guerra, Farini generale appena nominato luogotenente delle Due Sicilie, e infine Vittorio Emanuele II, “tutta gente avversa a Garibaldi, a codesto plebeo donatore di regni”.
La conversazione fra il Re e il Dittatore è lontana dall’epica ricostruzione dei libri di scuola, con quel roboante saluto il primo Re d’Italia. Al contrario, non si va oltre un freddo scambio di cortesie formali: come state? bene, e voi? benone! I due si allontanano cavalcando a fianco, e il nostro testimone si sforza di riconoscere l’epicità dell’avvenimento; ma alla fine non riesce a vedere altro che “un principe ricevitore e un popolano datore di una corona; trasformazione d’un regolo in re d’Italia”.
Il sovrano viene poi presentato ai pochi popolani presenti: salutatelo, è il Re d’Italia! Ma i cafoni meridionali, che neppure intendono l’italiano, riconoscono solamente il nizzardo e invece di inneggiare al Re prendono a gridare con voce sgrammaticata Viva Calibardo!
Dopodiché le due schiere si separano. Vittorio Emanuele II si reca a pranzare; Garibaldi, neppure viene invitato.
Il lettore l’avrà già capito: Mario è assolutamente di parte nel ricostruire l’episodio. Ma il motivo è anche comprensibile: mentre si incontravano il Redentore d’Italia e il suo primo Re, il rodigino doveva avere un groppo in gola, così come dovette tornargli quattro anni dopo mentre scriveva. Il giorno in cui, secondo la vulgata posteriore, iniziava un nuovo avvenire per la Patria, per Alberto Mario si trattava non di un inizio ma di una fine: il termine delle illusioni, la brusca recisione delle speranze.
Vi è una parola che sembra bandita dalla nostra storia nazionale, benché più e più volte adoperata: rivoluzione. Molti partigiani del ’43-’45 erano convinti di partecipare a una rivoluzione e non a una semplice guerriglia di liberazione; gli stessi fascisti per venti anni avevano chiamato rivoluzione la propria era; e allo stesso modo, durante il Risorgimento la parola rivoluzione fu largamente adoperata. Il processo che portò alla nascita del nostro Stato fu qualcosa di più di una semplice modifica di confini: era in gioco un totale stravolgimento degli ordinamenti statali, l’ultimo stadio della lenta morte dell’Ancien Régime. Una rivoluzione, dunque, tant’è che i testimoni dell’epoca usarono abbondantemente questa parola: nel 1861 si era compiuta la Rivoluzione Italiana. Su questo erano un po’ tutti d’accordo; meno consenso riscuoteva il dilemma se questa rivoluzione fosse andata a buon fine o meno.
È questa infatti la sottile differenza tra gli scrittori unitari e antiunitari che ricostruirono quelle vicende negli anni immediatamente successivi. Per gli antiunitari come il Buttà o il De Sivo una rivoluzione era effettivamente accaduta: il compiersi dell’unificazione nazionale era visto come il risultato finale di un’epoca di cospirazioni massoniche, anticlericali, moderniste; per costoro i settarii avevano centrato il colpo, riuscendo a scalzare i re legittimi e imporre costituzioni laiche e leggi persecutrici della morale cristiana. Per quanti invece, come il Mario, avevano militato dalla parte opposta, e su posizioni più radicali (repubblicani, socialisti, mazziniani puri), gli eventi del 1860-61 erano stati sì una rivoluzione, ma una rivoluzione fallita: “e anche adesso, benché il disinganno di quattro anni abbia spazzato via con ala inesorabile fede e speranza, ci sono momenti nei quali mi sembra di sedere sul terrazzo incantato, credendo nella realtà di quell’avvenire che di lassù aprivasi allo sguardo” scriveva Mario nel 1864. A quella data uno stato unitario italiano era stato finalmente realizzato; ma per l’autore de “La camicia rossa” la musica non era cambiata granché: continuava a essere sotto controllo poliziesco, a incappare in periodici arresti ed essere costretto di tanto in tanto a riparare all’estero.
Questo veneto biondo e dai capelli lunghi (tanto che, in un’epoca priva di rotocalchi e telegiornali, veniva spesso scambiato per Garibaldi) era nato nel 1825 a Lendinara, in provincia di Rovigo, suddito dell’Impero Austro-Ungarico. Studente di legge a Padova, avrebbe potuto benissimo avviarsi a una tranquilla vita borghese: ma non erano tempi né luoghi. Infatuato delle nuove idee, iniziò a frequentare caffè e circoli in cui si dibatteva di emancipazione italiana dallo straniero, di costituzione, di progetti unitari. Per la cronaca, all’epoca era su posizioni giobertiane, convinto dell’esigenza di una confederazione di stati italiani sotto la guida del Papa. Già tenuto d’occhio dalla polizia austriaca per possesso di libri proibiti, a 23 anni fu coinvolto negli scontri di piazza che videro a Padova la morte di due studenti, e dovette riparare a Bologna.
Ebbe così inizio una vita degna d’un romanzo, avventurosa come quella di molti giovani di quegli anni. Il ’48 lo travolse come un tornado, portandolo a girovagare per l’Italia mettendosi al servizio ora di questa ora di quella armata di volontari: partecipò alla difesa di Vicenza, Treviso, Venezia, fu poi a Milano, l’anno successivo era nella Bologna assediata dagli Austriaci. Dopo la sconfitta di Novara e l’abdicazione di Carlo Alberto, riparò a Genova, dove maturò un radicale cambiamento di posizioni.
Nel corso dei due anni precedenti aveva conosciuto Mazzini e Garibaldi, frequentato socialisti e repubblicani, e nello stesso tempo vedeva naufragare le speranze di rendere indipendente e unita l’Italia sotto la tiara papale, men che meno tramite l’aiuto della corona torinese. Per di più, Vincenzo Gioberti, fino a quel momento il suo faro ideologico, aveva ricoperto l’incarico di primo ministro sardo con un contegno che i liberali giudicavano degno d’un traditore.
Se aveva bisogno di ulteriori pungoli a sposare le tesi più radicali, ci pensò l’autorità sabauda: inaugurando una serie di persecuzioni che sarebbero durate decenni, nel 1850 lo arrestò a Genova con l’accusa di essere l’anonimo autore di un articolo contro Carlo Alberto.
Per il momento se la cavò con un confino di breve durata, ma tanto bastò a rinsaldargli nella mente la convinzione che aveva maturato: l’Italia andava fatta, ma senza il Papa né i Savoia. Alberto Mario era divenuto saldamente repubblicano.
Erano gli anni del travaglio interno al movimento unitario. Cavour iniziava a piazzare le pedine per arrivare all’unificazione con il sostegno della Francia di Napoleone III, e i patrioti si dividevano fra chi era disposto al compromesso pur di raggiungere lo scopo e chi non intendeva piegarsi. Mario – come Mazzini – era fra gli intransigenti. “La monarchia (piemontese, ndr), non essendo nazionale, non avendo origine, genio, interesse, storia, tradizioni nazionali, non può cessare di essere sarda o sia provinciale” scriveva in quel periodo criticando l’adesione di Garibaldi al progetto sabaudo .
Ma era quella la direzione in cui spirava il vento. Il Piemonte acquistava sempre più punti di prestigio a livello internazionale, si era ormai accaparrato l’amicizia della Francia e aveva tutto l’interesse di perseguitare i repubblicani. Nel 1857 Alberto Mario, nello stesso periodo in cui naufragava la spedizione mazziniana di Pisacane, era nuovamente arrestato assieme alla sua compagna, l’inglese Jessie White.
Prudentemente si allontanò dall’Europa, e nel frattempo andavano facendo l’unità senza di lui: la Seconda Guerra d’Indipendenza, il trattato di Villafranca, i plebisciti per l’annessione al Piemonte dei regni del centro-nord. Ma quando Mario tentò il ritorno in patria, la patria dimostrò non gradire la sua presenza: fu ancora arrestato, incarcerato a Bologna e gentilmente scortato in Svizzera dai gendarmi. Nasceva l’Italia, ma l’Italia non lo voleva con sé.
A Lugano – che sarebbe divenuto il suo rifugio abituale – arrivò a una conclusione drastica: bisognava completare il processo di unificazione con uno slancio di popolo, una manifestazione volontaria che sminuisse il ruolo dei Piemontesi e facesse l’Italia senza l’aiuto dello straniero. Per questo motivo l’unica via era far partire la rivoluzione il più lontano possibile da Cavour: cioè dal Regno delle Due Sicilie. “Mi fò frate piuttosto che combattere per il vostro re” pare avesse detto a Mazzini “Bisogna andare in Sicilia per rovesciargli l’Italia addosso”.
Illusioni? Probabilmente sì, come i fatti successivi dimostrarono. Alberto Mario e tanti come lui si unirono a Garibaldi nella speranza di fare l’Italia per l’Italia e non per conto di qualcuno. Sognavano di risalire da sud tutta la penisola, e prima dell’inverno essere già a Roma, poi in Veneto, poi a Trento. E poi chissà! Quando si sogna non esiste un limite: instaurare a furor di popolo la Repubblica? Il Socialismo? Cos’altro?
Le illusioni impiegarono poco a crollare. Il nostro, impigliato nei soliti problemi con la polizia piemontese, non aveva fatto in tempo a imbarcarsi con la prima spedizione garibaldina da Quarto. Si unì a quella guidata da Medici subito dopo la presa di Palermo, e da qui in poi rivestì un ruolo di notevole rilievo nella campagna di guerra, come racconta bene in questo libro e come lasciamo volentieri al lettore di scoprire. Ma davanti alle mura di Capua i sogni erano bruscamente crollati. Nell’autunno 1860 l’esercito piemontese arrivava in tutta fretta in Campania, spinto dai timori di Cavour che fosse troppo tardi per fermare la rivoluzione e strapparle i frutti. I garibaldini erano messi da parte, troncata ogni speranza di proseguire per Roma e Venezia; Garibaldi, esautorato di ogni potere, se ne era tornato nella sua isoletta.
Tutto sommato l’Italia era fatta, si sarebbe potuto dire. Ma quale Italia?
Alberto Mario dovette accorgersi presto che i suoi timori erano fondati. Subito dopo l’unificazione si trasferì a Ferrara; ma un editto di polizia pretese di allontanare dalla città gli esuli veneti, per prevenire sconfinamenti nel territorio asburgico e incidenti diplomatici con l’Austria. Invano Mario protestò di rifiutare quel genere di imposizione, di voler essere ormai considerato un italiano e non un esule veneto; arrestato per l’ennesima volta, dovette piegarsi alla proibizione di risiedere in località di confine.
Il paese che vedeva nascere non era quello che aveva sempre sognato; e attorno a sé non trovava che gente insoddisfatta: una centralizzazione illogica e autoritaria, che in molti casi spazzava via buone leggi per sostituirvi quelle piemontesi più antiquate; una polizia oppressiva al pari di prima contro il libero pensiero; l’esercito inviato in massa nel meridione per reprimere il brigantaggio. “Il paese è malcontento perché cercava fratelli e trova dominatori” ne concluse amaramente. Nello stesso periodo – guardato a vista dalla polizia – rifiutò la medaglia che ipocritamente voleva dargli quello stesso Stato che lo perseguitava. Invece si recò a Caprera, a tentare inutilmente di convincere Garibaldi che la rivoluzione aveva fallito e andava ripresa; che il Dittatore tornasse a Napoli, riprendesse il potere, conquistasse Roma e Venezia, proclamasse la Repubblica; c’era bisogno di varcare nuovamente il Rubicone.
Bellissimi sogni. Quando il Nizzardo si decise finalmente a riprendere la strada, dovette accorgersi di quanto duro fosse riuscire in un’impresa senza gli appoggi diplomatici dell’Europa: bastò una fucilata in Aspromonte a fermare le camicie rosse.
Alberto Mario, tra l’altro, non poté partecipare. Il motivo? Il consueto: colpito da un mandato di cattura, si era dovuto rifugiare in Svizzera, costretto a masticare amaro assieme ai suoi amici mazziniani e repubblicani: “Tutte le battaglie combattute finora hanno fruttato ad esclusivo beneficio di Casa Savoia e dei suoi campioni, non perché Mazzini o Garibaldi o i loro seguaci a questo mirassero, ma perché essi alla repubblica e all’Italia divisa preferirono l’Italia una anche sotto Casa Savoia”; la parola d’ordine sarebbe dovuta essere invece “Libertà prima dell’Unità”.
Rientrato in patria, scoprì di essere stato a sua insaputa eletto deputato nella circoscrizione di Modica. Rifiutò l’incarico con una lettera aperta che non fece che procurargli altri guai: subì un processo – peraltro vinto – in seguito a un passaggio in cui diceva “Mi ripugna invincibilmente di giurar fede a chi versò il sangue di Garibaldi”.
Dopo aver tanto combattuto, insomma, si ritrovava una sorta di straniero in patria, costretto a patteggiare di continuo, elemosinare spazi di libertà di espressione, e allo stesso tempo voglioso di continuare a lottare per completare la tanto desiderata redenzione della patria. Primi obiettivi fra tutti, quelli che l’incontro di Teano aveva bruscamente rimandato: Roma e Venezia.
Per quel che riguarda Venezia, il nostro combatté, con un ruolo più che secondario, alla guerra del 1866. E poté alla fine ritornare al suo paese natale, anche se rosso di vergogna per aver ricevuto il Veneto in dono da una potenza straniera e non averlo liberato con le proprie forze.
A Roma cercò di arrivare due anni più tardi al seguito delle rinate camicie rosse; e fu coinvolto nel disastro di Mentana, al fianco di un Garibaldi abbandonato da tutti, fuggiasco in terra ostile (quasi un Guevara in Bolivia ante litteram) e quasi desideroso di essere ucciso piuttosto che subìre una tale umiliazione. Mario nella Città Santa poté recarsi solo nel 1870, alle spalle dell’esercito savoiardo; ma non era la stessa cosa.
Non restava che gettarsi a capofitto nello studio e nella scrittura, con una passione inalterata rispetto agli anni della gioventù, che ancora gli faceva vagheggiare un giorno la rivoluzione antimonarchica; finché un tumore non lo portò via nel 1883.
Questi brevi cenni di una vita più che notevole bastano a capire con quale animo il nostro potesse riandare al periodo della spedizione nelle Due Sicilie, e siano da spiegazione al carattere particolarissimo di questa opera. La quale – occorre dire in primo luogo – è non un semplice memoriale, ma un vero e proprio romanzo, in cui il Mario dimostra un’abilità fuori dal comune: uno stile asciutto, essenziale, una capacità che è di pochi nel selezionare eventi e dialoghi; in definitiva una lettura che ci è parsa molto piacevole. È un grande romanzo d’avventura, con in più una caratteristica peculiare, che ha fatto sì che fosse messo un poco in disparte nel mare delle testimonianze garibaldine: il suo profondo pessimismo. Resoconto di una rivoluzione troncata sul più bello, La Camicia Rossa è una ricostruzione venata di malinconia quasi a ogni pagina, il cui sottotesto è un continuo quel che poteva e non è stato. Non è una lettura consolatoria, tutt’altro.
Per questo motivo poco si poteva prestare a concorrere alla memoria ufficiale del Risorgimento. Se la pillola da far mandare giù era quella di un’idilliaca collaborazione – tutt’al più con qualche screzio – tra grandi figure di patrioti, a costo di mettere accanto nei santini nazionalisti persone che si odiavano profondamente come Mazzini e Cavour; se l’immagine da consegnare ai posteri era quella di un paese redento e soddisfatto (con l’eccezione di pochi reazionari al sud, tanto pochi che per mantenere un minimo di ordine pubblico ci volevano metà dell’esercito e la legge marziale); se l’idea da inculcare era quella di un Piemonte avanzato che generosamente dona il Progresso a regioni infelici strappate dalle tenebre del medioevo; a cosa poteva giovare un’opera simile? Con dialoghi come il seguente:
– E se noi non diamo retta a questi segni augurali (…) perderemo la battaglia contro il re sardo.
– Contro il Borbone, tu vuoi dire!
– No no, contro il sardo, il quale venne qui per fare la guerra a noi.
E questo ci riporta all’incontro di Teano e al racconto che ci fa Alberto Mario.
Il giorno seguente, la moglie Jessie, che si occupa delle ambulanze, avvicina Garibaldi e gli chiede disposizioni. Il Dittatore risponde che i suoi feriti sono rimasti sull’altra sponda del Volturno. I presenti non capiscono il significato di quell’espressione sibillina. Allora Garibaldi, con la tristezza e la rassegnazione dipinte in volto, spiega:
– Signora, ci hanno messo alla coda.
Marcello Donativi