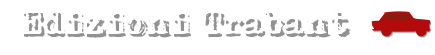Prefazione a
I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli – vol. III – Giuseppe Buttà
Un tristo officio: basta il titolo del primo paragrafo per dipingere l’atmosfera di questo tomo conclusivo della storia dei Borboni di Giuseppe Buttà.
Alla fine del secondo volume, il sacerdote messinese ci aveva lasciati descrivendoci la conclusione dei turbolenti avvenimenti del binomio 1848-49. La ribellione siciliana era sedata, frenati i trambusti interni al Regno al qua del faro, la rivoluzione pareva insomma sconfitta e ripristinato lo status quo precedente. Eppure restavano delle crepe, di cui non solo l’autore ma anche ogni lettore è per forza di cose consapevole. Nel momento in cui riprende il racconto, Buttà è conscio che la pace descritta è un equilibrio precario destinato presto a rompersi. Questo per un solo, semplicissimo motivo: tanto l’autore che il lettore conoscono già la fine di questa storia. Il racconto riprende dagli anni ‘50 del XIX secolo, chiunque si accosta al volume sa già che di lì a dieci anni il Regno delle Due Sicilie si sfalderà in pochi mesi come un castello di carte, e sa anche – probabilmente – che ciò non sarà raccontato nell’opera che ha in mano, perché materia già oggetto di un precedente libro.
È dunque in questo che consiste il tristo officio dell’autore: Buttà si assume il compito di condurre il lettore per mano fino alla vigilia della catastrofe, raccontando tutti gli avvenimenti che l’hanno annunciata e favorita; e tuttavia non racconterà la catastrofe. Sotto questo aspetto il terzo volume assume dei toni degni di una tragedia antica.
Il secondo volume era dominato dalla figura di Ferdinando II, il sovrano più amato dall’autore. Ne avevamo parlato come di una personalità ingombrante, un omaccione con atteggiamento da pater familias in casa e sul trono, instancabile viaggiatore nel suo regno, amministratore tanto appassionato quanto accentratore. Per la sua possanza fisica e spirituale, Ferdinando appare nei racconti, dei suoi sostenitori e non, come l’autentica chiave di volta che ha tenuto insieme il regno per decenni, venuta a mancare la quale l’edificio è crollato in un battere di ciglia. E difatti Buttà spende gran parte dell’ultimo tomo a descrivere, in un turbine di avvenimenti uno seguente all’altro, tutto quello che i suoi nemici hanno fatto per rimuovere questa chiave di volta. In meno di dieci anni, l’elenco è sorprendente: già all’indomani della domata rivolta del 48-49, l’intero universo sembra complottare contro il monarca e il suo regno. Una guerra innanzitutto psicologica – screditare quanto più i Borboni, presentando il loro regno come una mistura letale di oppressione, superstizione e sadismo – e in seguito anche fisica – i vari tentativi falliti di suscitare nuove rivolte. Già all’alba degli anni ‘50 abbiamo dunque le famigerate lettere di lord Gladstone, famose per aver definito le Due Sicilie come la negazione di Dio eretta a sistema di governo; una sequela più o meno fortunata di calunnie sparse per il mondo, fra le quali i fantasiosi strumenti di tortura che si diceva fossero in uso alla polizia borbonica; e poi si passa all’azione, con il soldato Agesilao Milano che attenta alla vita del re e l’esule Carlo Pisacane che fallisce una sorta di spedizione dei mille ante litteram. Entrambi subito canonizzati dalla religione unitaria come santi e martiri della lotta alla tirannia.
In mezzo a tutto questo, un Ferdinando che prova ad arginare la crisi, ora con decisione, più spesso con la stanchezza di chi ha combattuto troppo a lungo (come dice lo stesso Buttà, adagiandosi su “un letto di rose”), mentre attorno a lui l’Europa intera pare essersi davvero convinta che nel suo regno ogni giorno si condanna, si tortura, si fucila. Al culmine della lotta, il re si ammala e muore, degna conclusione di questa sorta di Passione di Ferdinando.
E qui entra in scena la figura forse più enigmatica dell’intera dinastia borbonica: Francesco II. Un sovrano che non ha nemmeno ricevuto l’onore di essere odiato dai suoi nemici. No, si preferiva ridicolizzarlo, dipingerlo come un incapace pure un po’ idiota. Se il padre era il temibile Re Bomba, a lui non toccava di meglio che essere il Re Bombino; se Ferdinando era un orco, Francesco era semplicemente il Lasagna, con un crudele riutilizzo del nomignolo che, bambino, aveva ricevuto per la sua golosità. Personaggio storico a cui i manuali scolastici, dopo pagine e pagine di stampe ottocentesche piene di ribelli con mantello svolazzante e capelli al vento, non dedicavano che una sola illustrazione, una figura minuscola di cui appena si intravvedevano i baffetti impomatati e la pettinatura con la scrima in mezzo, e in generale ti lasciava un sensazione di mediocrità e indecisione.
Molte delle critiche rivoltegli sono, a essere onesti, esatte. Era una personalità tormentata, schiacciato da un lato dalle dimensioni ingombrante della figura paterna e dall’altro dalla pesante responsabilità di essere figlio di un santa e averne involontariamente causato, con il parto, la morte. Non ricordo chi lo definì un sacerdote con la corona; e difatti, probabilmente, il suo sogno proibito sarebbe stato intraprendere la carriera ecclesiastica. Ma non poteva, e fu fatto re. Salito al trono all’improvviso, senza esperienza e senza troppa voglia, in un momento storico delicatissimo e per giunta avendo intorno una miriade di serpi in seno, commise forse ogni errore immaginabile, in più di un’occasione aiutando i suoi stessi nemici a detronizzarlo.
Eppure, nel momento del massimo pericolo, quando il regno gli crollava attorno e i Mille si avvicinavano pericolosamente a Napoli, seppe dimostrare una grinta insospettabile e lottò allo stremo delle forze fino all’ultimo secondo, guadagnandosi l’affetto dei suoi sostenitori e il rispetto di molti suoi avversari, se è vero, com’è vero, che molti testimoni ricordano di avere sentito Garibaldi spendere parole benevole nei suoi confronti.
Ma questa è un’altra storia e, come detto, appartiene a un altro libro. Don Buttà, che pure provava simpatia e stima per Francesco II, in quest’opera non ne approfondisce più di tanto la figura e assolve il suo compito di storico fermandosi alle soglie dello sbarco garibaldino. Il seguito è contenuto nelle sue altre opere: fatte le somme, messe insieme ci raccontano 150 anni di storia del Sud, dal 1730 al 1880, da un punto di vista controverso, opinabile per molta gente, ma appassionato e, secondo noi, di incalcolabile utilità.
Nel presentare questo volume che conclude la pubblicazione, da parte della nostra casa editrice, dell’opera omnia di Giuseppe Buttà, mi sia concessa qualche riflessione di carattere personale.
Nell’autunno 2007 inauguravamo le Edizioni Trabant, all’epoca un portale dedicato alla produzione e diffusione di volumi in formato esclusivamente digitale. Il primo titolo era Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta di Giuseppe Buttà. Troppe volte il nome di questo autore era comparso nella bibliografia di opere dedicate all’argomento; in più, gli ampi estratti riportati da Carlo Alianello ne La conquista del Sud ci avevano particolarmente incuriosito. Se si aggiunge la scoperta che l’opera fosse non facile da reperire e ristampata raramente nella storia, tutto ciò ci aveva portato alla decisione di proporla nuovamente al pubblico. Ricordo le giornate passate in biblioteca nell’estate del 2007, quando lavoravo su una copia dell’edizione originale e mi sembrava quasi di sentire i rumori della battaglia nel silenzio della sala. Quando la gente mi chiedeva se avessi programmato le vacanze, rispondevo: “le passerò a Gaeta nel 1861”.
Nel frattempo sono passati gli anni, le Edizioni Trabant si sono evolute in una casa editrice che offre sia il cartaceo che diversi formati digitali, e il sacerdote messinese ha continuato a segnare la nostra produzione. Al Viaggio sono seguiti nel 2011 il semisconosciuto romanzo-pamphlet Edoardo e Rosolina o le conseguenze del 1861, e in questo 2012 la presente e più conosciuta opera storica I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli.
A Giuseppe Buttà sono personalmente affezionato. Non si passa tanto tempo a lavorare sui testi di un autore senza in qualche modo sentirselo vicino. Più volte ho cercato di immaginarmelo. Non è facile, con scrittori, come lui, a suo tempo condannati all’oblio. Per altri, dopo la morte, è stata conservata minuziosamente ogni reliquia, gli scartafacci, le brutte copie, le lettere private, e legioni di critici si sono affannati a ricostruire quasi giorno per giorno la loro vita. Per conoscere gli autori dimenticati, invece, non abbiamo che le loro pubblicazioni, e di quelle ci dobbiamo accontentare se vogliamo farci un’idea di chi fossero. Devi lavorare di fantasia.
Io Giuseppe Buttà lo immagino come una specie di Don Camillo. Uno di quei sacerdoti sanguigni di cui è piena la nostra tradizione: il confessore che, invece di prescrivere tre pater noster, mena sberle; il prete da cortile più che da sagrestia. D’altra parte, lui stesso ha raccontato di sé alcuni aneddoti che lo raffigurano come un prete molto sui generis. Basta pensarlo quando faceva il cappellano militare e indossava una divisa a metà tra il religioso e il militare; e nel mezzo della battaglia, mentre attorno schizzavano le pallottole, prendeva appunti appoggiandosi a mo’ di scrivania sulla schiena del suo attendente.
Ed è curioso perché l’unica fotografia che ho trovato di lui lo presenta molto diverso dal personaggio – massiccio, muscoloso – di Guareschi. Al contrario, don Buttà appare una figura smilza, con gli occhialini e un’espressione placida. Eppure quell’uomo aveva davvero una penna che uccideva più di una spada.
Più volte, nel corso di questi anni, mi sono chiesto il motivo per cui suscitasse tanto interesse, in noi e nei lettori, la rivisitazione di quel periodo travagliato che ha portato al passaggio dal Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia. Eravamo consapevoli, nel proporre opere di questo tipo, di addentrarci in una sorta di campo minato. Il nostro insistere su questo filone ha portato, nel tempo, diversi attestati di stima e incoraggiamenti, i più pacati, alcuni improntati a un certo fanatismo; e, com’è giusto che sia, anche qualche critica. Ricordo una conoscente che, con l’aria di chi fa un’affermazione scontata, un giorno mi ha detto: “Voi continuate a pubblicare libri di destra?”. Sono rimasto stupito, perché mai avrei pensato di etichettare questo progetto culturale in tali termini. Ma nemmeno posso atteggiarmi a finta ingenuità e negare che non avessi messo in conto il rischio di simili semplificazioni.
Un ringraziamento va dunque a chi, attraverso vari canali (stampa, internet, corrispondenza privata) ha dimostrato di avere ben compreso lo spirito dell’iniziativa. Che è quello – riprendendo quanto già scritto anni fa nella prima prefazione per le ET – di contribuire a costruire non una storia condivisa, intesa come un compromesso a tavolino tra fazioni opposte, ma un storia completa, in tutte le sue sfaccettature, spesso contraddittorie. Una storia senza necessariamente buoni e cattivi, ma fatta essenzialmente da uomini.
Un’utopia? Forse. O magari una forma di incoscienza. Dopotutto, una volta siamo stati definiti “un editore temerario”. Una definizione che ho accolto con un largo sorriso.
La fortuna aiuta dunque gli audaci? Non saprei. Di certo so che la fortuna aiuta i curiosi. Perché solo finché manterremo la curiosità di conoscere, e approfondire, e vedere il mondo e la storia sempre da prospettive diverse, solo fino a quel momento potremo dirci vivi.
Marcello Donativi