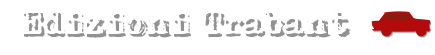Prefazione a
Analisi politica del brigantaggio nelle provincie meridionali – Tommaso Cava
Nell’introdurre, alcuni anni fa, la Storia delle Due Sicilie di Giacinto De Sivo, avevamo parlato di una “storia nascosta” del nostro paese. Vale a dire di una serie di vicende e personaggi di cui si trova solo una flebile traccia in quel magma indistinto che a volte viene chiamato storia ufficiale. Vuoi per dimenticanza, vuoi perché poco compatibili con i miti fondativi della nazione, difficilmente troveremmo in un’enciclopedia le voci biografiche relative al De Sivo o a Giuseppe Buttà, per fare i primi nomi che vengono alla mente, né appunto al capitano Tommaso Cava De Gueva.
Eppure la vicenda personale del capitano Cava è emblematica per capire come le vicende dell’unificazione nazionale siano state ben più complesse di una semplice transizione dalla tirannide alla libertà e abbiano invece comportato lacerazioni, dibattito e malcontento ben oltre l’anno 1861.
Tommaso Cava nasce a Napoli nel 1826. Figlio di un ufficiale di fanteria, intraprende a sua volta la carriera militare arruolandosi, volontario, a soli sedici anni. Da lì si incamminerà su un notevole cursus honorum: alfiere nel 1848, l’anno successivo fa il concorso per ufficiali ed è nominato Aiutante di Campo del generale Giovanni Rodriguez; nel 1852 diventa ufficiale dello Stato Maggiore, conquistando via via i gradi di 2° tenente, poi 1° tenente, infine capitano. È in questa veste che, nel maggio 1860, raggiunge Chieti per mettersi alle dipendenze del generale Giuseppe Pianell.
Il periodo è delicato: quando Cava arriva presso il suo nuovo superiore, è il 17 del mese e da quasi una settimana Garibaldi è sbarcato a Marsala. Il Regno è sotto attacco, ma è il vero caos è al suo interno.
Mentre Garibaldi si appresta a entrare a Palermo, Pianell invia Cava nei dintorni de L’Aquila a seguito di vaghe notizie di sbarchi garibaldini nella zona. A fine mese, per la stessa ragione, lo incarica di compiere una missione tra Martinsicuro e Silvi. E così va avanti per lungo tempo, una serie di frustranti missioni di ricognizione, ispezioni a sorpresa e perlustrazioni nel momento in cui il Regno va incontro allo sfacelo. Tanto da ingenerare il sospetto che siano orchestrate allo scopo di tenere impegnato parte dell’esercito lontano dalle zone calde; uno degli elementi che porterà Pianell tra gli ufficiali cui la storiografia borbonica addosserà l’infamante accusa di tradimento.
A luglio Cava torna a Napoli al seguito di Pianell, che si appresta a vivere la sua breve esperienza di Ministro della Guerra. È lì il 7 settembre, quando Garibaldi entra a Napoli. Subito lascia la capitale e raggiunge la corte borbonica fuggita a Gaeta, per mettersi a disposizione dell’estrema difesa del Regno progettata da Francesco II. Viene pertanto assegnato alla piazza di Capua e a ottobre, dopo la battaglia del Volturno, mentre gli eventi precipitano, ne diventa Capo di Stato Maggiore, giusto in tempo per gestirne l’assedio da parte del sopraggiunto Esercito Piemontese.
Il 2 novembre la Piazza di Capua si arrende e Cava, assieme agli altri componenti della guarnigione, è fatto prigioniero e viene mandato a Napoli. Qui segue apparentemente il destino di tanti suoi commilitoni dello smembrato Esercito delle Due Sicilie: riceve cioè un’offerta di mettersi al servizio del nuovo governo, come segno di continuità e coinvolgimento dei soldati meridionali nel nuovo regime, e accetta.
Apparentemente, dicevamo: il suo rapporto con il nuovo ordine sarà infatti problematico, fino ad arrivare a una completa rottura. Uno dei primi segnali è a gennaio, mentre infuria l’assedio di Gaeta. A Cava è chiesto di entrare nella Commissione che scrutinerà gli ex-ufficiali dell’esercito borbonico in vista della loro integrazione nell’esercito savoiardo; ma rifiuta, sentendo come ignominioso il compito. La situazione precipita negli anni successivi, quando ormai l’unità d’Italia è compiuta. A Cava sono assegnati diversi compiti di responsabilità tra la Campania e la Basilicata, un contesto che gli permette di essere a stretto contatto con i drammatici problemi dell’integrazione del Meridione nel nuovo regno, compreso il fenomeno del brigantaggio e la dura reazione repressione che ne scaturisce.
Presto Cava si segnala ai suoi superiori come una testa calda, un uomo che ha accettato il nuovo status quo ma non per questo si tira indietro dal denunciarne le storture, e soprattutto rifiuta di unirsi all’unanime coro di denigrazione nei confronti dell’antico regime. Già nel marzo 1861 invia, inascoltato, un rapporto al Governo in cui denuncia gli abusi sulla popolazione civile compiuti dal neonato Esercito Italiano. Nel 1863, quando ormai si è ritirato dal servizio e nel mentre la situazione è ulteriormente precipitata, pubblica un Appello alla opinione pubblica che lo mette definitivamente in rotta con i vertici militari. Il Ministro della Guerra, generale Della Rovere, sollecita provvedimenti disciplinari per avere disonorato il paese e l’esercito. Cava, convocato a Napoli, non si presenta ma invia una difesa scritta; nel giugno ’63 gli viene infine comunicata ufficialmente la rimozione dal grado.
Siamo allo scontro aperto. È la molla che spinge definitivamente Cava a farsi scrittore, con la pubblicazione in breve tempo delle due opere per cui è conosciuto – benché da pochi: la Difesa Nazionale Napoletana, nel quale racconta la propria vicenda personale e attua una riabilitazione dell’onore dell’Esercito delle Due Sicilie, e il presente pamphlet sul brigantaggio.
Il volume è del 1865, quattro anni dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia. Quattro anni durante i quali il Mezzogiorno era stato scosso da una serie massiccia di reazioni, percorso da numerose bande armate in guerra contro l’esercito italiano e i volontari della Guardia Nazionale. La situazione era giunta a tal punto da richiedere dapprima la proclamazione dello stato d’assedio e successivamente la promulgazione della celebre Legge Pica, che istituiva misure draconiane e la temporanea sospensione di alcune garanzie costituzionali per fare terra bruciata attorno ai briganti.
All’epoca in cui scrive Cava il brigantaggio andava già incontro al tramonto (la legge Pica cesserà di essere in vigore alla fine del 1865). Il prezzo da pagare era stato però durissimo: migliaia di arresti, un numero non ben calcolabile di fucilazioni sommarie, in alcuni casi interi paesi dati alle fiamme.
L’opinione pubblica ne era stata scossa e divisa. Vi erano liberali che consideravano il ferro e il fuoco come una misura indispensabile per contrastare un fenomeno che minacciava l’appena raggiunta unità nazionale; liberali di vedute più moderate cui ripugnavano le atrocità commesse anche dalla parte che sostenevano; infine, simpatizzanti del decaduto regno borbonico che scorgevano nel fenomeno nient’altro che la prova della brutalità e illegittimità del nuovo regime. Tra questi, il capitano Cava giunto ormai allo scontro con i suoi ex superiori.
Ma perché Cava si ripromette di effettuare un’analisi politica del fenomeno?
La risposta è lapalissiana: perché il brigantaggio, almeno nelle sue prime fasi, aveva avuto un carattere eminentemente politico. Nel corso del tempo questo aspetto è un po’ sbiadito, e l’uomo comune ha spesso pensato al brigante come a colui che delinque per ribellarsi alla sua sfortunata condizione sociale. In sostanza, una versione più popolaresca – e più violenta – di Robin Hood. Eppure il fenomeno delle bande, almeno inizialmente, aveva avuto spesso carattere politico prima che sociale. I briganti sostenevano di combattere non per reclamare una generica giustizia sociale, ma per restaurare il caduto dominio borbonico. Attaccavano l’esercito sardo; conquistavano, seppur per brevi periodi, interi settori del territorio innalzando la bandiera delle Due Sicilie; compivano rappresaglie contro i liberali che avevano collaborato all’unificazione; il tutto nella convinzione che presto o tardi lo spodestato re Francesco sarebbe tornato alla testa del suo esercito per riconquistare il regno. Non era mistero, d’altra parte, che il fenomeno fosse incoraggiato e spesso finanziato dai legittimisti se non dalla stessa corte borbonica in esilio.
Non a caso qualcuno si è spinto a parlare di guerra civile. O, per citare un saggio di qualche anno fa, guerra cafona.
Questo, certo, non è stato l’unico aspetto del brigantaggio, e probabilmente nemmeno quello predominante. Il fenomeno, abbiamo ripetuto più volte, era molto complesso e aveva mille sfaccettature, che a volte si sfioravano, a volte si intersecavano. Delinquenti comuni si davano alla causa legittimista per denaro, per convenienza o per promesse di amnistie; legittimisti convinti si univano alla guerra di bande per sostenere la propria causa, salvo poi ritrovarsi a collaborare con una proto-specie di mafia; per non parlare di tutti quei casi in cui non era facile distinguere l’uno e l’altro.
Per i simpatizzanti del dominio borbonico come Tommaso Cava, però, il risvolto politico esercitava un fortissimo fascino e rappresentava una speranza di riscatto.
Il Cava decide però di non dedicare il suo opuscolo ai regnanti borbonici, ma a Vittorio Emanuele II. È una sfumatura non da poco, segno dell’atteggiamento dell’autore. Parrà forse ambivalente ad alcuni, ma Cava, come descritto, non vuole porsi in aperto contrasto col nuovo ordine politico: lo accetta, si mette al servizio, ma allo stesso tempo rivendica il proprio diritto a porsi in modo critico nei suoi confronti. Al primo Re d’Italia confessa di non essere tra i suoi estimatori, nemmeno però gli professa odio:
I veri amici di un trono e di un Sovrano, son coloro che operano in modo da procurargli nei sudditi, il maggior numero di amici; ma coloro che indefessamente lavorano per disgustare ed esacerbare i popoli, non sono che i veri e più potenti nemici della corona e del capo che la cinge. Ed eccetto poche eccezionalità, coloro che reggono il governo di V. M. sono vostri dichiarati nemici, che vi hanno alienato perfino la tradizionale devozione ed affezione dei vostri antichi sudditi.
La seconda dedica è ai lettori, e qui Cava si spinge a un’altra affermazione illuminante sul suo punto di vista:
Io non ho la velleità di far guerra alle leggi; ma ho la ferma determinazione di biasimare le cause che hanno importato le cattive leggi, e gli uomini sui quali pesa la responsabilità delle nostre sventure.
Tiene dunque molto a mettere in chiaro all’inizio di non essere un legittimista livoroso. Fa professioni di rispetto nei confronti della monarchia sabauda, si dichiara spinto da nobili intenti. Detto questo, non si tira però indietro dal picchiare duro.
Innanzitutto rigetta con sdegno l’appellativo stesso di brigante attribuito alle bande armate che al suo tempo percorrono il Mezzogiorno. Con che faccia – si chiede – possono dare del brigante ad altri quelli che a loro volta sono stati più volte, in passato, chiamati tali? I fratelli Bandiera, Carlo Pisacane, Felice Orsini, lo stesso Garibaldi, ci ricorda Cava, furono appellati briganti in virtù delle loro imprese. E non dai reazionari. Lo stesso Cavour aveva dato del brigante a Garibaldi, salvo cambiare idea quando più gli è convenuto.
Cavour chiamava brigante Garibaldi nel 1860, ed invocava la sua fucilazione, quando ancora era incerto dell’esito dell’intrapresa a cui egli stesso lo spinse. Nel 1861 poi, lo chiamò un eroe, e si attribuì nel parlamento di Torino, il merito di quell’impresa, che pochi mesi prima egli fingeva di condannare.
Se proprio si vuole, dunque, si chiamino briganti gli uni e gli altri. Con una differenza, però: il brigantaggio post-unitario, al contrario dei personaggi nominati, gode del favore della popolazione, e la dimostrazione risiede nella sua durata:
Garibaldi negli stati Romani il 1849 fu ridotto a lui solo dopo un mese appena.
I Bandiera dopo 4 giorni furono catturati con tutti i loro compagni.
Bentivegna e Pesacane furono distrutti in due giorni.
Le attuali bande reazionarie in vece, stanno in campagna da cinque anni in tutto il continente napoletano, senza che ottanta mila uomini di truppa, avessero potuto distruggerle, anzi sono stati essi decimati: dunque è chiaro che tali bande sono sorrette, appoggiate, agevolate e sostenute da tutti i paesi e le città del continente istesso.
È una posizione netta, la quale però era condivisa dal governo sabaudo. La Legge Pica, infatti, tra le altre cose, aveva dichiarato guerra ai manutengoli, cioè a chiunque, nella popolazione civile, direttamente o indirettamente appoggiasse i briganti. Segno che era cosciente di un vasto appoggio popolare al fenomeno.
Quale dunque la differenza fondamentale tra le due fazioni, quella dei Pisacane e dei Garibaldi e quella dei Caruso e dei Crocco? La prima, i liberali, avevano il progetto di invadere un paese straniero per importarvi la rivoluzione; i secondi, i reazionari, reagiscono alla violazione del diritto incarnata dalla deposizione del legittimo sovrano.
L’unificazione, continua Cava, è stata ottenuta tramite il sopruso: una ingiustificata invasione di un regno indipendente e un plebiscito farlocco all’ombra delle baionette straniere. Come se non bastasse, il neonato governo non ha fatto nulla per ingraziarsi le popolazioni annesse, ma le ha vessate, umiliate, al punto da esacerbarne l’animo e stimolarne la nostalgia del precedente reame.
I Napoletani, intesi come popolazione del sud, hanno dunque tutto il diritto di fare la guerra al nuovo ordine, e questa non è da considerarsi volgare delinquenza.
Qui veniamo a un punto fondamentale della visione di Cava: la distinzione tra un brigantaggio politico, legittimista – giusto – e il brigantaggio sociale, pura criminalità da deplorare. Non si deve, cioè, confondere chi guida bande armate allo scopo di rimettere sul trono lo spodestato re borbonico, e chi genericamente taglieggia e devasta per il proprio tornaconto, ammantato al più di una giustificazione di riscatto sociale.
Era una tesi molto diffusa tra i reazionari ottocenteschi, che permetteva loro di idealizzare chi combatteva in nome di Francesco II con un richiamo a eventi del passato: la Vandea, il Sanfedismo.
Dove il Cava, e altri con lui, si sbagliava, era nel non comprendere il confine fin troppo sottile tra le diverse anime del brigantaggio. Affascinati dal pensiero di una lotta di popolo contro lo straniero, esageravano il ruolo dei politici sminuendo quello dei delinquenti comuni; per non parlare delle numerose situazioni in cui i due fenomeni si incontravano e confondevano. L’incontro di Borjès con Carmine Crocco (che abbiamo descritto nella prefazione alle memorie del brigante) è emblematico in questo senso, e lascia anche capire come alla lunga l’aspetto delinquenziale abbia prevalso su quello politico, e sia stato forse tra le cause della sconfitta delle bande.
Tommaso Cava considera, probabilmente a torto, il brigantaggio politico numericamente più consistente di quello comune, e ne idealizza i personaggi:
I legittimisti onesti, i quali sono invasi dal nobile sentimento di onestamente difendere, in un modo qualunque il diritto conculcato ed offeso dalla frode e dal tradimento, hanno la norma di attendere al loro scopo senza mai commettere un’azione che deturpasse la nobiltà del mandato che si hanno imposto. […]I legittimisti onesti adunque, che preferiscono di combattere armata mano in campagna il governo attuale, rifuggono da tutto quello che sa d’infamia e di vituperio. Essi sono i veri martiri di un principio politico-sociale, la cui difesa potrebbe essere biasimevole appena, se il nuovo ordine di cose che essi combattono, avesse a riparazione di tante violenze patite, importato un miglioramento alla condizione morale e materiale dei loro concittadini, o pure, se un sentore qualunque, accennasse ad un futuro miglioramento, almeno illusorio.
Era un’idea nobile, probabilmente errata per i motivi che abbiamo descritto, ma meritevole di rispetto e non di oblio. Un tale approccio è condiviso da molti scrittori ottocenteschi simpatizzanti per la parte borbonica, i quali dopo l’Unità d’Italia a lungo cullarono il sogno di una rivolta popolare contro il nuovo regime. I pochi episodi isolati in cui questa lotta effettivamente si compì, assieme ai casi più numerosi in cui la delinquenza comune si prestò, per sincera adesione, calcolo o perché prezzolata, a sostenere la lotta allo straniero, ne eccitarono la fantasia. Sfortunatamente per loro, si trattava di un’illusione.
Nel giro di pochi anni, grazie anche alle durissime leggi speciali emanate dopo il 1863, il brigantaggio fu debellato. Negli ultimi anni aveva ormai perso qualsiasi connotazione politica, e quando l’esperienza fu terminata i pochi sopravvissuti, come Carmine Crocco, tenderanno a sminuire se non proprio rinnegare la matrice legittimista della loro ribellione.
Eppure il brigantaggio legittimista è esistito e occorrerebbe ricordarselo di tanto in tanto. L’immaginario popolare odierno, invece, si concentra in genere soltanto sugli aspetti criminali del fenomeno brigantesco, quelli più pittoreschi, a tinte fosche, laddove il bandito delinque spinto non tanto da ideali politici quanto, al massimo, dalla voglia di rifarsi delle ingiustizie subìte. Invece figure meno conosciute come quella del Sergente Romano o del generale Borjès rappresentano il volto forse più nobile del brigantaggio, quello che si vedeva come una lotta partigiana contro un invasore straniero.
Che si trattasse di una minoranza, poco importa. Opere come quella del Cava sono in ogni caso la testimonianza di un sentimento diffuso in diversi settori della società dell’epoca, che merita di essere ripreso in considerazione.
Marcello Donativi