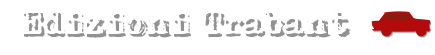Prefazione a
Diario di un privilegiato sotto il fascismo – Leo Ferrero
“Combattevamo Mussolini come corruttore, prima che come tiranno” ebbe a dire una volta Piero Gobetti; “il fascismo come tutela paterna prima che come dittatura; non insistevamo sui lamenti per mancanza della libertà e per la violenza, ma rivolgemmo la nostra polemica contro gli italiani che non resistevano, che si lasciavano addomesticare.”
In effetti, e il ’900 ce l’ha insegnato, una dittatura non riesce a reggersi unicamente sulla violenza, almeno non su quella esibita. Se da una parte vi è l’arresto, il linciaggio e qualsivoglia altra misura estrema e visibile per l’eliminazione del dissenso, dall’altro – soprattutto quando un regime, conquistato il potere, punta a consolidarsi – le armi che utilizza sono più sottili e consistono talvolta non tanto nella segregazione o uccisione del dissidente, quanto nella sua emarginazione dalla società. “Disgraziatamente ora non si bastona più”, dice nel presente libro un fascista, rammaricandosi del fatto che, preso il potere, il regime abbia imposto metodi più subdoli nei confronti degli oppositori.
È un’operazione complessa: che sia effettuata attraverso la polizia, i servizi segreti o una rete di delatori, richiede in ogni caso la collaborazione di un popolo che, vuoi per paura vuoi per abbaglio, si è lasciato addomesticare. Gli esempi nella storia si sprecano.
Wladyslaw Strzeminski, il pittore polacco espressione di un’avanguardia invisa al neonato regime comunista, negli anni ’50 fu dapprima allontanato dall’Accademia; in seguito fu licenziato da qualsiasi lavoro potesse attenere all’arte, e infine gli fu impedito, tramite il ritiro della tessera, di acquistare i colori per poter dipingere anche solo privatamente. In pochi furono, nell’ambiente accademico, a prendere le sue difese. Il romeno Norma Manea, negli anni ’80, intraprese uno snervante braccio di ferro con la censura di Ceausescu per poter pubblicare il suo romanzo La busta nera; l’opera, quando vide la luce, era stata del tutto snaturata da decine di tagli e correzioni a ogni pagina, e l’autore, ormai un isolato in patria, scelse la via dell’esilio volontario.
La storia d’Italia non fa eccezione. Durante il ventennio vi furono episodi eclatanti di soppressione violenta del dissenso, tra cui quelli celebri di Giacomo Matteotti e del su citato Gobetti, ma numerosi furono i casi in cui il regime, per mettere a tacere dei personaggi scomodi, intraprese la strada di piccole ma efficaci vessazioni: la costante sorveglianza della polizia, l’ostacolo all’esercizio della professione, il ritiro del passaporto.
Tra questi, un episodio riguardò un’intera famiglia, cui apparteneva l’autore del presente diario: la famiglia di Guglielmo Ferrero.
Pare strano introdurre l’opera di uno scrittore attraverso la biografia del padre. Sembra oltretutto ingeneroso nei confronti di un uomo che, benché figlio d’arte, ha avuto una sua esistenza letteraria autonoma, degna di un destino migliore di quello riservatogli dalla prematura scomparsa. Tuttavia, è importante soffermarsi sulla figura di Guglielmo Ferrero non soltanto per il ruolo che ha rivestito nella storia del nostro paese, ma anche perché è di fatto il vero protagonista di questo diario.
Ferrero era nato a Portici nel 1871, ma la famiglia era originaria del Piemonte: destino girovago comune a quanti, all’epoca, nascevano come lui da un impiegato delle neonate ferrovie italiane. D’altra parte tutta la sua vita successiva sarà caratterizzata da una costante instabilità geografica che, vuoi per scelta vuoi per costrizione, si riverserà a cascata su tutta la famiglia: Ferrero, compiuti gli studi a Torino, passerà il resto della sua esistenza balzando da un capo all’altro del mondo.
Importante l’esperienza torinese, durante la quale conobbe e frequentò Cesare Lombroso, il celebre padre dell’antropologia criminale. Non soltanto per l’influenza che lo scienziato positivista avrebbe avuto sulla sua formazione, ma anche perché nel 1901 ne avrebbe sposato la figlia Gina – a sua volta una notevole intelligenza dell’epoca – dando vita a una famiglia nella quale la cultura si avvertiva, per così dire, a ogni respiro. Nello stesso anno del matrimonio dava alle stampe il primo volume della sua opera più famosa, Grandezza e decadenza di Roma, nella quale analizzava il periodo della crisi della Repubblica romana fino all’avvento di Cesare Augusto con uno stile discorsivo e scorrevole che ne decretò il successo in tutto il mondo e un’originalità di vedute che gli alienò più di una simpatia nel mondo accademico. A quella di storico e romanziere affiancava, intanto, un’instancabile attività di relatore, tenendo lezioni e conferenze in tutto il mondo fino a divenire una figura di spicco della cultura a livello internazionale.
Politicamente, è vero quanto asserisce Gina Lombroso nella prefazione a questo volume, che il marito non avesse mai aderito ufficialmente ad alcun partito o fazione. Tuttavia, le sue frequentazioni e le sue prese di posizione lo posero presto nel novero dei socialisti, con conseguenze anche di scontro con le autorità. Significativo, a questo il proposito, il processo a cui fu sottoposto nel 1894 nel periodo delle repressioni del governo Crispi; o le numerose occasioni in cui collaborò a iniziative promosse da Filippo Turati.
Nel 1916 Ferrero si trasferì con la famiglia a Firenze. Qui visse la nascita e affermazione del fascismo. Nei primi anni lo storico non ebbe particolari fastidi da parte del regime, in virtù anche del fatto di non poter essere esplicitamente inquadrato in questa o quella fazione. Tuttavia, Ferrero non fece nulla per nascondere il suo dissenso: firmò il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti di Benedetto Croce, collaborò in attività di commemorazione di Matteotti. In qualche modo, iniziarono delle forme di boicottaggio. Una delle più dolorose fu la vicenda del quotidiano Il Secolo, con cui Ferrero collaborava da diverso tempo. La testata si era distinta, sotto la direzione di Mario Missiroli, per alcune inchieste piuttosto pungenti sullo squadrismo. Nel 1923, preso il potere, Mussolini fece in modo che il giornale fosse acquistato da una cordata di imprenditori a lui vicini. Diverse firme importanti, per protesta, lasciarono il quotidiano con una lettera aperta in cui auspicavano che esistessero ancora italiani “per i quali l’amore per la patria non sia disgiunto dal rispetto per la libertà”. Tra i firmatari, vi era Guglielmo Ferrero.
Un’altra manovra, questa volta personale, fu lo sfratto che la famiglia subì dalla casa di Firenze in cui abitavano. Alcuni anni prima, Ferrero aveva preso una villa sui colli, in località Strada in Chianti, chiamata dell’Ulivello: decise pertanto di portare la famiglia lì, lontano, pensava forse ingenuamente, dai problemi. Qui è ambientato gran parte del Diario di un privilegiato sotto il fascismo.
Giunti alle soglie dell’opera che state per leggere, possiamo finalmente introdurre il suo autore. Leo era il figlio primogenito di Guglielmo, nato a Torino nel 1903. Visto il clima familiare che abbiamo descritto, c’erano tutti gli ingredienti perché il giovane maturasse delle inclinazioni letterarie, e difatti dimostrò presto un genio precoce. A 16 anni padroneggiava il francese come una lingua madre e pubblicava articoli in due lingue; a soli 18 anni, sulla scia forse di una voglia di emulazione, scrisse assieme al padre il saggio storico La palingenesi di Roma. La sua vera passione di quei primi anni era però il teatro: già dall’adolescenza aveva iniziato a scrivere drammi, nel 1919 finalmente poté vederne due messi in scena a Roma, riscuotendo il parere favorevole, si dice, di Luigi Pirandello. Sembrava, insomma, essere predestinato a una luminosa carriera nelle lettere. Purtroppo, non erano i tempi né i luoghi.
Nella seconda metà degli anni ’20, come illustra bene Gina Lombroso nella sua prefazione, il fascismo prese alcuni attentati contro Mussolini a pretesto per effettuare un giro di vite contro i dissidenti. Furono privilegiate, però, armi più subdole del vecchio squadrismo, che anzi si cercava in qualche modo di tenere a bada, nel tentativo di istituzionalizzare gli strumenti repressivi, servendosi delle forze di polizie, della magistratura (fu creato il famigerato Tribunale Speciale), della censura sulla stampa. In questa fase, nessuno poteva più sentirsi al sicuro. Il cittadino, in modo particolare se personaggio pubblico, era messo davanti a un aut-aut: aderire al regime o scomparire, metaforicamente o no.
È in questo contesto che matura il presente libro, il quale parte evidentemente come un diario privato, ma si trasforma ben presto nella cronaca in tempo reale delle persecuzioni della famiglia Ferrero. Un’odissea che ha al suo centro il padre Guglielmo, impegnato in un estenuante braccio di ferro con le forze di polizia e il mondo politico, nello strenuo tentativo di mantenere la possibilità di esercitare la sua professione, pubblicare articoli e libri: insomma, continuare a esistere come personaggio pubblico.
All’inizio, come dicevamo, Leo pensava di parlare di sé. Nelle prime pagine lo annuncia come il diario della sua vita adulta, ma in breve confessa una certa stanchezza. “Questo diario mi secca.” scrive il 20 ottobre 1926, “Parlare di me in fondo non mi diverte”. Ma già il 1 novembre la vita e di conseguenza il diario prendono tutt’altra piega. Giunge notizia dell’attentato Zamboni, è il prodromo alla tempesta che travolgerà l’intera famiglia. Sono le piccole e grandi angherie di cui parlavamo in apertura. In un primo momento viene impedito a Guglielmo Ferrero di viaggiare per tenere le sue consuete conferenze all’estero: gli sono infatti negati i passaporti, sulla base di generiche motivazioni di sicurezza. Sul capofamiglia inizia ad aleggiare la costante minaccia di confino, sempre presente come una spada di Damocle ma mai veramente attuata. Poliziotti prendono ad affollare il giardino di casa, per sorvegliarlo ma anche come continuo monito. La posta è controllata, amici e conoscenti sono potenziali delatori. Lo scopo del regime è quello di impedirgli la fuga all’estero e allo stesso tempo conquistarlo alla sua causa. Ne conseguirà un tira e molla tra Ferrero e il fascismo, fatto di proteste da parte dello scrittore e un’alternanza di minacce e promesse da parte della dittatura, secondo un climax che non sveliamo per lasciare al lettore il piacere della scoperta.
Come sia finita questa vicenda, questo invece lo raccontiamo, dal momento che appartiene oramai alla storia. Leo Ferrero riuscì a lasciare l’Italia assieme alla sorella Nina nel 1928; due anni dopo fuggirono i genitori. Guglielmo Ferrero si stabilì in Svizzera, dove insegnò storia all’università e morì nel 1942.
Leo trovò rifugio a Parigi, dove poté riprendere la sua attività intellettuale come pubblicista, poeta, drammaturgo, critico letterario. Nel 1932 si trasferì negli Stati Uniti per effettuare una ricerca sugli Indiani d’America. Qui trovò la morte in un incidente stradale nel 1933, a soli 30 anni.
Furono i genitori, negli ultimi anni della loro vita, a curare le opere del figlio prematuramente scomparso. In particolare, la madre fece pubblicare questo diario, scrivendone una prefazione allo stesso tempo tenera e appassionata.
Una lettura che ci è piaciuta e abbiamo pertanto voluto riproporre al pubblico. In un periodo in cui fioriscono da più parti tentazioni nostalgiche o tentativi di riabilitazione, bisognerebbe ricordare come la dittatura non abbia posto le sue basi soltanto sui fenomeni più vistosi di omicidio e devastazione (quindi, giustificabili da parte di qualcuno come misure eccezionali e saltuarie), ma su una costante operazione di controllo e repressione che ha attraversato l’intera società in una miriade di storie personali. Questo richiedeva il concorso, o almeno l’omertà, di una buona fetta della popolazione. Perché Leo Ferrero intitola il suo diario “di un privilegiato”? Perché la sua famiglia aveva i mezzi di sostentamento per sopravvivere nonostante le angherie subìte e, aggiungiamo noi, aveva lo spessore intellettuale di lasciare ai posteri il racconto della propria vicenda. A loro si contrapponevano i “non privilegiati”, tutti quelli, e sono tanti, cui la storia ha impedito di far sentire la propria voce, la cui vita è stata travolta e spesso distrutta non da pochi, isolati carnefici, ma dal conformismo e dalla paura di un popolo che si è lasciato addomesticare.
Leo Ferrero questo lo aveva intuito.
Come scriveva Luigi Operti nella prefazione alla prima edizione: “Egli comprese che il fascismo non era la causa bensì l’effetto d’un crollo di valori morali, e da buon lottatore lavorò senza tregua alla loro restaurazione.”
Marcello Donativi