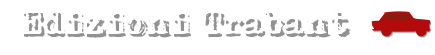Prefazione a
Lettere sul Regno di Napoli – William Gladstone
Il 13 novembre 1850 il Giornale Ufficiale delle Due Sicilie informava dell’arrivo a Napoli, tre giorni prima, di un personaggio illustre: l’«onorevolissimo Guglielmo Edoardo Gladstone, consigliere di Stato, membro del Parlamento britannico, con moglie, figlia, cameriera e domestico.» Fa quasi tenerezza come, nel lento mondo precedente al villaggio globale, facessero notizia anche le vacanze di un politico straniero non ancora del tutto affermato. Figlio di un mercante di Edimburgo con probabili ascendenze nella nobiltà scozzese, Gladstone era entrato in Parlamento sin dal 1832 tra le fila del partito conservatore Tory e in quel momento aveva alle spalle soltanto un incarico di ministro nel gabinetto di Robert Peel. All’epoca dei fatti, però, al governo sedeva Russel dei Whig e il nostro era all’opposizione. Lo scopo della visita, tuttavia, era ufficialmente di carattere personale e non politico: la figlia Mary aveva contratto una malattia agli occhi e si riteneva potesse esserle di giovamento il clima mite del sud Italia. Il politico inglese portava con sé delle lettere di presentazione rilasciategli dal principe di Castelcicala, rappresentante del governo napoletano a Londra e, appena giunto, oltre a consegnarle ai destinatari, si mise in contatto con l’ambasciatore inglese sir Temple offrendo la sua disponibilità per un eventuale incontro con Re Ferdinando II. Tale incontro non ebbe però mai luogo. Gladstone si trattenne a Napoli fino al febbraio 1851, quando si imbarcò per Marsiglia, prima tappa del viaggio di ritorno in Inghilterra.
Passarono pochi mesi, e l’11 luglio dello stesso anno era pubblicato a Londra un libbricino contenente una lettera (datata 7 aprile) di Lord Gladstone a George Hamilton Gordon, conte di Aberdeen, suo compagno del partito Tory, già in passato Segretario agli Affari Esteri e futuro Primo Ministro. A breve giro sarebbe stata resa pubblica anche una seconda lettera e le due, raccolte in volume, formeranno un pamphlet destinato a suscitare scandalo e polemiche, influenzare l’opinione pubblica internazionale ed essere oggetto di dibattito non soltanto presso i contemporanei, ma anche nel secolo e mezzo successivo: Due lettere al Conte di Aberdeen sulle persecuzioni di stato del Governo Napoletano, scritte dall’onorevole W.E.Gladstone deputato in rappresentanza dell’Università di Oxford. Erano nate le famose Lettere di Lord Gladstone.
Cosa aveva spinto il deputato inglese a trasformare il suo soggiorno privato in un’inchiesta sulla politica interna del Regno delle Due Sicilie? È una domanda sulla quale si sarebbero costruite diverse illazioni.
UN INGLESE A NAPOLI
C’è da dire che, se anche cercava riposo, la situazione che trovò a Napoli non era delle più tranquille. Il regno meridionale si portava dietro gli strascichi dei tragici avvenimenti del biennio 1847-49, con la rivolta della Sicilia e il fallito esperimento costituzionale. La somma degli eventi aveva causato una frattura insanabile tra gli intellettuali liberali e la Casa Reale, che già non partivano da buone basi ma avevano tentato di arrivare a un compromesso. Ferdinando II aveva concesso una Costituzione, ma non si era potuti nemmeno arrivare a mettere in moto la nuova macchina statale: il 15 maggio 1848 il tentativo dei deputati più intransigenti di effettuare un colpo di stato era stato represso nel sangue. Dopo altri due tentativi elettorali, dal 1849 in poi la Costituzione, formalmente non abolita, era stata sospesa e il Re aveva ripreso il pieno potere, guadagnandosi da parte dei liberali l’appellativo di Re spergiuro. Nel frattempo, diversi deputati compromessi con i fatti del 15 maggio furono arrestati o dovettero riparare all’estero, molti nel Regno di Sardegna, uno degli stati più accoglienti nei confronti di questi esuli. Fra chi riparò a Torino c’era Giuseppe Massari: ricordate questo nome. Altri personaggi più o meno legati all’esperimento costituzionale, anche se nell’immediato ne erano venuti fuori senza conseguenze personali, nel giro di pochi anni attirarono le attenzioni della polizia diretta dal nuovo ministro realista Peccheneda, e tra il 1849 e il 1850 una serie di arresti eccellenti portò a istituire il cosiddetto “processo della Società dell’Unità Italiana”. Sul banco degli imputati sedevano alcuni soggetti illustri: Luigi Settembrini, che nel 1848 era stato ministro del governo costituzionale, era accusato di essere l’autore di alcuni proclami anonimi antiborbonici (nei quali, va detto, tra le altre cose si incitava al regicidio); suo cognato Salvatore Faucitano era stato invece colto in flagrante in un maldestro tentativo di attentato bombarolo durante una visita di Papa Pio IX – o così almeno sosteneva l’accusa, dal momento che gli era esplosa addosso una bottiglia che teneva nel cappotto; Carlo Poerio era anch’egli un ex-ministro e fu coinvolto in seguito alla denuncia di un certo Jervolino; Michele Pironti era addirittura un magistrato della Gran Corte Criminale, deposto dal servizio perché compromesso con i moti del 1848. In tutto gli imputati erano quarantadue e, al di là dei casi specifici di arresto, l’accusa era di aver costituito una società segreta sul modello della carboniera, chiamata “dell’Unità Italiana”, con lo scopo di suscitare una rivoluzione liberale.
Fu questo il clima che Gladstone trovò a Napoli. Al suo arrivo, il processo era in corso da alcuni mesi e gli imputati, comparsi finalmente davanti ai giudici dopo un lungo periodo di quella che oggi chiameremmo carcerazione preventiva, si difendevano strenuamente negando ogni accusa, dichiarando inesistente la setta dell’Unità e anzi insinuando che le prove addotte contro di loro fossero contraffatte e false le testimonianze. Tra i liberali si diceva che quella fosse la vendetta del Re Bomba: dopo aver cancellato le concessioni del 1848 si sarebbe dedicato a perseguitare le persone che le avevano caldeggiate.
Gladstone trovò l’ambasciatore Temple piuttosto preoccupato dell’andamento del processo, anche perché vedeva coinvolte alcune figure di vedute liberali che negli anni avevano sviluppato una certa familiarità con il corpo diplomatico inglese. L’ambasciatore seguiva personalmente quasi tutte le sedute, avendo anche ottenuto dal presidente della corte Navarra di poter sedere vicino al Procuratore Generale, e la sua presenza era a tal punto divenuta una consuetudine da permettergli di interrompere il dibattimento ogni volta che non aveva ben compreso un’espressione italiana. Oltre a lui, altre persone che Gladstone frequentò durante il suo soggiorno furono George Fagan, primo addetto all’Ambasciata Britannica e amico personale di Carlo Poerio, anch’egli assiduo spettatore delle sedute processuali, e Giacomo Lacaita, all’epoca consigliere legale dell’Ambasciata, ma anche personaggio tenuto d’occhio dalla polizia come potenziale cospiratore. Il quadro che questi liberali napoletani e inglesi loro simpatizzanti dipinsero a Gladstone della situazione interna di Napoli gli causarono stupore e indignazione; a ciò si aggiunse la descrizione delle condizioni di vita nelle carceri napoletane, a tal punto fosca che Gladstone chiese di visitarne una. Da quel punto in poi divenne anch’egli spettatore costante del processo, e non è forse un caso che la sua partenza da Napoli sia avvenuta poco tempo dopo l’emissione della sentenza. Sentenza che comminò pene durissime: su quarantadue imputati otto furono assolti, due (tra cui Settembrini) condannati a morte, altri due all’ergastolo e i restanti (tra cui Poerio) a numerosi anni di carcere duro, cioè con l’aggravante della catena.
Al suo ritorno in patria, Gladstone manifestò ad alcuni colleghi il suo sdegno e l’intenzione di far qualcosa in favore della causa dei liberali italiani. Presto ciò giunse anche alle orecchie di alcuni esponenti del governo di Napoli. Il conte di Aberdeen, infatti, a cui Gladstone aveva confidato la sua idea di sottoporre il caso all’opinione pubblica, cercò di fare opera di mediazione e, per evitare incidenti diplomatici, ne rese partecipe l’ambasciatore Castelcicala, il quale a sua volta informò il Primo Ministro Giustino Fortunato. Così, quando il 7 aprile la prima lettera fu inviata ad Aberdeen in forma privata, questi ne spedì subito una copia a Castelcicala. L’ambasciatore fu subito preoccupato dal contenuto della missiva e la condivise con Fortunato, il quale, però – se diamo credito a una vulgata corrente – ritenne di non informare, se non per grandi linee, il re Ferdinando II. Gladstone era d’altra parte a conoscenza che la lettera fosse stata sottoposta al governo di Napoli e, secondo alcuni, sperava di ottenere dal governo napoletano delle risposte in merito alle sue rimostranze (quantomeno un miglioramento delle condizioni dei carcerati), altrimenti, in modo vagamente ricattatorio, il suo scritto sarebbe stato reso di pubblico dominio. Castelcicala, timoroso delle conseguenze che avrebbe avuto la diffusione della lettera, suggerì al Fortunato di preparare una serie di risposte alle accuse rivolte al governo, in modo da sottoporle inizialmente in forma privata ad Aberdeen e in un secondo momento, se la lettera fosse stata pubblicata, in forma ufficiale. Ma questo progetto andò avanti con lentezza, finché tre mesi dopo Gladstone annunciò al Castelcicala di essersi già organizzato per la pubblicazione. Nonostante gli estremi sforzi di Aberdeen per evitare lo scandalo, l’opera fu messa in vendita l’11 luglio.
Il pamphlet fece grande scalpore e fu anche un successo editoriale: nella sola Inghilterra se ne sarebbero prodotte otto ristampe. Come aveva temuto il Castelcicala, l’effetto fu di porre di colpo la dinastia dei Borboni di Napoli sul banco degli imputati dell’opinione pubblica europea. Ma cosa conteneva il libello di così scandaloso? Innanzitutto era scritto con una certa abilità retorica, in una prosa vibrante, non esattamente improntata alla misuratezza dei toni. Già nelle prime pagine, e prima ancora di argomentare le sue affermazioni, Gladstone parlava a proposito del governo borbonico di «una incessante, sistematica, deliberata violazione della legge da parte di quel Potere che dovrebbe essere incaricato di supervisionarla e preservarla»; «una tale violazione delle leggi naturali e umane, portata avanti allo scopo di violare ogni altra legge, non scritta ed eterna, umana e divina»; un governo che agisce con lo scopo di «distruggere la pace, la libertà e a volte, tramite la pena di morte, financo la vita dei più virtuosi, onesti, intelligenti, distinti e raffinati uomini dell’intera comunità»; con il risultato di arrivare al «totale ribaltamento di ogni morale e idea di comunità». Coronava il tutto il famoso giudizio, passato alla storia come un’affermazione dello stesso Gladstone, ma da lui riportato come raccolto da ignoti napoletani, secondo il quale il regno dei Borboni era «la negazione di Dio eretta a sistema di governo». Nelle pagine successive muoveva specifici capi di accusa nei confronti dei reggenti di Napoli: primo, avere incarcerato circa 20.000 sudditi per reato di opinione; secondo, avere intentato nei loro confronti dei processi irregolari, tramite la violazione delle normali procedure di polizia, la creazione di falsi capi di accusa e la messa in scena di processi-burla con sentenze già scritte; terzo, le condizioni disumane delle carceri, nelle quali erano sottoposti a un regime di vita intollerabile e in alcuni casi anche alla tortura fisica. Ne emergeva un quadro da romanzo gotico, nel quale un governo dispotico non faceva che arrestare gli elementi migliori della società, per rinchiuderli, incatenati, in oscure carceri sotterranee. A simbolo di tutto questa era preso Carlo Poerio, in quanto era il personaggio sul quale Gladstone aveva potuto raccogliere maggiori informazioni: nella sua lettera ne faceva il prototipo del martire, un cittadino integerrimo ingiustamente tormentato dalla tirannide.
Non passò molto prima che il testo fosse tradotto a beneficio dei lettori italiani. Già il 25 luglio il quotidiano Il Risorgimento diretto da Camillo Benso di Cavour iniziò la pubblicazione a puntate delle lettere. Chi aveva dimestichezza con la lingua inglese si era però già procurato una copia; e qui entra in scena il su citato Giuseppe Massari. Originario di Taranto, Massari aveva alle spalle una lunga storia di opposizione ai Borboni, che lo aveva portato a passare dieci anni di esilio tra il 1838 e il 1848. Rientrato in patria in occasione della Costituzione, era stato eletto deputato, ma, dopo i convulsi avvenimenti successivi, era nuovamente fuggito all’estero, questa volta in Piemonte. Quando lesse le lettere, come altri esuli napoletani ne gioì: sentiva che fosse stata fatta giustizia della loro situazione davanti all’Europa intera. Subito indirizzò una lettera a Gladstone per ringraziarlo, definendo la sua “una buona e nobile e santa azione”. Lesse poi la traduzione de Il Risorgimento e, giudicandola insoddisfacente, decise di produrne una di suo pugno: da quel momento in poi Massari sarà la personalità italiana che più di tutte si prodigherà per diffondere, propagandare e difendere dalle controaccuse l’opera di Gladstone.
Tuttavia, il libello non avrebbe avuto la stessa risonanza se non fosse stato presto oggetto di un dibattimento alla Camera dei Comuni inglese. Il 7 agosto 1851, infatti, il deputato George De Lacy Evans indirizzò a Henry John Temple, visconte di Palmerston, fratello del su menzionato ambasciatore e all’epoca Segretario agli Affari Esteri, un’interrogazione sulla politica interna degli stati italiani. Se la prima parte dell’interrogazione riguardava il Regno di Sardegna, la seconda faceva riferimento alle lettere di Lord Gladstone e chiedeva quali azioni avesse intrapreso il Governo Inglese nei confronti di quello napoletano in seguito alle tremende rivelazioni contenute nel libro. Palmerston dette una risposta ambigua: da un lato sosteneva che l’Inghilterra non avesse diritto di interferire nella politica interna di uno stato sovrano, dall’altro però lodava l’interesse dimostrato da Gladstone per l’argomento. Di conseguenza, il governo non avrebbe esposto alcuna rimostranza ufficiale a quello di Napoli; tuttavia Palmerston informava la Camera di avere già di sua iniziativa inviato una copia del pamphlet a tutti gli ambasciatori inglesi, affinché lo sottoponessero ai vari governi del mondo. Di fatto, ciò rappresentava una sorta di avallo ufficiale da parte dell’Inghilterra al contenuto delle lettere.
Il caso era ormai oggetto di dibattito internazionale: articoli a riguardo comparivano sull’Allgemeine Zeitung, sul Morning Chronicle, sul Times. Gran parte dell’Europa aveva iniziato a deplorare gli orrori perpetuati dal dispotismo di Napoli.
Ma, per l’appunto, come reagì il governo di Napoli? È importante ricostruirlo, dal momento che spesso gli scrittori di parte borbonica l’hanno accusato di scarso impegno e tempestività nel rispondere alla accuse dell’opinione pubblica.
Come già accennato, Castelcicala e Fortunato erano venuti al corrente della faccenda già prima che la lettera fosse stampata, e si erano già dati da fare per stilare una serie di risposte alla accuse formulate dal politico inglese. Probabilmente, a quel punto non era ancora chiaro sotto quale forma diffonderle, intanto però avevano iniziato a raccogliere informazioni e appunti in vista di una risposta, ufficiale o no che fosse. A questo proposito è utile un documento di archivio, senza autore né data (probabilmente però dell’agosto 1851), nel quale si appuntano una serie di verifiche da effettuare a proposito delle reali condizioni delle carceri di stato e riguardo a un libro di catechismo che Gladstone citava come esempio dell’ideologia ufficiale di stato, ma del quale, come risulta dal documento, a corte non si conosceva neanche l’esistenza. È altamente probabile, come vedremo a breve, che Fortunato si fosse fatto fornire anche i dati ufficiali sul numero di detenuti per reati politici nel Regno: questo per rispondere a una delle accuse più gravi di Gladstone, cioè la stima di circa 20.000 prigionieri. Restava da decidere la mossa successiva.
Certamente, la pubblicazione delle lettere, ma soprattutto il dibattito al Parlamento Inglese precipitarono gli avvenimenti. Si sente dire di solito che la stampa delle Due Sicilie (che, per quanto riguardava la politica, era esclusivamente stampa di stato) ignorò Gladstone. Ciò non è del tutto esatto. Alla fine di agosto, infatti, compariva un articolo sul Giornale Ufficiale, nel quale si deplorava l’avallo dato dal governo inglese alle «assurde, false ed inique calunnie» contenute nel libro e si esprimeva preoccupazione sulle ripercussioni che ciò avrebbe potuto avere sulle relazioni diplomatiche tra i due regni.
Ciò non era però sufficiente, e Castelcicala dovette pensare che la mossa migliore fosse farsi difendere da una personalità inglese simpatizzante per la casa reale borbonica. Si rivolse pertanto a Charles Mac Farlane. Era costui uno scrittore scozzese che aveva vissuto stabilmente in Italia nella prima metà del XIX secolo e vi aveva fatto ritorno negli anni successivi, diventando un appassionato di storia locale (è autore di una monografia sul brigantaggio pre-unitario ancora oggi abbastanza diffusa, per quanto fortemente interpolata). Utilizzando quasi certamente del materiale passatogli dall’ambasciatore napoletano (il che spiega quanto fosse informato sul numero dei prigionieri politici), Mac Farlane pubblicò una lettera aperta al conte di Aberdeen, come contraltare a quella di Gladstone. La difesa del Mac Farlane verteva su alcuni punti essenziali: in primo luogo, a suo parere, gli eventi del 1848 erano stati eccezionali e dunque giustificavano reazioni eccezionali, era dunque un errore giudicare i fatti senza contestualizzarli nel clima di rivoluzione e post-rivoluzione vigente a quel tempo a Napoli; in ogni caso, la reazione non poteva definirsi eccessiva: il numero dei detenuti per reati politici era infatti stimabile intorno ai 2000 (un decimo di quanto denunciava Gladstone) e le carceri di gran lunga più confortevoli della sua cupa descrizione. Sosteneva inoltre, citando varie fonti, l’effettiva colpevolezza degli imputati, in modo da rimandare al mittente l’accusa fatta al sistema giudiziario napoletano di confezionare prove ad arte per perseguitare degli innocenti. La lettera era ben scritta e portava della argomentazioni a favore delle sue tesi, ma aveva il vizio di partire con il piede sbagliato: nelle prime pagine, infatti, Mac Farlane si lasciava andare a delle insinuazioni poco difendibili sul Gladstone, secondo le quali il deputato di Oxford fosse sul punto di mutare casacca e, da Tory, diventare un Whig radicale o addirittura un… repubblicano socialista. Lo scrittore scozzese inaugurava, insomma, un leitmotiv che avrebbe accompagnato da lì in poi, fino ai giorni nostri, la stampa di simpatie filoborboniche: l’idea cioè che non solo il libro di Gladstone fosse un deliberato tentativo di destabilizzare il Regno delle Due Sicilie, ma che il suo stesso viaggio fosse sin dall’inizio organizzato a quello scopo, di concerto con il Palmerston.
Per questo e altri motivi, la lettera di Mac Farlane, presto definita da Massari uno schifoso libello, non sortì gli effetti sperati. A ciò contribuì anche la difficoltà a darle la stessa diffusione delle lettere del Gladstone: Castelcicala ne inviò alcune copie al Palmerston, pregandolo di spedirle agli ambasciatori inglesi allo stesso modo precedentemente fatto con il libello accusatorio; ma il ministro britannico rispose di no, giustificandosi con vaghe scuse. Lo stesso Mac Farlane, in una lettera a Giustino Fortunato, si lamentò del fatto che i giornali inglesi si rifiutavano di pubblicare il suo scritto. A Napoli dovettero sentirsi come accerchiati, senza molte possibilità di far sentire la propria voce.
Ci fu, è vero, anche chi difese il governo napoletano di sua iniziativa. Oltre alla Civiltà Cattolica, l’organo ufficiale dei Gesuiti, naturalmente propenso ad appoggiare le operazioni di polizia contro le società segrete, e questo nonostante il rapporto non sempre felice con la corte di Napoli, un’altra illustre penna fu quella del francese Jules Gondon, direttore dell’Univers. Costui pubblicò a puntate sul suo giornale una lettera aperta a Gladstone, nella quale sposava molte delle tesi difensive del Mac Farlane, ma nell’ambito di un discorso molto più ampio e documentato; vi univa però il punto di vista religioso, ragion per cui, alle insinuazioni che Gladstone fosse d’improvviso divenuto un rivoluzionario, aggiungeva alcune allusioni alla sua fede anglicana come motore primo della sua avversione verso un regno cattolico.
Mancava però ancora una risposta ufficiale da parte del governo di Napoli. Questa arrivò finalmente sotto forma del libretto Rassegna degli errori e delle fallacie pubblicate dal sig. Glasdstone in due sue lettere indiritte al Conte Aberdeen sui processi politici nel Reame delle Due Sicilie, datata 25 agosto 1851. Il testo è anonimo, ma se ne è individuato l’autore in Salvatore Mandarini, giudice della Gran Corte Criminale.
Aveva, come è facile immaginare, carattere istituzionale, il che spiega perché poco spazio fosse concesso alla retorica e all’attacco personale: prima di entrare nel merito della questione, l’anonimo riconosceva al Gladstone le buone intenzioni, rimproverandolo al massimo di essere stato sviato da un sentimento di umana pietà unito a informazioni errate. Questa è una delle ragioni per cui, ai contemporanei come ai posteri, la Rassegna sembrò non solo tardiva, ma debole.
Per il resto, le argomentazioni a favore del governo seguivano a grandi linee quelle già espresse dal Mac Farlane e dal Gondon, con in più una fiera difesa della modernità e del garantismo delle leggi napoletane, sottolineati a più riprese dalla citazione in nota di specifici articoli del codice. Al libello erano allegate delle tabelle con i dati ufficiali sul numero dei detenuti del Regno.
L’opuscolo fu inviato ai principali giornali, italiani e non, considerati amici. Si cercò anche di farlo leggere in Inghilterra, ma, come già accaduto col Mac Farlane, l’operazione ebbe scarso successo: mille copie di una traduzione in inglese furono inviate a varie personalità della politica e della cultura, ma andarono incontro a fredda accoglienza; altrettanto infruttuoso fu il tentativo di farlo pubblicare sulla stampa britannica, la quale si mostrò ostile all’iniziativa. L’opinione pubblica inglese pareva avere già sposato senza appello il punto di vista delle Lettere.
Non fu invece indifferente il Gladstone stesso, che nel gennaio 1852 licenziò un nuovo scritto, da molti considerato una specie di “terza lettera”, dal titolo An examination of the official reply of the Napolitan Government, presto tradotta dal Massari e pubblicata a Torino. È un testo interessante, sia perché rappresenta l’ultimo significativo intervento nell’ambito di questa polemica, sia perché Gladstone, pur senza rinnegare la sostanza della sua battaglia, fece una parziale ritrattazione di alcuni punti. Ammise esser priva di fondamento e soltanto una voce senza riscontro il fatto che Luigi Settembrini fosse stato sottoposto a tortura; corresse un errore fattogli notare a proposito della pena de’ ferri, avere cioè sostenuto che fossero incatenati in carcere dei rei che non erano invece stati condannati al carcere duro e avere addirittura insinuato che tale pena fosse stata istituita appositamente per i condannati di quel processo; ritrattò l’affermazione che molti imputati assolti fossero ancora detenuti nonostante il proscioglimento. Riguardo, invece, al numero dei prigionieri politici, si schermì sottolineando come la stima di 20.000 fosse soltanto una credenza comune da lui ritenuta plausibile, e aggiungeva che, anche di fronte alle cifre fornite dal governo, continuava a essere credibile in virtù di un gran numero di arresti illegali. Egli era dunque disposto ad ammettere alcune imprecisioni nei dettagli; non tali però da inficiare il quadro di insieme.
UNA POLEMICA NON SPENTA
Qui termina la storia delle lettere di Lord Gladstone, per lo meno quella relativa alla polemica coeva. La domanda che ci si deve porre, a questo punto, è quanta influenza questo episodio abbia avuto sugli avvenimenti storici successivi. È innegabile, infatti, che il pamphlet e il conseguente scandalo esercitarono un ruolo capitale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea a favore della causa degli unitari italiani, convincendola che il Regno delle Due Sicilie fosse effettivamente una detestabile tirannia. A parlare, infatti, non era più come in passato un esule napoletano, ma un eminente politico inglese, e il suo avallo fu fondamentale: se negli anni successivi la politica inglese simpatizzò sempre di più con il Regno di Sardegna, se così tanti volontari prestarono il proprio braccio o perlomeno il proprio finanziamento alle imprese degli unitari, ciò fu dovuto anche alla martellante propaganda anti-borbonica che prese avvio alla pubblicazione delle lettere. Ciò che è notevole osservare, in molti casi attecchirono nella coscienza comune anche molti degli aspetti meno verificabili ma più d’impatto del racconto di Gladstone, persino quelli su cui l’autore stesso aveva ritrattato.
Pensiamo al tema della tortura. Nella prima lettera Gladstone riferiva una voce secondo cui Luigi Settembrini in carcere fosse stato sottoposto a tortura tramite aghi conficcati sotto le unghie; tra l’altro l’episodio non era raccontato come un tentativo di strappare la confessione all’imputato, ma come un non ben giustificato modo per tormentarlo nel periodo in cui, già condannato, scontava la pena. Questo fu uno dei passi della lettera che più indignò i sostenitori dei Borboni, i quali non solo fecero notare la totale assenza di prove per un’asserzione così grave, ma rivendicarono anche essere stato il regno meridionale uno dei primi in Europa ad abolire l’istituzione della tortura. Si trattava con tutta probabilità di una diceria, e prova ne è che lo stesso Settembrini, quando anni dopo scrisse le sue memorie, incentrate in gran parte sulla propria odissea giudiziaria, non fece menzione alcuna di maltrattamenti di questo tipo. Lo stesso Gladstone, come si è visto, fece marcia indietro sull’argomento nel suo terzo scritto, ammettendone l’indimostrabilità. Eppure l’idea che nelle carceri borboniche fossero in uso strumenti di tortura di tipo medievale si diffuse rapidamente, soprattutto all’estero. Si racconta che negli anni ’50 a Londra un esule italiano, un certo Nani, avesse aperto una sorta di piccolo museo in cui erano esposti sedicenti strumenti di tortura in uso nelle carceri borboniche. E senza le lettere di Gladstone avrebbero avuto meno credito anche successive accuse lanciate sulla stampa internazionale alla polizia borbonica, come gli articoli del Morning Post del 1856 con cui non solo si descrivevano a parole, ma anche tramite disegni, dei presunti strumenti di tortura utilizzati contro i patrioti siciliani, tra i quali la famigerata cuffia del silenzio.
Più in generale, le lettere ebbero un ruolo primario nel far sedimentare nell’opinione pubblica, anche delle generazioni successive, il ritratto a tinte fosche dei Borboni di Napoli che perdura ancora oggi. Un esempio, tra i tanti, può essere tratto da una biografia di Gladstone stampata negli Stati Uniti qualche decennio dopo i fatti di cui ci occupiamo. In questo breve estratto si può vedere la semplificazione con cui gli avvenimenti d’Italia erano narrati all’estero:
Nel tempo in cui Mr. Gladstone visitò Napoli, l’Italia era percorsa da un crescente desiderio di indipendenza e unione. Le misure tristemente famose adottate dal Re di Napoli per reprimere nei suoi domini ogni aspirazione alla libertà ebbero il solo effetto di rendere il popolo ancora più determinato e la libertà cui aspirava più certa. Il suo cattivo governo durò ancora per pochi anni e fu il motore primo dei movimenti rivoluzionari che agitavano in continuazione la penisola italiana. […] Il brillante successo di Garibaldi nel 1860 riempì Francesco II di terrore. Costui, come tutti gli uomini malvagi, era disposto a fare le più sfarzose promesse di riforme liberali, pur di sfuggire alle conseguenze dei suoi crimini. Ma il suo pentimento fu tardivo. Garibaldi, vittorioso, emanò un decreto secondo cui le Due Sicilie, redente tramite il sangue italiano, e che avevano liberamente eletto il loro dittatore, formavano parte integrante di un’Italia unita e indivisibile, sotto il re costituzionale Vittorio Emanuele II e i suoi discendenti. Francesco II fu detronizzato ed espulso dal suo regno, come conseguenza inevitabile della politica di odio sua e dei suoi predecessori.
Se dunque, come è avvenuto recentemente, un personaggio del calibro di Roberto Benigni ha potuto affermare in televisione, in un discorso tenuto nell’ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, che i Borboni erano “peggio dei nazisti”, una parte di responsabilità va anche a lord Gladstone.
Per questa ragione, il suo nome, negli ambienti culturali simpatizzanti per la ex casa reale di Napoli, ha assunto col tempo una fama più che sinistra. Già all’epoca si volle presto gettare nei confronti dell’operato del politico inglese il sospetto della premeditazione. Il viaggio in Italia di Gladstone, si diceva, lungi dall’essere di natura privata, era sin dal principio organizzato allo scopo di raccogliere materiale diffamatorio nei confronti del Regno delle Due Sicilie; questo complotto era stato organizzato da Palmerston in persona, e ciò in virtù di una politica estera inglese vòlta ad avere delle mire sulla Sicilia se non sull’intero meridione d’Italia. Di questo avviso sono i più famosi scrittori ottocenteschi di parte borbonica, Giacinto De Sivo e Giuseppe Buttà, che probabilmente utilizzò il precedente come fonte di molte sue affermazioni. Oltre ai sospetti sulle reali intenzioni di Gladstone, la pubblicistica a lui ostile gli rimproverava una certa superficialità di metodo: aver egli raccolto notizie di seconda mano, da fonti tendenziose e senza l’opportuna verifica (prova ne sarebbero le numerose espressioni presenti nel testo come si dice, mi è stato riferito, a quanto pare etc. e le tante imprecisioni, alcune delle quali, come si è visto, successivamente ammesse dall’autore stesso); infine, essersi a volte spacciato per testimone oculare di situazioni a cui, nella realtà, non avrebbe assistito.
In tempi più recenti, l’argomento è stato ripreso in un saggio degli anni ’70 presto diventato un classico della letteratura revisionista del Risorgimento, La conquista del Sud di Carlo Alianello. Il libro appartiene più al genere polemico che alla ricerca storica, ed è un’appassionata requisitoria che intende descrivere il processo dell’unità italiana come un’aggressione coloniale del Regno di Sardegna ai danni del meridione. È significativo che l’opera inizi proprio raccontando le vicende del Gladstone, raccogliendo e ampliando le argomentazioni già utilizzate dalla pubblicistica filo-borbonica ottocentesca: per Alianello, l’episodio delle lettere è la dimostrazione di un complotto internazionale allo scopo di preparare il terreno per l’unificazione italiana sotto la bandiera sabauda. Il saggio ha riscosso nel tempo un certo successo e ancora oggi, anche laddove non viene citato, è la fonte principale di un paio di aneddoti che intendono dimostrare la malafede del Gladstone. Conviene dunque spendere un paio di parole su questi.
Il primo è il seguente:
Gladstone, tornato a Napoli nell’anno 1888-1889, fu ossequiato e festeggiato dai maggiorenti del così detto Partito Liberale, i quali non mancarono di glorificarlo per le sue famose lettere con la negazione di Dio, che tanto aiutarono la nostra rivoluzione; ma a questo punto il Gladstone versò una vera secchia d’acqua gelata sui suoi glorificatori. Confessò che aveva scritto per incarico di lord Palmerston, con la buona occasione che egli tornava da Napoli, che egli non era stato in nessun carcere, in nessun ergastolo, che aveva dato per veduto da lui quello che gli avevano detto i nostri rivoluzionari.
Il brano appartiene a un volume di Domenico Razzano intitolato La biografia che Luigi Settembrini scrisse di Ferdinando II, ma nelle note è spiegato come Alianello lo abbia tratto dalla monografia di Cotugno che abbiamo spesso consultato anche noi. Si tratta dunque di una notizia di seconda mano. In sé e per sé dà l’idea di essere poco più di un pettegolezzo, un aneddoto poco verificabile e privo di riscontri in altre fonti. E bisogna d’altra parte sottolineare come, anche ammettendone la veridicità, Gladstone avrebbe semplicemente sostenuto di avere avuto un secondo fine e non avere controllato a sufficienza le informazioni ricevute, non di avere inventato tutto. Invece oggi da più parti questo episodio, tratto dall’Alianello che lo aveva letto dal Cotugno che lo aveva estratto dal Razzano, viene citato come prova ultima del fatto che Gladstone avesse scritto il falso.
Più interessante a nostro avviso, e più utile a centrare il nocciolo della questione, è un’altra citazione fatta dall’Alianello e oggi piuttosto diffusa. Si tratta di un articolo di Ferdinando Petruccelli della Gattina comparso su L’unione di Milano il 22 gennaio 1861 e consultato di prima mano da Alianello, che ne possedeva una copia d’epoca. Petruccelli della Gattina era, come Carlo Poerio, un liberale; come Massari era stato costretto all’esilio dopo il 1848 e, come entrambi, era stato in seguito eletto deputato del Regno d’Italia. A differenza di loro, però, si distinse in più occasioni per un approccio meno agiografico agli avvenimenti del Risorgimento a cui pure aveva partecipato, segnalandosi anzi per il sarcasmo di molti suoi scritti. Basta pensare alla sua opera più famosa, I moribondi del Palazzo Carignano, impietosa satira del neonato parlamento italiano, nella quale in più occasioni deride lo status assunto da Poerio di martire nazionale:
Poerio è una reliquia. Lo si imbandisce nelle tavole ministeriali, come un oggetto di curiosità egiziana e di appetito ben conservato – perchè la poca forza che resta a questo gran martire si è concentrata nelle mascelle, mascelle potenti, le quali, quando non masticano, lavorano un concettino all’Achillini, onde presentarlo ad una signora. Quanto al cervello, Poerio l’ama meglio à la sauce blanche che nella sua testa. Colpa senza dubbio di quello scellerato di re Borbone, il quale assiderò quest’uomo di Plutarco nelle prigioni di Montesarchio – ovvero di quel burlone di Gladstone, il quale creò questo grand’uomo all’uso di John Bull, come Caracalla creò console il suo cavallo.
Lasciamo da parte il lapsus tra Caligola e Caracalla. Poerio sarebbe stato dunque una figura leggendaria, quasi creata ad arte da un burlone a uso e consumo del pubblico inglese (per John Bull s’intendeva all’epoca l’inglese medio o l’Inghilterra nel suo complesso). Ma veniamo al passo citato da Alianello. Qui Petruccelli della Gattina è ancora più esplicito:
Poerio è un’invenzione convenzionale (e chi fu con lui) della stampa anglo-francese. Quando noi agitavamo l’Europa e la incitavamo contro i Borboni di Napoli, avevamo bisogno di personificare la negazione di questa orrida dinastia, avevamo bisogno di presentare ogni mattina ai credenti leggitori d’una Europa libera una vittima vivente, palpitante, visibile, che quell’orco di Ferdinando divorava a ogni pasto. Inventammo allora il Poerio. Poerio era un uomo d’ingegno, un galantuomo, un barone; portava un nome illustre, era stato ministro di Ferdinando e complice suo in talune gherminelle nel 1848. Poerio era stato deputato e fratello d’Alessandro… Ci sembrò dunque l’uomo opportuno per farne l’antitesi di Ferdinando, e il miracolo fu fatto.
La stampa inglese e francese stuzzicò l’appetito di quel filantropo e uomo di stato, Gladstone, il quale, recandosi a Napoli, volle vedere da presso questa specie di nuova maschera di ferro; lo vide. Si mosse a pietà. E Gladstone fece come noi; magnificò la vittima onde renderne più odioso l’oppressore; esagerò il supplizio, onde commuovere a maggior ira la pubblica opinione.
E Poerio? Poerio, che oggi si mescola in ogni minestra, fu creato da cima a fondo.
Il Poerio reale ha preso sul serio il Poerio fabbricato da noi, in dodici anni, in articoli a 15 centesimi la linea.
Lo hanno preso sul serio coloro che lessero di lui, senza conoscerlo da presso. L’ha preso sul serio quella parte della stampa che si era fatta complice nostra, credendoci sulla parola. Ma capperi! Che l’abbia preso sul serio anche Cavour!
È un passo importante, perché getta sul piatto della nostra discussione una domanda cruciale: quanto può essere considerata affidabile una fonte che scrive per ragioni di propaganda politica? Questo vale, naturalmente, per tutti.
Ciò che, infatti, maggiormente colpisce nello studiare le vicende delle lettere di Gladstone, è la difficoltà di trovare, ieri come oggi, chi si accosti all’argomento senza l’intento di dimostrare una tesi a priori, pro o contro che sia. Semplificando: ancora oggi, a distanza di un secolo e più, ci si ritrova stretti tra chi tratta l’argomento decidendo di dare credito a qualsiasi affermazione di Gladstone e liquidando le argomentazioni di chi all’epoca difendeva il governo di Napoli come deboli e prive di fondamento (spesso senza sentire nemmeno l’esigenza di informare il lettore su quali fossero queste argomentazioni), e dall’altra parte chi, per screditare il Gladstone, è disposto a prendere per buona qualunque fonte, anche il pettegolezzo di corridoio.
Un approccio storiografico maturo, invece, dovrebbe, a nostro avviso, lasciare da parte l’adesione a questo o quel partito e concentrarsi, almeno all’inizio, su un’unica, fondamentale domanda: Gladstone scrisse il vero o no? Tutto il resto ne consegue.
È un’indagine che inevitabilmente necessiterà non solo di un vaglio critico delle fonti letterarie, ma soprattutto di una lunga ricerca di archivio, la sola utile a dipanare la matassa dei punti più spinosi della questione. Per esempio, l’entità numerica degli imputati per reati politici, dal momento che, su una popolazione complessiva stimata tra gli 8 e i 9 milioni di abitanti, c’è una bella differenza tra i 20.000 detenuti denunciati dal Gladstone e i 2000 dichiarati dal governo.
Il nostro augurio è che, presto o tardi, qualcuno si assuma il compito di questa ricerca e cerchi, nei limiti del possibile, di farlo, come si dice, sine ira ac studio. Nel frattempo, ci sia però concessa qualche riflessione.
Al giorno d’oggi pochi oserebbero negare la reale esistenza di una setta chiamata Società dell’Unità d’Italia e il fatto che Carlo Poerio, Luigi Settembrini, Salvatore Faucitano, Michele Pironti e altri ne facessero parte. È ormai assodato che la maggior parte dei capi di accusa del processo del 1850 fossero, nella sostanza, esatti. Se gli imputati negavano, non era soltanto per trovare una via d’uscita giudiziaria, ma anche per interpretare al meglio quel ruolo di martire che tanto poteva giovare alla causa anti-borbonica. Gli stessi condannati, in molte occasioni, lo avrebbero ammesso negli anni successivi, talora vantandosene come prova del ruolo svolto a favore della rivoluzione. A tal proposito, possiamo scegliere, tra i tanti, un documento estratto da una seduta della Camera dei Deputati del 29 aprile 1867, durante la quale venne commemorata la figura di Carlo Poerio, scomparso il giorno precedente. Giuseppe Massari, nel suo intervento, fu abbastanza prudente, senza dilungarsi molto sulle ragioni delle traversie giudiziarie del defunto:
Nel 1851 lo condannarono a 24 anni di ferri. […] La sua condanna fu precipua occasione delle famose lettere di Gladstone; ei divenne così la personificazione del martirio dei popoli delle Due Sicilie.
Quando però prese la parola Francesco Crispi, col suo fare sanguigno fu molto più esplicito, ammettendo, senza nemmeno troppi giri di parole, che le accuse a carico di Poerio fossero veritiere. Non solo, ma aggiunse anche delle informazioni a cui la polizia borbonica non era arrivata, come il coinvolgimento di Poerio nell’insurrezione siciliana:
Io, facendo eco alle cose dette dai due illustri oratori, sento l’obbligo di confermare con fatti che sino all’altro giorno potevano essere un segreto, ma che oggi appartengono alla storia, gli atti di Carlo Poerio.
Il Poerio, che io conobbi 27 anni addietro, fu invero il tipo del cospiratore italiano, quando, ben inteso, altra via non c’era per liberare la patria, che quella di cospirare contro la tirannide. Egli succhiò colla vita il culto della patria e l’odio contro i Borboni. […] Carlo Poerio fu il capo, e, come diceva benissimo l’onorevole Pisanelli, fu il cuore, fu la mente della gioventù delle provincie meridionali. Io soggiungerò che egli fu il centro pei Napoletani e pei Siciliani, i quali si erano raccolti nell’intendimento di rovesciare il trono dei Borboni. […] Quando, il 20 dicembre 1847, io partii per la Sicilia, onde metterci d’accordo negli atti necessari alla insurrezione che poi scoppiò il 12 gennaio 1848, nella prigione di Carlo Poerio, a Santa Maria Apparente, si stabilì questa concordia tra Napoletani e Siciliani, che poscia non fallì nella comune opera contro i Borboni. Carlo Poerio era ancora in prigione quando la Sicilia insorgeva; e l’11 gennaio, prima che io partissi per la seconda volta, andai a stringergli la mano, ci accordammo su ciò che conveniva fare nel continente, e lo lascia pieno di fede nel successo della causa nazionale.
Viene dunque a cadere subito, e senza grossi sforzi di indagine, uno dei maggiori pilastri del discorso di Gladstone, l’idea cioè che la polizia napoletana arrestasse degli innocenti, fabbricando false prove a loro carico, al solo scopo di soddisfare la sete di vendetta del re.
Della tortura si è detto. Si tratta di una voce comparsa a più riprese sulla stampa ottocentesca, senza trovare mai alcun riscontro. Naturalmente non siamo così ingenui da pensare che non avvenissero casi di abuso, come tristemente capita a tutte le polizie del mondo quando si trovano a fronteggiare indagini inerenti la sicurezza dello stato; ma che la polizia borbonica disponesse di celle sotterranee dotate di strumenti di tortura degni dell’Inquisizione Spagnola, questo va realmente liquidato come una favola.
Le stesse prigioni non erano certo un modello di civiltà, ma condividevano il livello di degrado degli altri paesi europei. La catena era in uso anche altrove, e nella stessa Inghilterra si emanavano condanne anche più crudeli, come i lavori forzati. Il tentativo di impressionare il lettore descrivendo il sistema carcerario napoletano poteva, dunque, avere successo soltanto su chi non avesse mai visitato un carcere dell’epoca, e ed essere così indotto a credere che quella descritta fosse una peculiarità del governo borbonico.
Tirando le somme: anche a un’analisi superficiale, al giorno d’oggi le lettere di Gladstone dimostrano di non reggere il tempo e contengono molte più imprecisioni e notizie errate di quanto l’autore non fosse disposto ad ammettere, in una misura tale che, ragionando secondo il diritto odierno, vi si potrebbe ravvisare a tratti il reato di diffamazione.
Come detto, però, sarà utile in futuro un vaglio critico e documentale delle sue affermazioni. Con il presente volume, per il momento, abbiamo cercato quantomeno di fare ordine presentando le principali fonti letterarie in materia. Un compito laborioso ma, a nostro avviso, necessario, dal momento che fino a oggi chi si volesse accostare all’argomento si è trovato nella condizione di dover consultare le testimonianze favorevoli e quelle contrarie a Gladstone nettamente separate tra loro, quasi a compartimenti stagni, senza un inquadramento storico né un corretto ordine cronologico.
CONCLUSIONE
Giunti al termine della nostra presentazione, non resta che chiedersi come si conclusero le vicende dei personaggi che abbiamo citato.
Coerentemente con l’ideologia paternalistica del governo borbonico, le pesanti condanne espresse ai danni degli imputati non furono mai eseguite interamente, ma per gradi commutate in pene più lievi. Chi era stato condannato a morte, come Settembrini, vide la pena tramutata in ergastolo; anche chi, però, era stato destinato a una lunga detenzione con regime duro non scontò la pena nella sua interezza. Nel 1859 il governo napoletano, allo scopo di liberarsi di personaggi così scomodi per la pubblica opinione, prese una decisione apparentemente motivata da ragioni di clemenza, che però si sarebbe rivelata fatale: commutare la pena di un gran numero di prigionieri politici nell’esilio. Poerio, Settembrini, Faucitano e altri illustri detenuti (come Silvio Spaventa) furono forzatamente imbarcati in direzione Stati Uniti; la nave fu però dirottata verso l’Irlanda, i circa sessanta si sparpagliarono tra l’Inghilterra e il Piemonte in qualità di rifugiati politici. A scaglioni avrebbero fatto tutti ritorno in patria, chi al seguito di Garibaldi, chi dopo la proclamazione del Regno d’Italia.
Carlo Poerio fu deputato del nuovo parlamento italiano, riverito come un martire redivivo; prese però infine le distanze dalla vita politica e morì in povertà. Settembrini tornò a dedicarsi all’insegnamento e agli studi letterari, e fu autore di un libro di memorie sulle sue traversie giudiziarie che ebbe una certa diffusione a fine ottocento. Chi non venne meno all’impegno politico fu Giuseppe Massari: eletto più volte deputato, divenne popolare, tra l’altro, come segretario della Commissione Parlamentare sul Brigantaggio e in quella veste, nel 1863, lesse alla Camera la relazione finale che spianò la strada alle famigerate leggi repressive di Giuseppe Pica.
Quanto a Gladstone, andò incontro a una luminosa carriera: per quattro volte Primo Ministro, è tuttora considerato uno dei politici più influenti della storia inglese contemporanea. Non si spezzò mai il suo legame con l’Italia, paese che amava particolarmente e dove anche a distanza di anni era ricordato con simpatia dai liberali locali per l’apporto dato alla loro causa. Chi, invece, parteggiava per altre fazioni, non gli perdonò mai la pubblicazione delle lettere.
Solitamente il finale che si dà a questa vicenda, almeno da parte borbonica, è infatti l’aneddoto, già citato, del Gladstone che ammette in pubblico di avere inventato le proprie accuse verso il governo di Napoli. Tale scenetta, come spiegato, è molto dubbia.
Pochi conoscono, invece, un’altra possibile conclusione, questa sì autentica, della nostra storia. L’8 maggio 1863, all’incirca nel periodo in cui Giuseppe Massari si occupava del brigantaggio, lo stesso argomento venne dibattuto alla Camera britannica. A distanza di anni i deputati inglesi tornavano a parlare dei diritti umani nel meridione d’Italia: questa volta, però, Lord Gladstone non sedeva tra gli accusatori, ma si ritrovò sul banco degli imputati. Il deputato conservatore Cavendish-Bentinck, infatti, partendo da alcune analogie tra il Sud Italia pre-unitario e post-unitario, rispolverò dai ricordi le denunce fatte da Gladstone dieci anni prima, per accusarlo senza mezzi termini di doppiopesismo:
Nel 1851 il Cancelliere dello Scacchiere scrisse quel famoso libello, con cui denunciava, con energia ed eloquenza, gli orrori delle prigioni napoletane; e il nobile Conte, a quel tempo Ministro degli Esteri, in risposta a una domanda posta dal nobile rappresentante di Westminster, rispose che avrebbe inviato una copia del libro a tutti i diplomatici britannici, nella speranza di trarne beneficio per tutti. […] Quali erano le accuse mosse al Governo di Napoli dall’onorevole nel suo libro?
Primo, che 20.000 e più persone fossero confinate nelle prigioni di stato. Cosa abbiamo adesso? Il Console Generale Bonham ha ammesso che i prigionieri politici sono più di 20.000. Molti Deputati hanno portato testimonianze dello stesso tipo. La Camera può apprendere dal signor Crispi che a Palermo ci sono 1300 prigionieri politici. Dal deputato Lazzaro (il 9 aprile passato) che la prigione di Salerno, costruita per contenere 600 detenuti, ne ha attualmente 1400. Potenza 1100 invece di 600. Lanciano 700 invece di 200. Eppure davanti a questi fatti l’onorevole tace.
Secondo, l’onorevole era indignato del fatto che la polizia napoletana facesse delle perquisizioni domiciliari. […] E invece, adesso che è in vigore lo Statuto Albertino, così tanto più liberale della Costituzione Napoletana del 1848, e le perquisizioni e arresti arbitrari sono all’ordine del giorno, […] adesso che sono sottoposti ad arresto i familiari di presunti briganti fino al terzo grado di parentela e centinaia di persone, per il mero sospetto di complicità, sono imprigionate e spesso fucilate senza processo, e molte persone, già assolte dai tribunali, continuano a essere trattenute in prigione, ebbene, l’onorevole tace.
Terzo, l’onorevole ha protestato contro il lungo periodo di carcerazione preventiva degli indagati prima del processo. Adesso che centinaia di infelici, di tutte le età e di entrambi i sessi, marciscono in galera senza speranza, e invocano l’aiuto degli stranieri di passaggio, adesso che un simile flagello è stato ammesso interamente persino dal Console Generale Bonham, l’onorevole tace.
Quarto, l’onorevole ha descritto lo stato delle prigioni in modo divenuto proverbiale. Qual è il loro stato attuale? Facciamogli leggere i resoconti di Crispi, Ricciardo, e del Console Bonham! Le catene dei prigionieri politici – le catene dei Garibaldini, la cui colpa è di avere amato troppo l’unità d’Italia, non riescono a suscitare la compassione dell’onorevole, ed egli e il Conte tacciono.
Infine, l’accusa principale dell’onorevole nei confronti del Governo Napoletano era di essere del tutto illegittimo. […] E lo Statuto Albertino è forse rispettato? Lo stato d’assedio a Napoli e in Sicilia è durato più di qualunque stato d’assedio sotto il governo borbonico; ed è un fatto ormai che la stampa libera sia imbavagliata. Non intendo in alcun modo difendere o giustificare minimamente l’operato degli ultimi governi borbonici. Ma il nuovo ordine ha forse migliorato la situazione? Sotto i Borboni, come ammette lo stesso onorevole, la pena di morte era rara; invece oggi centinaia, se non migliaia di persone vengono fucilate senza processo, e comandanti come il famigerato Fumel, le cui atrocità invano il Governo di Sua Maestà ha tentato l’anno passato di nascondere, sono stati mandati a bruciare e distruggere paesi interi e massacrarne gli abitanti. […] Onorevole, io non mi appello a lei in nome della coerenza, perché davanti a questa parola farebbe orecchie da mercante, ma in nome della pietà, affinché levi ancora la sua voce per la causa di Napoli, e si prodighi per mitigare i mali che affliggono quella infelice popolazione.
E con questa maligna citazione, che – ricordiamo – non viene dalla voce di un fazioso borbonico, ma di un parlamentare inglese, ci piace terminare e lasciare al lettore di immergersi nella gran mole di documenti da noi raccolti. E che il dibattito, sempre che se ne senta il bisogno, abbia di nuovo inizio.
Marcello Donativi