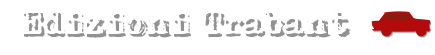Prefazione a
La fine di un regno – Raffaele De Cesare
Accade talvolta, quando le passioni sono accese, specialmente quelle politiche, che i ben intenzionati siano clamorosamente fraintesi. Spesso è un giochetto intenzionale. E così avvenne che Raffaele De Cesare, di per sé un liberale e un moderato, fosse un bel giorno accusato di essere un nostalgico del dominio borbonico. Il fatto ebbe luogo nell’ambito della tornata elettorale del 1904. De Cesare, nella sua pur breve esperienza politica, si era messo contro nientemeno che Giovanni Giolitti: scattò allora un fenomeno che era un’abitudine oggi come allora, e che noi chiameremmo macchina del fango.
Lo spunto venne dall’imponente opera saggistica a cui De Cesare dava in quegli anni gli ultimi ritocchi, intitolata La fine di un Regno: nelle intenzioni, un quadro particolareggiato degli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie, dal 1848 all’entrata di Garibaldi a Napoli. Piccolo particolare: il declino dei Borboni non era narrato con l’acrimonia tipica di tanti pubblicisti, ma con pacatezza, quasi con un velo – se non di solidarietà – di simpatia. Ciò prestò fin troppo facilmente il fianco ai propagandisti: ecco, si disse, De Cesare è in fondo un filo-borbonico, rimpiange l’antico regime e via di questo passo. Allo storico costò la mancata rielezione alla Camera dei Deputati e l’apparente fine della carriera politica (apparente, perché, sei anni più tardi, sarebbe stato nominato Senatore del Regno).
Quello citato è un caso limite, tra le critiche ricevute nel tempo dall’opera che presentiamo. In effetti, a conti fatti ben pochi hanno equivocato a tal punto da attribuire al De Cesare simpatie filo-borboniche. Gli appunti mossi alla Fine di un Regno, semmai, si sono concentrati sulla serietà storiografica del testo: non di storia si tratta, hanno detto in molti, ma di storia del costume, ai limiti del pettegolezzo. “Ora sappiamo solo come questo regno è finito, non perché è finito” fu il commento in un necrologio all’indomani della scomparsa dell’autore. Tale posizione, sebbene non priva di interesse, risulta però ingenerosa se rapportata alle intenzioni con cui l’opera è stata scritta. Cercheremo di spiegare quindi perché, nonostante i loro evidenti limiti, questi due volumi sono secondo noi di enorme interesse.
Raffaele De Cesare, innanzitutto, non era né un nostalgico dell’antico regime, né un conservatore. Apparteneva a una famiglia dell’entroterra barese discretamente in vista (lo zio Carlo fu un famoso economista dell’epoca) e di tradizioni liberali, non al punto da essere degli espliciti oppositori del regime borbonico, ma abbastanza per entrare nel mirino delle repressioni seguite ai moti insurrezionali del 1799 prima e, più recentemente, del 1848. Il nostro, però, per semplici ragioni anagrafiche (nacque nel 1845) non poté vivere da protagonista il Risorgimento ed entrò nella vita adulta quando il regime dei Borboni era ormai caduto. Trasferitosi prima a Napoli per compiere gli studi e in seguito a Roma, visse una carriera abbastanza prestigiosa nel giornalismo, coronata da incarichi di responsabilità (la direzione de La Nuova Patria) e alcuni di quegli scandali che aiutano a farsi un nome (come nel 1889 un processo per oltraggio alla Corona, concluso con l’assoluzione, a seguito di un articolo in cui si criticava l’operato politico del monarca). De Cesare nasce dunque come giornalista e tale attitudine resterà anche nei suoi libri. Bisogna tenerne conto. E, infatti, la stessa Fine di un regno vide la prima luce nel 1894 come un servizio giornalistico per il Corriere di Napoli.
Era intenzione dell’autore, almeno all’inizio, limitarsi alle vicende del regno “al di qua del faro” (vale a dire la parte continentale). Nel corso delle successive verifiche, complice anche l’accesso all’archivio del generale Carlo Filangieri, lo sguardo si allargò anche alla Sicilia. E questo aspetto della consultazione di un archivio privato non è marginale: è segno invece della particolare direzione che De Cesare intendeva imprimere alla sua storia. Una narrazione non limitata alle grandi vicende politiche, ma spesso e volentieri anche al dietro le quinte, alle intime relazioni tra i personaggi, alle motivazioni personali e psicologiche delle loro decisioni. Non solo, molte pagine erano dedicate alla ricostruzione della vita quotidiana negli anni del regime borbonico, le riviste più in voga, gli avvenimenti culturali, le polemiche letterarie, i piccoli e grandi problemi cui andavano incontro le diverse fasce sociali nella Capitale e in provincia. C’è in questo un mal celato aspetto nostalgico. Nel parlare del mondo pre-unitario, De Cesare parlava in fondo, nel bene o nel male, della sua infanzia, e lo stesso valeva per gran parte dei suoi lettori.
Ma non c’era soltanto sterile nostalgia. In più occasioni De Cesare si lascia andare a delle considerazioni dalle quali traspare anche un certo rimpianto per degli aspetti positivi, ormai scomparsi del mondo andato. Nel capitolo V del secondo volume, per esempio, una volta tracciato un quadro sintetico della vita di provincia dell’epoca, esprime un commento che soltanto a una lettura superficiale potrebbe sembrare nostalgico o addirittura reazionario, e che rivela imparzialità e lucidità di analisi, tanto più in considerazione del liberalismo dell’autore:
Ecco in breve la vita delle provincie col suo male e col suo bene, come tutte le cose umane, ma che rispondeva ad una condizione sociale e morale, storica ed economica, che poteva venirsi modificando via via, ma che non era lecito mutare di punto in bianco. E la rivoluzione violentemente la mutò, nella sua parte esteriore, con un diritto pubblico, il quale non fu inteso altrimenti, che come reazione meccanica a tutto il passato. Il nuovo diritto non rifece l’uomo, anzi lo pervertì. La vecchia società si trovò come ubbriacata da una moltitudine di esigenze e pregiudizii nuovi, per cui ciascuno vedeva nel passato tutto il male e nelle così dette idee moderne tutto il bene, donde il bisogno di por mano a creare tante cose ad un tempo, utili e inutili.
E lo stesso ritratto di Ferdinando II, se rapportato a tante ricostruzioni che a seconda dei casi lo vedono ora come il monarca perfetto, ora come un mostro sanguinario, mostra un lodevole equilibrio: non ne nasconde i limiti, ma allo stesso tempo trova l’onestà di ammettere che sotto il profilo umano non fosse una persona disprezzabile.
Furono forse questi gli aspetti alla base del successo del libro. Il pubblico infatti gradì parecchio e ciò convinse l’autore a tornare più volte sulla sua opera, ormai destinata alla pubblicazione in volume, con continue aggiunte e limature che lo impegnarono fin quasi agli ultimi anni. A furia di aggiunte, raggiunse alla fine lo stato attuale: un poderoso saggio-fiume, talmente ricco di dettagli e digressioni da dare a volte l’impressione di non seguire un filo preciso, una narrazione che indaga il particolare fino a perdersi alle volte nell’aneddotica o nel pettegolezzo.
De Cesare, influenzato da alcune critiche positive, si convinse di essere il portatore di un nuovo modo di fare storia. Lo provano certe sue affermazioni dell’età matura, nelle quali rivendica con orgoglio di avere dato importanza a tanti particolari apparentemente minori con l’intento di opporre, alla storia convenzionale, una nuova forma di storia “democratica” e “sociale”.
Per certi aspetti, però, La fine di un regno, più che inaugurare un nuovo corso, sembra invece uno degli ultimi, tardivi colpi di coda di quella scienza, l’antiquaria, dedita alla ricostruzione minuziosa, a volte maniacale, di usi e costumi del passato; scienza che aveva conosciuto grande fortuna nell’ancient régime e che, in epoca contemporanea, era stata via via accantonata, con l’accusa di essere un mero esercizio di stile, a favore di una storiografia tutta concentrata sugli intrighi politici e diplomatici. Col risultato di ottenere, forse, uno squilibrio di segno opposto.
Ma sono proprio i difetti dell’opera quelli che, secondo noi, la rendono preziosa. Nello sconfinato numero della letteratura sul Regno delle Due Sicilie, che si tratti di autori simpatizzanti o avversari, si trovano fiumi di inchiostro sulle vicende politiche e sociali, sui moti insurrezionali e le repressioni del regime, sulle sfaccettature della politica interna ed estera; in pochi però si sono fermati a descrivere la vita quotidiana. De Cesare lo ha fatto, tramandando ai posteri l’affresco di un paese in cui, nonostante le mille contraddizioni, si viveva e si moriva, si producevano giornali e si andava a teatro, si spettegolava su grandi e piccoli scandali. Può forse dare l’idea di avere esagerato, quando si spinge a fornirci dettagli come il colore dei biglietti del treno. Ma anche questi particolari hanno una loro importanza, se appartengono a una fase storica sulla quale dopo il 1861 si è cercato di stendere un velo di oblio, come un passato imbarazzante e da rimuovere, un sistema politico e sociale definito “la negazione di Dio”, per usare le parole di lord Gladstone.
Inutile quindi pretendere dal De Cesare ciò che non era nelle sue corde. Il nostro non era né un antiborbonico sfrenato, che scrive usando la penna come una baionetta garibaldina, né un reazionario in lotta col proprio tempo, impegnato a svelare al mondo le malefatte dei suoi avversari. Per fare un paragone con un altro illustre storico delle Due Sicilie – fatte ovviamente le debite proporzioni – se Giacinto De Sivo è Tacito, Raffaele De Cesare è Svetonio.
Ammettiamolo: c’è bisogno di entrambi. È essenziale analizzare le motivazioni politiche, sociali ed economiche dietro le decisioni storiche prese dai grandi del passato nelle sale di rappresentanza; ma non è disprezzabile neppure andare a indagare cosa è accaduto di sera, quando il personaggio storico, lasciata la sala, si è andato a rifugiare nel suo appartamento privato. Un lavoro sporco, un lavoro – si dirà – da guardoni; ma, come si suol dire, qualcuno deve pur farlo.
Marcello Donativi