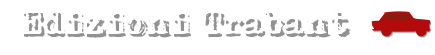Prefazione a
Diario di un imboscato – Attilio Frescura
«Questa guerra non è mica la guerra mia. La mia guerra è contro i pescicani imboscati figli di una vacca. E quelli non stanno mica soltanto in Germania o in Austria, stanno dappertutto. E io, bambino mio, di morire per loro non c’ho mica tanta voglia.» Diceva così Vittorio Gassman ad Alberto Sordi in una delle prime scene de La Grande Guerra, il capolavoro di Mario Monicelli sulla Prima Guerra Mondiale. Una spacconeria messa ancora più in evidenza dal fatto che i due, per il resto del film, non faranno altro che cercare di imboscarsi, salvo andare incontro a un’inaspettata morte eroica.
Un altro film, un’altra scena. Siamo circa alla metà di Uomini Contro di Francesco Rosi, liberamente tratto da Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu. I soldati italiani si ammutinano: sono stanchi di essere costretti a turni massacranti al fronte senza l’adeguato cambio, non tollerano più di essere costretti ad azioni suicide dalla miopia di ufficiali fanatici e impreparati. La rivolta si conclude, come prevedibile, con un nulla di fatto, e i responsabili sono fucilati in base alla più rigida legge marziale.
Qual è stata dunque la realtà della guerra italiana del ’15-’18? L’ironia dei contadini e degli artigiani in divisa, o il dramma di una intera generazione mandata a morire davanti alla mitragliatrice nemica? Probabilmente entrambe. D’altronde buona parte della storia d’Italia è a metà tra tragedia e commedia. E qui si arriva all’opera che presentiamo, un diario di guerra sempre in bilico tra il riso bonario e la smorfia amara. Mario Rigoni Stern, uno dei primi a riportarlo all’attenzione ormai alcune decine di anni fa, pur apprezzandolo rimproverava all’autore proprio il tono leggero, l’indulgere talvolta nella battuta da caserma.
Ma cosa si può pretendere da un imboscato, il quale per di più ammette di esserlo sin dalla copertina?
Imboscato: questa parola segna il titolo, da questa prende le mosse l’autore già dalla prefazione, da questa dobbiamo iniziare noi. Tecnicamente, imboscato è chi si adopera per sfuggire a un impegno gravoso. In gergo militare, può indicare chi fa di tutto per evitare la guerra – il raccomandato che si fa mandare in congedo, o assegnare in ufficio – o per estensione chiunque non abbia mai provato le durezze della prima linea. Diventa così l’antonomasia di chi manda gli altri a morire senza rischio per sé, il famoso nemico alle spalle di cui tanto sono pieni i racconti di guerra. Eppure, per Frescura l’imboscato è qualcosa di più, quasi una categoria dell’anima.
Le gradazioni dell’ “imboscato” sono infinite. Il combattente ha sempre qualcuno che è “imboscato” rispetto a sè, ed a sua volta è imboscato rispetto a qualche altro. La gradazione va dal soldato di pattuglia al “comandato al Ministero della guerra, in Roma” dove non arrivano nè i cannoni, nè la flotta, nè gli aeroplani.
Così avviene che il soldato di pattuglia, ritornando nella trincea, dice ai compagni che sono rimasti nel pericolo minore:
– Ah, siete qui, eh, “imboscati”?
E il termine lo aveva tanto colpito da tornare, a tratti, anche in altre sue opere. Nel romanzo Diciotto milioni di stelle, ad esempio, i soldati al fronte vedono passare dei colpi di cannone sopra le loro teste, diretti alle retrovie. Uno di loro commenta: «Sparano indietro. È per gli imboscati. È bene; un poco per uno, diamine…»
Da un certo punto di vista, Frescura poteva a buon diritto essere chiamato un imboscato. Figlio della borghesia veneta (il padre era un imprenditore del ramo ottico, fondatore di una delle prime fabbriche di occhiali nella sua zona), giornalista a Bologna, allo scoppio della Grande Guerra era tra quegli interventisti che mescolavano, sulla scia del futurismo, la fascinazione per l’arte a quella per il combattimento. Non l’aiutava però l’età: era della classe 1881 e fu pertanto assegnato, col grado di tenente, alle Milizie Territoriali, il ramo delle Forze Armate cui erano destinati i più anziani, raramente con compiti di prima linea, più spesso con incarichi nelle retrovie. Un ruolo tutt’altro che eroico, quantomeno nel pensiero comune: già nelle prime pagine si lamenta di “tanta gente fossilizzata nell’idea di questi territoriali messi unicamente a guardia di pacifiche strade e di imbelli ponti ferroviari”. Degli imboscati, appunto. Padri di famiglia, uomini non più di primo pelo presi in giro da chi va al fronte. Un corpo le cui stesse canzoni di battaglia non possono fare a meno di ricorrere all’autoironia.
Siamo ancora nelle prime fasi del conflitto e del diario di Frescura. Ci si può permettere di scherzare. L’autore inizia a parlare della guerra come una specie di scampagnata, di cui riporta anche gli episodi buffi: le due pattuglie italiane che si perdono e, scambiandosi l’un l’altra per il nemico, gridano entrambe in coro “mi arrendo!”; l’ufficiale che aiuta a cercare una presunta spia austriaca travestita da ufficiale italiano, prima di capire di essere egli stesso il sospettato. Frescura va anche a trovare Gabriele D’Annunzio, reduce da un volo propagandistico su Trento, e scambia con il poeta delle pompose affermazioni sulla Nazione, la “razza italiana” e l’utilità di quella guerra.
Basta un anno circa per far mutare tono al nostro autore. Tempo che l’orrore giunga anche dalle parti degli imboscati. In genere, a loro si manifesta sotto forma di paesi sventrati, civili in fuga, morti e feriti riportati dalle trincee. Già nell’agosto 1916, annota con sgomento di aver visionato le mazze di ferro che gli Austriaci usano per uccidere i nemici avvelenati dai gas: è stata da poco inventata la guerra batteriologica, ma all’utilizzo degli ultimi ritrovati della chimica si accoppia quello dei vecchi ritrovati medievali. Frescura discute con un generale se un simile strumento sia o no conforme alle leggi di guerra. Ma arriva a condannare tutti i mezzi, e aggiunge una sorprendente frecciata al nazionalismo:
Barbaro le mazze ferrate, barbaro i gas asfissianti. E barbaro anche il piombo che uccide e l’acciaio che dilania, sventra, mutila, stritola…
Ah! Se tutto questo è la Patria, è barbaro anche la concezione della Patria…
Passano i mesi e si spinge ancora più in là. Mentre il 1916 volge al termine, descrive la lunga teoria di soldati reduci dalla prima linea. È una giornata vittoriosa, gli italiani hanno conquistato una quota importante. Ma sono i feriti ad attirare l’attenzione del nostro testimone:
Ed ecco uno, che non dimenticherò più. È portato a spalle da un compagno a cui allaccia il collo. Il compagno gli regge le gambe con le sue braccia passate sotto i ginocchi. Vediamo la sua ferita oscena e ripugnante. Ha i pantaloni calati, il culo nudo, squarciato, tamponato alla meglio, tutto sporco di sangue.
Vorrei che chi ha voluto la guerra vedesse quel culo.
Dall’ineluttabilità della guerra all’amarezza verso chi l’ha invocata senza averla ben presente. Un passaggio niente male per un interventista. Ma le pagine più crude del libro appartengono probabilmente al Capitolo VII. Siamo ormai nella primavera del 1917, a breve avverrà il disastro di Caporetto. Già però si avvertono i segnali di esasperazione dei soldati. Un conoscente di Frescura, da civile un veterinario, è stato designato a giudice del Tribunale di guerra, un ruolo che ama poco in quanto, per usare le sue parole, ad fe’ fusilè d’ia gent, devi far fucilare le persone. Il nostro assiste ai processi, raccoglie le confidenze del giudice, annota i casi più eclatanti. Il risultato è scioccante: un lugubre elenco di tutte le mutilazioni e le infezioni a cui i fanti erano disposti a sottoporsi volontariamente pur di sfuggire all’orrore del combattimento: c’è chi usa aculei di robinie per procurarsi sulla pelle graffi simili ai segno della scabbia; chi si spalma sugli occhi sostanze chimiche per indurre la congiuntivite, o nelle orecchie per l’otite; chi arriva a spalmarsi o addirittura iniettarsi in varie parti del corpo degli escrementi nella speranza di avere delle infezioni. Questo per simulare la malattia. Altri si procurano finte ferite da combattimento: aspettano, per esempio, che scoppi nelle vicinanze una granata per provocarsi una mutilazione, una ferita, una frattura con quello che hanno a portata di mano. Il tribunale militare li passa uno ad uno, e macina condanne su condanne. In alcuni casi fucila.
Quanto a Frescura, ha appena il tempo di rendersi conto di avere raggiunto i due anni di guerra, e ricordare con stupore di quando, da civile, la invocava in pubblico, che viene destinato a un altro incarico: censurare le lettere dei soldati cancellando ogni riferimento agli aspetti sanguinosi del conflitto:
È destino, adunque, che io debba vedere tutta la bruttura, tutta la somma di miserie di questa povera umanità dolorante? E noi, imboscati per eccellenza, dobbiamo inesorabilmente cancellare ogni frase che dica, per esempio, che la guerra non è bella!
Intendiamoci: tutto questo non fece mai di Frescura un antimilitarista. Anzi, è forse proprio questa ambiguità di fondo a rendere interessante l’opera, il contrasto tra la vocazione interventista dell’autore e la sua onestà nel sottolineare senza pudori quanto di intollerabile egli trovi nella guerra. I fatti nudi e crudi dicono che alla fine del conflitto si era guadagnato due medaglie al valore e due croci di guerra, oltre alla promozione al grado di capitano. Segni inequivocabili della dedizione da lui dimostrata, nonostante tutto, nel suo compito, e del fatto che essere dei buoni combattenti non significa, per questo, amare la guerra. D’altra parte, non era forse il Duca di Wellington a dire «Dopo una battaglia perduta, la più grande iattura umana è una battaglia vinta»?
Pubblicato per la prima volta nel 1918, il Diario di un imboscato andò incontro a un largo successo di pubblico, tanto da guadagnarsi tre ristampe negli anni successivi. A ciò contribuirono le polemiche suscitate dai giudizi tagliati con l’accetta presenti nel libro; tuttavia, nelle successive edizioni, l’autore cercò di purgarla delle parti più apertamente polemiche. Ma anche in questo modo essa conservò la sua vena sarcastica e anti-eroica. Quanto all’autore, proseguì nella sua attività di giornalista e tentò altre volte la via della narrativa, pur senza raggiungere il successo del suo diario di guerra; opere a cui vanno aggiunti alcuni romanzi d’avventura, sulla falsariga di Salgari, pubblicati sotto il fantasioso pseudonimo del capitano Ph. Escurial. Nel complesso, una onesta carriera letteraria che non lo portò, però, più a replicare il livello qualitativo del debutto.
All’indomani della pubblicazione del romanzo Diciotto milioni di stelle, fornì il seguente ritratto autobiografico alla rivista L’Italia che scrive:
Quando ho buttato il mio Diario di un imboscato tra la carta dei botoletti ringhiosi un mio amico – di quelli che si fanno improvvisamente vivi per mandarvi le condoglianze per un lutto – mi ha scritto: « conosci quel tuo omonimo che ha scritto il Diario di un imboscato? È un tuo parente?» Ho risposto che lo conosco pochissimo, dato che nessuno conosce sé stesso.
Ma la domanda del mio vecchio amico – sollecito a tutte le condoglianze – non mi ha stupito, perché tutto ci si poteva aspettare da me, fuorché un libro.
Mi spiego:
Ho cominciato nel milleottocento… Be’: lasciamo stare le date; sono i fatti che contano, non i numeri. Ho cominciato a sedici anni a dirigere un giornale letterario che arrivò al suo quarto numero, formò la delizia di Enrico Mercatalli, allora direttore dell’Unione di Bergamo, che mi coprì di ridicolo e mi scoprì giornalista. Feci della cronaca, della letteratura, poi il soldato, ancora della letteratura e molte altre cose punto letterarie… E non sono neanche cavaliere!
Ho fatto la guerra, ho scritto la mia guerra e rifaccio il giornalista.
Il mio vecchio amico, che non mi aveva ancora conosciuto nel milleottocento… (lasciamo le date: sono i fatti che contano) ha avuto ragione di chiedermi se conoscevo l’autore del Diario di un imboscato.
Il quale è arrivato alla sua seconda edizione. Nella nuova ho inesorabilmente soppresso tutte le pagine polemiche, per farne un’opera più storica che polemica. E per dire meno male che mi è possibile del prossimo.
Il libro già si incammina per la terza edizione. Figliolo irrequieto di un padre dinamico, il robustino ha cambiato editore: il Galla di Vicenza – un galantuomo editore – mi ha ceduto all’Oberosler di Bologna – un editore galantuomo – a un prezzo che fa concorrenza a Guido da Verona.
Mi ha ceduto in arme e bagaglio: nel bagaglio ci sono Diciotto milioni di stelle. Un romanzo. L’editore Obersosler spera di farne altrettanti, dei milioni.
Io, fra quei diciotto milioni di stelle, cerco la mia.
«Figliuolo irrequieto di un padre dinamico»: c’è tutto Attilio Frescura in questa definizione allo stesso tempo leggera e sarcastica. E noi oggi, nel centenario dell’intervento dell’Italia nella Grande Guerra, siamo più che lieti di riproporre al pubblico il suo robustino.
Marcello Donativi